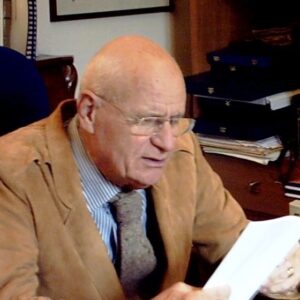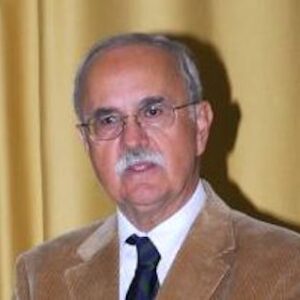Piero Filippetto e Lanfranco Zancan, due padovani a Milano tra il 1943 e il 1945
Furono due protagonisti attivi e coraggiosi della Resistenza contro il nazifascismo
Il padovano padre Piero Filippetto s.j., dai primi mesi del 1943, insegna storia e filosofia al liceo classico dell’Istituto Leone XIII, scuola della Compagnia di Gesù di Milano.
Ma il 1943 è un anno difficile e burrascoso nella città lombarda, come del resto in tutta l’Italia. Infatti, dopo l’invasione anglo-americana del 9 luglio in Sicilia, iniziano i distruttivi bombardamenti degli alleati a Roma, il 19 luglio, poi anche a Milano, l’8 il 13 e il 15 agosto, con centinaia di morti. In tale contesto, il 25 luglio 1943, al Gran Consiglio, Dino Grandi presenta l’ordine del giorno che provoca la fine della dittatura fascista con l’arresto di Mussolini. La firma poi dell’armistizio a Cassibile, l’8 settembre, porta a una situazione caotica con lo sfaldamento dell’esercito italiano. Mussolini dopo un breve periodo di detenzione, il 12 settembre, è liberato dai tedeschi, condotto in Germania e posto a capo della Repubblica Sociale Italiana, che inizia la sua attività di governo fantoccio nell’alta Italia. Il 13 settembre, con l’insediamento all’hotel Regina di Milano della Gestapo, inizia la caccia agli ebrei e agli antifascisti. Vengono ricostituiti tutti gli organi del Partito Nazionale Fascista, messe in vigore le leggi razziali del 1938 e ora, sotto il controllo tedesco, rigidamente applicate. In un palazzo milanese di via Rovello, oggi sede del Piccolo Teatro, si insedia come in ogni città occupata dai tedeschi una squadra d’azione, chiamata Ettore Muti, formata da fascisti di provata fede e vari gruppi di detenuti comuni provenienti dal carcere di San Vittore. La Muti, come del resto la Banda Carità di Padova, rivelò una decisa tendenza a sostituirsi agli organi di polizia, spinta anche dall’appoggio tedesco, per una feroce repressione anti partigiana, contro i renitenti alla leva, gli ebrei, i ricercati politici e i prigionieri di guerra alleati liberati dai campi di prigionia dopo la dichiarazione dell’armistizio. Tutti cercavano di raggiungere da Milano la libertà in Svizzera, prima che la situazione diventasse più grave.
Padre Filippetto si trova ad operare in questo difficile contesto e, pur insegnando in un luogo protetto come l’Istituto Leone XIII, inizia ad avere rapporti con il mondo esterno. Frequenta don Andrea Ghetti, pure lui insegnante di storia e filosofia presso il Collegio San Carlo di Milano e assistente della Fuci, Federazione Universitaria Cattolica Italiana, e Giulio Cesare Uccellini, detto Kelly, figura di primo piano nello scoutismo e della resistenza, con i quali costituisce un’associazione clandestina, con l’approvazione del cardinale Ildefonso Schuster, dal nome Opera scautistica cattolica aiuto ai ricercati (con l’acronimo Oscar). La loro missione era falsificare i documenti per aiutare ebrei ricercati, alleati fuggiaschi, uomini della resistenza, giovani renitenti alla leva, avversari politici a fuggire in Svizzera attraverso la frontiera del varesotto. Padre Filippetto, nell’organizzazione segreta, conosce anche altri sacerdoti come don Aurelio Giussani, don Angelo Motta, don Giovanni Barbareschi e Carlo Bianchi presidente della Fuci di Milano, che diventeranno compagni di lotta. Gli appartenenti all’Oscar dalla sua costituzione fino alla fine del 1944, pur agendo in segreto e con uno spirito di puro volontariato, riuscirono ad assistere 2200 espatri e compilarono 3000 documenti falsi.
A proposito di uomini della resistenza padre Piero, all’inizio del 1945, è al centro di un episodio storico. I tedeschi, il 10 settembre 1943, occupano Padova e tutto il Veneto: si consolida allora un fermento di collaborazione tra tutti i partiti antifascisti, la popolazione e il clero che, uniti, cercano di contrastare sia l’esercito hitleriano sia i fascisti della Repubblica Sociale loro alleati. Si forma il Comitato di Liberazione Nazionale regionale veneto con Concetto Marchesi, Egidio Meneghetti, Mario Saggin, Alessandro Candido, Lanfranco Zancan. A Padova, tra gli altri, i due luoghi dove maggiormente si svolge l’attività di contrasto sono l’università e l’Antonianum. Infatti per tutto il periodo della resistenza, fino alla Liberazione, il collegio dei gesuiti è il luogo dove vengono preparati i volantini, stampati i giornaletti, compilati i lasciapassare e le carte di identità false e si nascondono alcuni protagonisti della resistenza veneta come Otello Peghin, Egidio Meneghetti, Corrado Lubian e Lanfranco Zancan. Questo rifugio è una spina nel fianco delle forze occupanti, tanto che per ben due volte il collegio è sottoposto a controlli e a perquisizioni da parte della Banda Carità, con sede a Palazzo Giusti nella città del Santo. Il comandante Mario Carità dirige la famigerata organizzazione criminale con gli stessi metodi della Ettore Muti di Milano. Vengono imprigionati e torturati alcuni resistenti veneti arrestati tra la fine del 1944 e l’inizio del 1945.
Lanfranco Zancan è invece riuscito a sfuggire all’arresto e a rifugiarsi in una stanza attigua alla stalla dell’Antonianum. Il rettore del collegio gesuitico padre Carlo Messori Roncaglia s.j., avuto sentore di un possibile arresto, lo invita ad abbandonare al più presto quel nascondiglio nel collegio, in quanto c’è l’ordine di sparare a vista.
Zancan decide allora di lasciare immediatamente Padova in bicicletta e portarsi a Milano, per mettersi agli ordini del generale Cadorna. Prima di partire, però, vuole incontrare Marcello Olivi, il giovane volontario della libertà proveniente dal Cansiglio. Egli doveva prendere il suo posto nel Comitato di Liberazione Nazionale ed era nascosto a casa dei genitori di padre Piero Filippetto. Con quest’ultimo lo Zancan si metterà in contatto una volta giunto a Milano. Ecco la breve storia di questo episodio, descritto dallo stesso Zancan in una riunione del Rotary Club di Padova tenuta il 26 aprile 1983 alle Padovanelle:
Epifania del 1945. Passeggio tranquillo nel posto più bello della mia Padova, tra gli alberi dell’Orto Botanico. Accanto le cupole del Santo, più oltre si stagliano le cupole di Santa Giustina. Una stanza, che comunica con una stalla: aiuto “Maria la piccola” ad alimentare e mungere qualche vacca. I buoni padri della Compagnia di Gesù debbono pur continuare a vivere.
Nel cuore della notte, improvvisamente, la porta si spalanca: avvolto nel mantello nero, due occhi di bragia, mi appare padre Carlo Messori. “Tuo fratello Giorgio, Ponti e Meneghetti sono sotto tortura: fino a questo momento non hanno parlato. C’è di più. Tuo fratello Giorgio, che tanto ti assomiglia nella taglia e nel modo di camminare, ha dovuto passare e ripassare di fronte alle SS di Palazzo Giusti. C’è l’ordine di spararti a vista. Domani all’alba devi lasciare l’Antonianum”.
Comprendo. Penso a mio fratello Giorgio, a Meneghetti, a Ponti: non ho dubbi. “Nella tortura serra le nostre labbra. Spezzaci, non lasciarci piegare”. Penso a Maria e ai miei due bambini. Sono al sicuro nelle ampie distese di terra strappate alla malaria dai nostri vecchi. Li raggiungerò. “Signore, rendi nel dolore all’Italia una vita generosa e severa. Liberaci dalla tentazione degli affetti: veglia sulle nostre famiglie”.
Padre Messori attende silenzioso. “Ho deciso: lascio Padova con la mia bicicletta. Chiedo di incontrarmi prima con chi prenderà il mio posto. Chiedo, una volta a Milano, di essere agli ordini del generale Cadorna”. A pochi passi dall’Antonianum, la casa dei Filippetto, vecchi amici di tutta la mia famiglia. Qui l’incontro indimenticabile con un giovane volontario della libertà, sceso dal Cansiglio. Di lui ricordo soltanto due occhi da galantuomo: era Marcello Olivi.
Qualche giorno dopo a Milano al Leone XIII, accolto affettuosamente da padre Piero Filippetto della Compagnia di Gesù. Mi diede un indirizzo: Paolo Pellizzola, via Gallina 14. In questa famiglia rimasi fino al 29 aprile 1945. Stupenda la prima impressione di questa casa: in stile floreale, per una sola famiglia, con annessa officina per minuterie metalliche, confinante muro a muro con un comando tedesco.
Paolo Pellizzola, un uomo sui cinquant’anni, mi ha fatto capire il valore del lavoro in Milano. Era legato ai Fratelli Branca ed aveva fatto una fortuna inventando quel maledetto tappo, che ancor oggi mi impegna ogni volta che prendo un Fernet-Branca. La madre veronese, più ermetica del famoso tappo nel non mollare la figlia ventenne, la Pepe, anche se innamorata di un ebreo, che in quei giorni era certamente errante! Ho tenuto per voi tre grani di Pepe.
“Come ti trovi nel letto che ogni mattina la mamma ti rifà con tanto amore?”
“Benissimo!”
“Si trovava benissimo anche Luigi, uno studente di ingegneria, venuto prima di te e mandato pure da padre Filippetto: ieri è stato fucilato dai tedeschi sul Lago Maggiore. Domani tu ti alzi per tempo e te ne stai lontano da casa nostra tutto il giorno”.
“Perché?”
“Vengono da noi due avanzi di galera, che hanno bisogno di parlare tra di loro tranquilli: Parri e Cadorna”.
Memorabile quel 24 aprile: radio Londra incalzava con le notizie. Trovai il padre che stava aprendo una bottiglia di Champagne autentico, patriotticamente sottratta ai tedeschi che se ne andavano; doverosamente sottratta agli inglesi che venivano. Questa generosa famiglia di italiani alzò affettuosamente le coppe verso di me: e Pepe infranse la sua ai miei piedi, senza un perché. Ieri sera le ho telefonato: “Parla pure ai tuoi Rotariani della ‘bella bionda che ti rammendava i calzini’”!
Nei tre mesi a Milano conobbi tre uomini, che restarono miei amici nell’arco intero della vita. Achille Marazza, membro effettivo per la Democrazia Cristiana nel Comitato di Liberazione Alta Italia, tante volte ministro della Repubblica Italiana. Mario Ferrari Aggradi, anche lui tante volte ministro della Repubblica Italiana. Ma in quei tre mesi, fidanzato a Venezia, fu un tramite meraviglioso di notizie tra mia moglie e me.
Il terzo desidero farvelo conoscere alla luce che mi apparve allora. Era un uomo con tanti anni più di me, alto e distinto, con due baffoni asburgici. Poi abbiamo vissuto oltre un ventennio assieme, d’accordo in tutto e per tutto. Anche in quei tre mesi fummo sempre d’accordo. Camminavamo a lungo assieme per Milano. Tra l’altro un giorno mi raccontò che nella guerra 1915-1918, essendo trentino, aveva combattuto sul fronte orientale ed era stato decorato di medaglia d’oro al valore militare sul campo. Eravamo ormai in aprile e camminando io gli esprimevo la mia preoccupazione sull’avanzata degli slavi verso Trieste. Mi disse: “Mio fratello ha avuto assicurazione dagli Alleati che Trieste resta all’Italia”. “Ma tuo fratello chi è?” “Il ministro degli esteri del Governo Bonomi: Alcide De Gasperi”.
E vengo al 25 aprile 1945. Augusto De Gasperi mi telefona: il Comitato di Liberazione Alta Italia ha affidato ad Achille Marazza il compito di trattare la resa di Mussolini e di Graziani al Palazzo dell’Arcivescovado, alla presenza del cardinale Schuster.
Appuntamento nella piazza vicina all’Arcivescovado. Augusto De Gasperi aggiunge che Achille Marazza desidera averci vicino il più possibile, per quanto lo consentiranno le circostanze. Mi avvio sollecito verso Piazza del Duomo. E mi ritorna in quei momenti, come una visione fuggevole, un episodio lontano e vicino della mia vita, sperduto nel tempo che passa. Qualche giorno prima di quel 16 dicembre 1943 salivo la scala dell’Istituto di Farmacologia, che porta al primo piano. Nell’arco di sopra si staglia il volto in lagrime di Maria Meneghetti. Mi dona un libro, che non ho mai più letto: I cuori puri. Porta impresso l’ex libris di Egidio Meneghetti: semper cum victis, numquam victus. Egidio Meneghetti è nel campo di concentramento di Bolzano; Giovanni Ponti è a Palazzo Giusti: il destino vuole che tocchi a me essere interprete della volontà della Resistenza delle genti venete.
In quel pomeriggio livido, in una Milano quasi deserta, mentre adepti delle più diverse polizie si muovevano in borghese, pistole alla mano, tre uomini si avviavano frettolosi verso il Palazzo dell’Arcivescovado, circondato da ogni parte da moschettieri del Duce con baionette innestate e spianate. Sono Achille Marazza, Augusto De Gasperi, Lanfranco Zancan. Considerano entro quali limiti e in quali forme la resa da Mussolini possa essere accettata ad evitare ulteriore spargimento di sangue. Poi Achille Marazza, da solo, avendo con sé l’Italia, scompare oltre il portone dell’Arcivescovado.
Più tardi ero ai piedi dello scalone dell’Arcivescovado. Vidi scendere Mussolini con Graziani. Un uomo prestante saliva rapido lo scalone. Riconosciuto evidentemente Mussolini, puntò l’indice e gridò chiaramente: “Ti deferiremo ai tribunali del popolo”.
Graziani morì sul proprio letto, Mussolini nella maniera che gli italiani non dimenticano. Marazza, Zancan e De Gasperi non ebbero mai dubbi del perché. Non è vero che il Comitato di Liberazione Alta Italia abbia autorizzato chicchessia a scannare Mussolini in quella maniera. È vero soltanto (e Marazza me lo testimoniò subito in quelle ore) che il Comitato di Liberazione Alta Italia ritenne opportuno, per ragione politica, coprire quel delitto.
Quel mattino avevo il bracciale tricolore del Comitato di Liberazione Alta Italia e in tasca una tessera che per dieci giorni mi diede poteri straordinari. Uscivo di casa, in via Gallina, e un operaio mi affrontò: “L’è lu; l’è là”. “È lui; è là”. E il suo sguardo si volgeva verso Piazzale Loreto. Poco dopo ero in Prefettura: chiesi ed ottenni cristiana sepoltura per Clara Petacci e Benito Mussolini. Ad un medico, il Cattabeni, che nel passare degli anni fu il professore di medicina legale e il Rettore magnifico della Università di Milano, diedi l’ordine di procedere al riconoscimento ed eventualmente all’autopsia della salma di Mussolini. A poche ore di distanza mi riferì. Era certamente Mussolini; non aveva lividi da percosse. I visceri rivelavano pienezza di salute fisica. Non esisteva l’ulcera duodenale, di cui parlò tutta Italia.
In quelle ore entrai alla Caproni, dove operava un tribunale del Popolo. D’autorità sottrassi alla morte una giovane maestrina, certamente innocente. Da quel momento, e fino alla mia bocciatura per la Costituente, girai le contrade d’Italia, nell’intento di spezzare subito, in sul nascere, la spirale dell’odio.