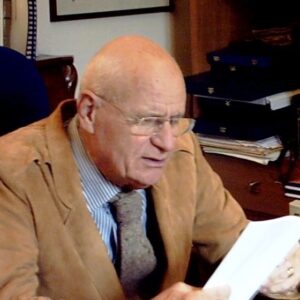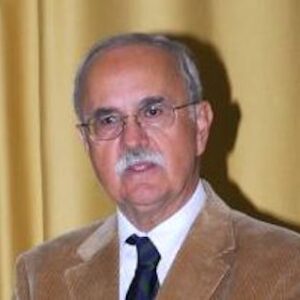Dal Veneto al Brasile: la missione sociale di padre Umberto Pietrogrande
Una vocazione che lo ha portato ad essere guida spirituale, manager, educatore innovativo
Il 5 agosto 2015, nel Piauí, uno degli stati più poveri del Brasile, si spegneva padre Umberto Pietrogrande, gesuita d’origine veneta che per oltre mezzo secolo ha operato tra le aree rurali e le periferie urbane del Brasile, promuovendo sviluppo umano, accesso all’istruzione, sanità di base e solidarietà comunitaria. Il lutto proclamato da autorità civili ed ecclesiastiche in Brasile e, seppur con minor risonanza, talvolta anche in Italia, testimoniava il segno lasciato dalla sua azione. Un’azione condotta con una sorprendente capacità progettuale e organizzativa.
Nato a Padova nel 1930 in una famiglia numerosa (undici tra fratelli e sorelle) e benestante, figlio di Elisa Romaro e dell’avvocato antifascista Rinaldo Pietrogrande, Umberto crebbe in un ambiente fortemente impregnato di valori civili e cristiani. Il padre faceva parte della cerchia del vescovo Luigi Pellizzo ed era un militante della prima ora del Partito popolare di don Luigi Sturzo, con cui risultò primo dei non eletti in Veneto alle elezioni del 1919 e secondo a quelle del 1921, negli stessi anni in cui la politica locale aveva quali protagonisti figure del calibro dei compagni di partito Sebastiano Schiavon e Umberto Merlin e del socialista Giacomo Matteotti, barbaramente assassinato dai fascisti nel 1924. Lo stesso Rinaldo verrà più volte picchiato e minacciato per il suo impegno politico, ecclesiale e sociale nel territorio. L’esempio paterno, insieme alla forte devozione della madre, accesero in Umberto l’idea che la fede non potesse essere disgiunta dall’azione concreta. Una convinzione che avrebbe orientato le sue scelte future: «la mia vocazione sacerdotale e missionaria affonda la sua origine e la sua giustificazione nell’educazione famigliare che ho ricevuto» [U. Pietrogrande, Lettera ai parenti, 7 maggio 2002, Socopo].
Nel dopoguerra, Umberto è un giovane attivo nella Fuci (Federazione universitaria cattolica italiana), nella Democrazia cristiana e soprattutto nell’Azione cattolica, di cui presiede il ramo giovanile (Giac, Gioventù italiana di azione cattolica) diocesano e poi regionale. Dopo la laurea in giurisprudenza all’Università di Padova e un promettente inizio di carriera legale nello studio dell’illustre avvocato Cesare Crescente (sindaco di Padova), tuttavia, Umberto stupisce tutti entrando nel noviziato di Lonigo della Compagnia di Gesù. Non ancora ordinato sacerdote, venne inviato come missionario in Brasile. Era il 1961, e la sua obbedienza al superiore che lo spediva oltreoceano fu anche l’inizio di una delle prime avventure della cooperazione internazionale italiana.
Padre Umberto si insediò dapprima nello Stato dell’Espírito Santo, una regione rurale afflitta da povertà cronica, assenza di infrastrutture, emigrazione giovanile. Anziché limitarsi all’attività pastorale, il gesuita veneto scelse di affrontare le cause strutturali del disagio sociale in cui era chiamato a operare: la mancanza di educazione, la frammentazione familiare, l’assenza di servizi sanitari, la rassegnazione. Con straordinaria capacità organizzativa, intuì che la risposta doveva essere sistemica, integrata, innovativa. Fu così che, ispirandosi al modello delle “Maison familiales rurales” francesi e grazie all’intermediazione dell’Istituto agrario di Castelfranco Veneto, padre Umberto diede vita al Mepes (Movimento de educação promocional do Espírito Santo), uno dei progetti più importanti nella storia educativa del Brasile contemporaneo.
Le “Escolas famílias agrícolas” (Efas), fondate nel 1968, offrivano un’alternanza tra scuola e lavoro in famiglia, favorendo la permanenza dei giovani nelle aree rurali e promuovendo allo stesso tempo competenze tecniche e crescita comunitaria. Non si trattava solo di educazione: le scuole erano pensate come catalizzatori di sviluppo umano integrale. Da esse nacquero asili, dispensari sanitari, centri di formazione professionale, ospedali. E soprattutto, si formò attorno a padre Umberto una rete capillare di collaboratori brasiliani e italiani, sostenuta dall’Aes-ccc (Associazione degli amici dello Stato brasiliano dell’Espírito Santo), una delle prime ONG italiane operanti nel Sud globale, attiva ancora oggi. La sua opera fu tanto efficace quanto coraggiosa. In piena dittatura militare, riuscì a creare alternative reali all’esclusione sociale. Fu interrogato, sorvegliato, persino temporaneamente incarcerato, ma mai messo in condizione di dover interrompere la propria azione. Merito anche della sua formazione giuridica, che gli consentì di muoversi con competenza in contesti complessi, tutelando le persone e le istituzioni che aveva creato.
Nel 1984 una nuova chiamata: il suo superiore lo destinò al Piauí, uno degli stati più poveri del Brasile. Umberto obbedì, lasciando il Mepes ma non il metodo. A Teresina, nel bairro popolare di Socopo, riorganizzò l’intero tessuto educativo, sanitario ed economico della zona. Fondò la Funaci (Fundação padre Antonio Dante Civiero), diede vita a nuove scuole famiglia, creò centri sanitari e l’ospedale San Carlo Borromeo, oggi punto di riferimento in tutto il Piauí. Promosse comunità agricole collettive, imprese rurali, collaborazioni internazionali con università italiane e con la Fao. Nel 1996 inaugurò la “Fazenda nova esperança”, una vera e propria incubatrice di innovazione agroalimentare e sociale.
Padre Umberto Pietrogrande non fu mai un teorico. Non scrisse trattati sulla pedagogia dell’alternanza (metodologia da lui portata in Brasile, che consisteva nel concordare con le famiglie più povere di alternare i giorni a scuola con dei giorni al lavoro per i ragazzi), né si presentò esplicitamente come un teologo della liberazione. Eppure, incarnò appieno lo spirito della Populorum progressio di papa Paolo VI, che egli chiamava la sua “stella polare”. E fu proprio nella combinazione tra fede e giustizia, tra contemplazione e azione, tra idealismo evangelico e pragmatismo gestionale, che trovò la propria cifra. La sua spiritualità, profondamente ignaziana, si rifletteva nella formula che spesso ripeteva: “fa tutto come se dipendesse da te, aspetta tutto come se dipendesse da Dio”. Negli ultimi anni di vita si ritirò in una casa di preghiera da lui chiamata “Golgota”, da dove continuò a far sentire la sua presenza e il suo sostegno alla comunità.
Molti videro in lui una guida spirituale, altri un manager capace, altri ancora un educatore innovativo. Di certo seppe mettere insieme la dimensione spirituale, l’impegno civile, e la concretezza “imprenditoriale” dell’azione. Con la naturalezza e la forza di chi, scegliendo il sacerdozio e vivendolo dall’altro capo del mondo, non ha mai perduto il legame alle radici profonde del proprio impegno, che stavano nella famiglia e nel contesto veneto del cattolicesimo sociale da cui proveniva.
Molti sono i riconoscimenti che sono stati tributati a padre Umberto (o Humberto, come è stato rinominato in Brasile): cittadinanze onorarie, premi missionari, omaggi pubblici. Il giorno del suo funerale, nel 2015, migliaia di persone hanno affollato la chiesa di Teresina: autorità civili, politici, educatori, contadini, studenti. Il Parlamento di Brasilia gli rese un tributo ufficiale. Le comunità di Anchieta e Teresina proclamarono tre giorni di lutto e oggi una delle arterie principali di quest’ultima città gli è dedicata: Avenida Padre Humberto Pietrogrande.
Non stupisce. Perché in padre Pietrogrande non c’era solo una vocazione, ma una visione. E una capacità organizzativa impressionante, che si tradusse in reti, strutture, metodi capaci di durare ben oltre la sua vita. Seppe trasformare l’ispirazione evangelica in azione concreta. Seppe, nel solco della sua formazione nell’Azione cattolica, vedere le necessità, giudicarle con rigore e compassione, e infine agire. Sempre con una luce accesa, come quella che faceva brillare ogni sera sulla croce della sua chiesa, affinché tutti sapessero che stava pregando per loro.


Bibliografia:
- L. Billanovich, Luigi Pellizzo Vescovo a Padova (1907-1923), Il Poligrafo, 2014.
- E. Cracco, Intreccio di una storia: padre Umberto Pietrogrande e la vita di Mepes, Aes, Funaci, Padova, 2015, pp. 1-27.
- C. Grossoni, Andare: perché? Esperienze di cooperazione tra i popoli, Publycom, Vercelli, 2016.
- G. Ghedini, «Umberto Pietrogrande: il gesuita che costruiva ponti», Visioni LatinoAmericane, Edizioni Università di Trieste, Anno VIII, Numero 15, luglio 2016, pp. 50-69.
- G. Ghedini, «Sociologia promozionale e cooperazione internazionale Italia-Brasile. Il contributo di Giuliano Giorio», Visioni LatinoAmericane, Edizioni Università di Trieste, Anno XI, Numero 20, gennaio 2019, pp. 21-37.
- G. Ghedini, E. Pietrogrande, A. Ramin (a cura di), Corrispondenza tra padre Umberto Pietrogrande e prof Giuliano Giorio. Fonte: Archivio Storico Famiglia Giorio, 2022.
- U. Pietrogrande, Una progettualità a tutto campo, in Lazzari F. e Merler A. (ed.), La sociologia delle solidarietà: scritti in onore di Giuliano Giorio, FrancoAngeli, Milano, 2003.
- G. Romanato, Giacomo Matteotti. Un italiano diverso, Milano, Bompiani, 2024.
- G. Salice, Intervista a padre Umberto Pietrogrande di Grazia Salice, «Magis», n.48, marzo 2006, pp. 27-32.
- M. Silva, Padre Humberto Pietrogrande: 50 anos de missão no Brasil, Grafica e Editora Alternativa, Vitòria, 2012.
- M. Toffanin, Sebastiano Schiavon: lo “strapazzasiori”, Padova, La Garangola, 2005.
Giacomo Ghedini è Ricercatore presso l’Istituto Storico Italo-Germanico della Fondazione Bruno Kessler (Trento).