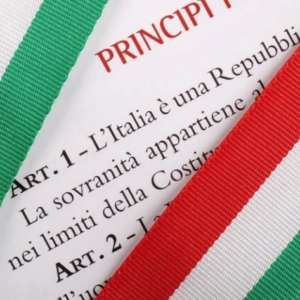La detenzione preliminare
Prosegue l’esame del nostro sistema giuridico e penitenziario
La forma di detenzione in attesa del processo – pertanto quando il detenuto è ancora innocente – è la custodia cautelare in carcere.
Per tale misura cautelare coercitiva è dedicata un’apposita struttura detta Casa circondariale.
In essa sono detenute, oltre alle persone in attesa di giudizio, quelle che sono già state condannate a pene inferiori a cinque anni o con un residuo di pena inferiore ai cinque anni.
Nella pratica, tuttavia, le Case circondariali sono abitate per lo più da queste ultime due categorie, con conseguenti problemi di percezione per i reclusi in attesa di giudizio (quindi ancora innocenti) e di rapporti tra i detenuti.
A disciplinare la Casa circondariale sono gli artt. 59, 60 e 61 della Legge 354/1975 sull’Ordinamento penitenziario e gli artt. 110 e 115 del D.P.R. n. 230 del 30.06.2000 Regolamento sull’Ordinamento penitenziario.
Soprattutto all’interno di quest’ultimo Regolamento si possono leggere una lunga serie di norme rigide che disciplinano la vita detentiva.
Ma perché si finisce anticipatamente reclusi in una Casa circondariale?
Valgono, per essa, i medesimi criteri previsti per le altre misure cautelari personali, ovvero le esigenze previste all’art. 247 del codice di procedura penale.
Sinteticamente, esse sono tre: 1) il rischio che l’indagato inquini le prove o le distrugga; 2) il rischio che l’indagato si dia alla fuga; 3) il rischio che l’indagato commetta nuovi e gravi delitti della stessa specie o con l’uso delle armi.
Tuttavia, non per tutti i delitti è prevista la possibilità della custodia cautelare in carcere, ma soltanto per quelli che prevedono una pena edittale superiore nel massimo a cinque anni di reclusione, pena determinata senza l’applicazione astratta di alcuna circostanza aggravante o attenuante, fatta eccezione per l’aggravante della minorata difesa e per l’attenuante della speciale tenuità per i delitti contro il patrimonio.
In ogni caso, la scelta del carcere dev’essere sempre l’extrema ratio. Invero, ai sensi dell’art. 275 del codice di procedura penale, la detenzione è disposta quando è ritenuta inidonea l’applicazione di tutte le altre misure cautelari messe insieme. Inoltre, la custodia in carcere è sempre esclusa se, sotto un profilo prospettico, si ritiene che il giudice del processo, ricorrendone i presupposti, concederà la sospensione condizionale della pena o non applicherà una pena superiore a tre anni (eccetto che per alcuni gravi reati).
La misura custodiale è disposta dal Giudice procedente su domanda del Pubblico Ministero, Giudice che, nella stragrande maggioranza dei casi, è il giudice delle indagini preliminari.
Al 31 luglio 2024, secondo la relazione periodica al Parlamento del Ministero della Giustizia ai sensi della legge 47/2015, i detenuti presenti nelle carceri italiane sono 61.133, a fronte di una capienza regolamentare di 51.207 posti.
I detenuti in custodia cautelare sono il 25% del totale, pari a 15.285. Di questi 8.934 (54%) sono in attesa del primo grado giudizio mentre 6.251 sono in appello o ricorrenti in Cassazione
Il 33% di coloro che si trovano in custodia cautelare carcere sono stranieri, ovvero 5.934.
Concludiamo questa disamina teorica sul carcere, prima di vedere come nel concreto funzionano le carceri, con un istituto giuridico del tutto particolare: la latitanza.
Esso è disciplinato dall’art. 296 del codice di procedura penale. È latitante colui che si sottrae – volontariamente – alla custodia cautelare, agli arresti domiciliari, al divieto di espatrio, all’obbligo di dimora (c.d. latitanza “processuale”) o un ordine con cui si dispone la carcerazione in seguito a una condanna (c.d. latitanza “esecutiva”).
Lo status di latitante viene dichiarato sulla scorta del verbale di vane ricerche redatto dalla polizia giudiziaria a seguito della ricerca della persona.
A dichiarare la latitanza è il giudice procedente, a cui il Pubblico Ministero trasmette l’incartamento. Se ad essere applicata è la misura della custodia cautelare in carcere, il giudice deve dare atto nel provvedimento che l’indagato era a effettiva conoscenza dell’emissione della misura.