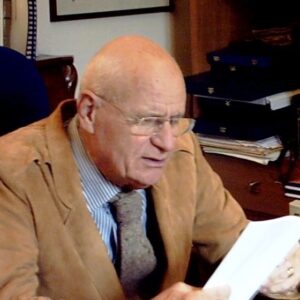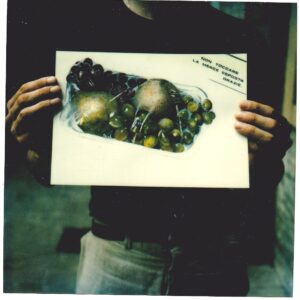Letteratura femminile, forma iniziale del sapere
Da tabù negli scorsi secoli a fenomeno editoriale del Novecento
È ormai opinione consolidata che nel corso dei secoli la donna si è vista negare non solo la possibilità di espressione tecnico-scientifica, ma anche quella artistico- letteraria, più confacente alla sua creatività. Chi ha osato infrangere il tabù, ha dovuto superare ostacoli che il sesso forte – forte nella misura in cui occupa il potere – non ha mai conosciuto. Questo perché, esprimere o nominare il mondo al femminile, implica comunque parlare di linguaggio e di sapere, considerata l’intima relazione e il reciproco condizionamento che intercorre tra essi. In tutte le epoche vi sono state personalità femminili che, prescindendo dalla relazione degli opposti, hanno vissuto e rappresentato il cosmo secondo una prospettiva del tutto personale, basata sull’esperienza individuale.
Tuttavia, con gli anni Settanta del XX secolo, l’espressività femminile si è imposta come vero e proprio fenomeno editoriale, dovuto alla pressante curiosità del pubblico, desideroso di misurarsi con nuove modalità di scrittura, di riscoprire il femminile, di dare voce alla donna e alla sua esperienza, al di là di qualsiasi forma di rivendicazione o d’intento fine a se stesso. Per lo più, le autrici scrivono per necessità, indipendentemente dal fatto di essere donna o cittadina di una determinata nazione. La letteratura viene considerata come possibilità d’intervenire nel mondo a partire dalla realtà locale e, al contempo, di esprimere sentimenti universali. È possibile, pertanto, individuare un mondo letterario articolato, un ambiente culturale propizio ad accogliere i segni di un rinnovamento, anche sociale, in cui alla donna vengono offerte almeno delle opportunità, sempre maggiori con il trascorrere degli anni. Si veda l’esempio di Tina Anselmi, prima donna ministro della repubblica italiana, firmataria della fondamentale legge istitutiva del Sevizio Sanitario Nazionale.
Nell’affrontare il problema con consapevolezza e con maturità espressiva, le scrittrici fanno ricorso soprattutto al genere romanzesco, sia esso il Bildungsroman o la variante del romanzo di iniziazione, ricorrendo al flusso di coscienza, alla forma onirica e meta-narrativa costituita da monologhi, da allegorie e da racconti strettamente vincolati alla ricostruzione di eventi reali, siano essi grandi/piccoli avvenimenti/ sconvolgimenti del proprio tempo, rivelatori del significato di una realtà complessa e mobile. Esse ne amplificano la percezione e creano una visione costantemente tesa alla ricerca della verità. Il discorso letterario presenta una visione originale, recuperando cioè le origini, ciò che è andato perduto nel tempo reale della storia, e si connota di uno spirito di ribellione nei confronti dei maestri, nel tentativo di spezzare l’egemonia maschile – e per certi versi anche quella femminile –. Da qui, deriva la destrutturazione narrativa lirica, tipica tra l’altro della scrittura al femminile, perché ruota attorno a qualcosa che non può essere reso in maniera esplicita – la coscienza della protagonista, per l’appunto –, e perché le situazioni narrate sono svincolati per lo più dal rapporto causa/effetto. Ne consegue un’analisi della realtà femminile, nelle sue diverse sfaccettature e l’affermazione della coscienza dell’essere donna, propria di un soggetto che si affaccia alla vita culturale come ente storico.
Avvalendosi dell’ironia e di figure femminili fittizie che ricorrono alla memoria, al viaggio dentro e fuori di sé, all’esplorazione dei sentimenti più celati, le autrici si presentano al lettore come portavoce di un clima di profondo disagio sociale. Nel denunciare la situazione della donna, in base all’educazione ricevuta e ai ruoli di figlia, di fidanzata, di sposa, di madre, il discorso assume una posizione problematica rispetto alle difficoltà d’integrazione alla sfera culturale della società d’appartenenza e non solo. Tuttavia, fa intravvedere la possibilità di un riscatto: una volta ultimato il percorso di iniziazione, superate prove incontrate durante il viaggio nel microcosmo individuale o nello spazio fisico, le protagoniste sono finalmente in grado di prendersi cura di sé avendo raggiunto la maturità dell’anima che comporta coscienza delle facoltà e delle scelte soggettive. Sono proprio le privazioni e le distruzioni a dispiegare le dinamiche della conoscenza: dal passaggio da ciò che non è a ciò che è, si crea pertanto una realtà nuova.
A volte l’attesa è lunga e colma di rinunce prima di raggiungere la completa indipendenza, prima che si risolva il conflitto interiore, scatenato dal desiderio di ricreare l’immagine più autentica del sé, sia pure conservando i tratti propri della tradizionale visione di femminilità, intesa come l’essere per gli altri, con la piena consapevolezza dell’importanza della donna in seno alla famiglia. Affiora, pertanto, un’idea superiore della bellezza, dove trovano unità conoscenza ed etica, contenuto e stile, proprio come teorizzato da Heidegger (Che cos’è la filosofia) nella sua presentazione dell’arte quale forma aurorale del sapere.