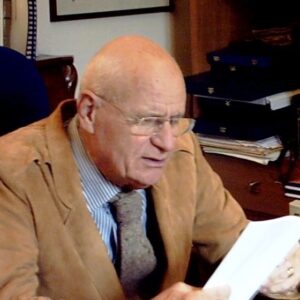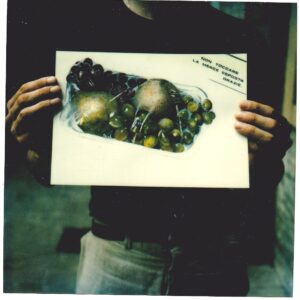Francesco Petrarca e l’Università di Padova
Quando il più grande intellettuale europeo del suo tempo fu accusato di essere… ignorante e illetterato
Tutti sanno, o dovrebbero sapere, chi è Francesco Petrarca: non solo il principe dei poeti d’amore, ma l’intellettuale di gran lunga più influente nella cultura europea del XIV secolo nonché il primo turista d’ Europa, nel senso che inaugurò quel modo di viaggiare soprattutto per inquietudine dell’animo e curiosità di cose nuove che si diffuse sempre più nei secoli seguenti e va tuttora sotto il nome di turismo. È infatti quasi impossibile seguire i suoi innumerevoli spostamenti fra Provenza, Spagna, Francia, Fiandre, Germania e Italia nel corso di una vita relativamente lunga (1304-1374) e ricchissima di gratificazioni mondane quanto di complicazioni spirituali. Tuttavia negli ultimi vent’anni li troviamo praticamente limitati all’Italia centro-settentrionale, dove Signori e Repubbliche si contendevano l’onore di ospitarlo, perché la sua sola presenza dava lustro e prestigio alla Corte e alla Città.
Dopo un prolungato soggiorno presso i Visconti di Milano, si trasferì nel Veneto, fra Padova e Venezia, e poi definitivamente a Padova, ospite “servito e riverito” di quel Signore, Francesco da Carrara. Ed è qui che nel 1366 ebbe luogo un episodio, per certi aspetti abbastanza increscioso, che tuttavia gli offrì l’occasione di esprimere con chiarezza il suo pensiero.
Avvenne infatti che quattro giovani filosofi dell’università di Padova, peraltro amici suoi e frequentatori della sua casa a Venezia, affermarono che Francesco Petrarca era sì “un buon uomo, anzi ottimo, ma illetterato e del tutto ignorante”. Una affermazione incomprensibile se non si tiene presente che nel ‘300 l’università di Padova – una delle prime in Europa – era la roccaforte dell’aristotelismo, non di quello che san Tommaso era riuscito a conciliare col cristianesimo; ma di quello che, dietro il paravento della “doppia verità” di Averroé: non una ma due verità, sovrapposte non conciliate, la verità che la ragione mi dimostra e la verità a cui credo per fede – dietro a questo assai trasparente paravento, nel nome di Aristotele professava il più radicale ed esclusivo scientismo.
Ora è comprensibile che a sentirsi chiamare ignorante – proprio lui – lì per lì il Petrarca ci sia rimasto male, poi però scrisse una ben meditata risposta De sui ipsius et multorum aliorum ignorantia, “Sull’ignoranza propria e di molti altri”, con la quale sposta la prospettiva filosofica e il centro dell’interesse dalla conoscenza scientifica della natura alla conoscenza dell’uomo, dalle leggi della fisica e dalle sottigliezze della logica alle problematiche della morale e della psicologia: “Infatti a che potrebbe giovare conoscere la natura delle belve, degli uccelli, dei pesci, dei serpenti e non sapere o sdegnar di sapere la natura degli uomini, il fine della nostra vita, donde veniamo e dove andiamo?”.
Evidentemente allora l’accusa di ignoranza diventa questione di cosa si intende per sapere: se la conoscenza della natura o la conoscenza dell’uomo; se un totalitario razionalismo scientifico fine a se stesso o l’indagine delle ragioni, dei valori e delle possibilità umane.
Così i giovani averroisti padovani si rivelano incatenati a un ormai sterile passato, mentre il vecchio Petrarca apre la strada ai futuri sviluppi dell’Umanesimo e del Rinascimento. E, a costo di scandalizzare i suoi polemici interlocutori, conclude che, almeno per quanto riguarda la felicità, che è la cosa più importante per l’uomo, in eius cognitione, una vecchietta devota, un pescatore, un pastore, un contadino che abbiano fede in Dio, ne sanno più di Aristotele. Un po’ come se ai giorni nostri uno dicesse: chi conosce Cristo ne sa più dell’Intelligenza Artificiale.