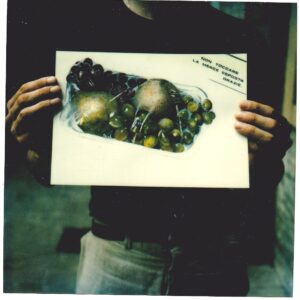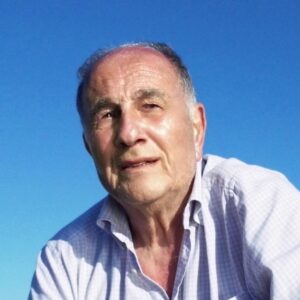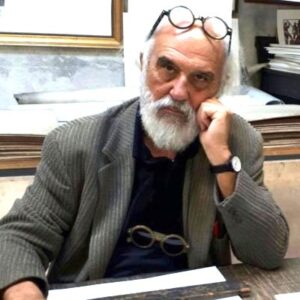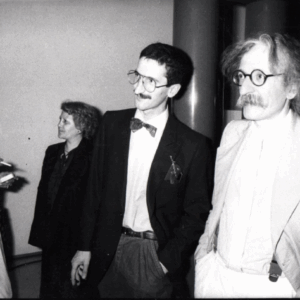Intellettuali e politica: un percorso storico
L’evoluzione, negli ultimi due secoli, di un rapporto complesso, tra manipolazioni e conflittualità
Verso la fine dell’Ottocento, il temine russo Intelligencija ‒ riferito all’insieme degli intellettuali, in quanto gruppo e categoria dal ruolo specifico e comune ‒ inizia a diffondersi in tutto l’Occidente, a partire dalla Francia. L’avvenimento, che ha catturato l’attenzione generale sulla funzione degli intellettuali all’interno della società, è l’affaire Dreyfus: il capitano alsaziano di origine ebraica, Alfred Dreyfus (1859-1935), è accusato di alto tradimento e di spionaggio a favore della Germania per avere trasmesso documenti segreti dell’esercito francese. Dal 1894 al 1906, la Francia avvelenata da un antisemitismo diffuso e dalla perdita recente dell’Alsazia e di parte della Lorena ‒ subita per opera dell’Impero tedesco di Bismarck nel 1871 ‒, si spacca in due fazioni: colpevolisti e innocentisti. A creare tale clima di tensione emozionale è l’attività di giornalisti e di politici antisemiti, suffragata da ambienti ecclesiastici e monarchici che, con il supporto di prove false, istigano ampi settori della società francese. I pochi difensori del capitano ‒ sostenuti dal “J’accuse” di Émile Zola, l’editoriale pubblicato il 13 gennaio 1898 dal giornale socialista L’Aurore e indirizzato in forma di lettera aperta al presidente della Repubblica francese Félix Faure‒ sono a loro volta minacciati, puniti o dimessi dall’esercito. Lo stesso Zola viene condannato a un anno di carcere e a tremila franchi di ammenda per vilipendio delle forze armate. Alla fine, lo scandalo giudiziario si risolve con la proclamazione di innocenza di Alfred Dreyfus, graziato e rintegrato nei gradi, nonostante l’accanita opposizione degli alti vertici militari.
Sono anche gli anni in cui giornalisti, scienziati sociali e politici, storici, scrittori, docenti universitari, funzionari pubblici di alto livello, giuristi, riformatori “di mestiere”, ovvero l’intera categoria di intellettuali, manifesta uno scopo comune: persuadere, dissuadere, guidare e condizionare la decisione politica secondo un profitto personale, assai lontano dall’ufficio di conoscere e far conoscere. Nel denunciare anomalie e necessari correttivi di una qualsiasi realtà politica o sociale, essi sono consapevoli di rafforzare la propria influenza all’interno di un determinato contesto politico, a tal punto che iniziano a concepire il loro intervento come una vera professione. Da qui, l’impegno di guidare e di animare il dibattito pubblico, instaurando un dialogo fecondo con gli organismi pubblici, a cui forniscono chiavi interpretative per comprendere i problemi collettivi. Le istituzioni politiche hanno, pertanto, un solido alleato nell’Intellighenzia. Basti pensare a quanto accade in occasione di importanti appuntamenti, come possono essere le elezioni in una nazione, o gli avvenimenti che sconvolgono equilibri geopolitici e sociali, quali guerre e crisi economiche.
Tutto ciò conduce all’affermarsi dell’attuale concetto di Post Verità (dall’inglese Post-Truth), ricondotta a circostanze dove i fatti obiettivi hanno meno influenza dei richiami alle emozioni e alle opinioni personali. In sostanza la veritas dei latini, l’aletheia dei greci, a cui si deve lo sviluppo di entrambi i popoli, non hanno il medesimo valore oggi, in quanto si situano in secondo piano rispetto alle situazioni tese a fare leva esclusivamente sull’emotività delle persone.
Il termine, in riferimento alle questioni politiche, è usato per la prima volta nel 2010 dal blogger David Roberts, all’interno di una rubrica presente nel sito di informazione online Grist. Esso si afferma diffusamente nel 2016, quando la Post-Truth viene proclamata parola dell’anno dall’Oxford Dictionary, in seguito a due importanti circostanze: il referendum sulla permanenza del Regno Unito in Europa e le elezioni Presidenziali degli Stati Uniti. Nel primo caso, i favorevoli alla Brexit, hanno denunciato l’assurdo esborso settimanale di 350 milioni di sterline, smentiti categoricamente dopo il voto, mentre i contrari hanno previsto, con il supporto di fasulli bilanci, il crollo dell’economia. Nel secondo caso, si diffonde la notizia che Barack Obama non poteva essere eletto Presidente perché privo di un certificato di nascita negli Stati Uniti. Ad essa, si aggiungono altre palesi menzogne, come quella relativa ai Clinton, mandanti dell’uccisione di un testimone scomodo.
Il neologismo viene approfondito anche dall’Accademia della Crusca, tramite un articolo di Marco Biffi dal titolo “Viviamo nell’epoca della post-verità?”, del 25 novembre 2016, in cui si pone l’accento sul vocabolo post da intendersi come oltre. Si tratta cioè di “un ‘dopo la verità’ che non ha niente a che fare con la cronologia, ma che sottolinea il superamento della verità fino al punto di determinarne la perdita di importanza”, afferma lo studioso.
È la conferma che l’emozione s’impone “oltre la verità”, la manipola a proprio piacimento confidando sui sentimenti della gente. Lo testimonia, tra l’altro, il deprimente spettacolo dei quotidiani dibattiti televisivi, dove pensatori esperti in ogni cosa, politici di sinistra si scagliano contro quelli di destra, e viceversa, scambiandosi grossolane accuse e dati statistici contraffatti. Per non parlare delle interviste rilasciate dai cosiddetti “intellettuali”, e pubblicate nelle molteplici reti sociali, in cui si ricorre alla reiterata affermazione degli stessi argomenti di discussione, ignorandone le obiezioni. Sembra proprio che, nell’odierna cultura politica, la verità sia avvelenata da costanti insinuazioni e da falsità tali da privarla di qualsiasi statuto di riferimento ‒ ossia del vero in sé per sé (Hegel) ‒, di ogni imperativo morale (Platone), di qualunque necessità metafisica (scolastica), della capacità di essere arbitro del reale e dell’erroneo, del giusto e dell’ingiusto. Viene annullata l’ostinata opposizione di filosofi, di letterati, di storici e di artisti nei confronti del realismo delle masse: per duemila anni, essi hanno adottato un atteggiamento distaccato ‒ per quanto riguarda le passioni politiche ‒ allo scopo di concentrarsi sull’attività disinteressata dello spirito e di un principio astratto, superiore, opposto a quello delle passioni. Vengono soppresse anche le diverse tappe del pensiero filosofico, dove il concetto di verità, sia pur affrontato da prospettive diverse, ha un comune denominatore: l’imprescindibilità del vero in contrapposizione alla menzogna.
Purtroppo, il diffuso collegamento tra Post Verità e contestazioni populiste è un ulteriore ostacolo allo svolgimento democratico; ciò è supportato dalla comune idea che la verità dei giornali non è credibile in quanto i fatti sono privi di documentazione. A noi il compito di smentirli.