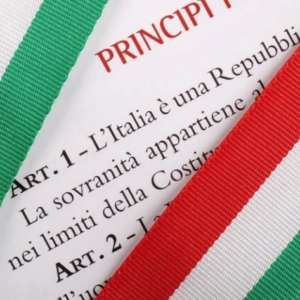Il Nobel per la Pace: ricordiamo chi lo ha meritato per le sue azioni ideali o concrete
L’ondata di solidarietà e rispetto che recentemente ha scosso il mondo in favore di Francesca Albanese e del suo coraggio, ha suscitato proposte e raccolte di firme nella speranza che le possa venire attribuita una candidatura al Premio Nobel per la Pace.
Condivido la stima e la gratitudine per la persona e per il suo operato, e non ho motivo di dubitare che sussistano le condizioni per tale riconoscimento. Francesca Albanese, giurista esperta di diritto internazionale, specializzata in diritti umani e Medio Oriente, dal 2022 relatrice speciale dell’ONU sui territori palestinesi occupati. In tale veste ha svolto per le Nazioni Unite l’incarico di analizzare torti e ragioni, connivenze e vergogne all’origine della disumana situazione del popolo palestinese. Si è mossa tra colossi di potere e uomini privi di qualunque remora morale, ha steso la relazione del suo lavoro e l’ha presentata il 30 giugno 2025 al Consiglio dell’ONU per i Diritti umani col titolo “Dall’economia dell’occupazione all’economia del genocidio”.
Paesi “civili”, e decine di aziende di non pochi Paesi, lucrano in diversi modi sul massacro: gli Stati Uniti hanno scatenato sanzioni, Israele e altri hanno diffuso calunnie, minacce e campagne di delegittimazione, lei ha percorso tante vie nel mondo per parlare della verità. Il rischio per la sua vita era chiaro a tutti: 50.000 firme sulla proposta di candidatura al Nobel per la Pace. Ma, nel concreto, è possibile? Come si determinano le candidature, quali sono i passaggi per arrivare alla scelta definitiva Secondo le regole no, non è possibile, almeno non quest’anno. L’anno prossimo potrebbe, ma solo per eventuali nuovi meriti.
Il meccanismo è complesso. La responsabilità delle scelte è affidata a Istituzioni svedesi: per Chimica e Fisica l’Accademia reale delle Scienze, per la Medicina l’Istituto Karolinska, per la Letteratura l’Accademia svedese, per la Pace invece è il Parlamento norvegese, in quanto alla prima assegnazione nel 1901 la Norvegia era ancora parte del Regno di Svezia e Norvegia.
Il Parlamento dunque designa cinque suoi membri come responsabili di tutti i passaggi, compreso quello definitivo (negli altri casi è sempre l’Assemblea dell’istituzione ad avallare la decisione finale ), e qui si può aprire un altro interrogativo: con quale “prudenza”, nel senso antico di saggezza e lungimiranza, cinque persone hanno saputo svolgere il loro delicatissimo compito, nel corso di questi decenni? Molta, sicuramente, molto spesso, ed era facile a volte, con Albert Schweizer, Maria Teresa di Calcutta, Martin Luther King, Nelson Mandela, la Croce Rossa, perché l’alto livello morale di un candidabile concentra sul suo nome un alto numero di proposte di candidatura.
Ma qualche inciampo indubbiamente c’è stato, se nel 2016, l’anno che ha visto il massimo numero di candidati, 376, il premio è andato a Juan Manuel Santos, Presidente della Colombia, per avere firmato un trattato di pace con le FARC, Forze Armate Rivoluzionarie della Colombia, trattato che sottoposto a referendum popolare viene cancellato; in seguito Santos dovette chiedere perdono alle madri dei giovani – più di 6.400 – che il suo esercito aveva sequestrato, ucciso e spacciato per guerriglieri.
Errare humanum. Ma i passaggi per la designazione sono pensati davvero con prudenza e coinvolgono tante persone. I cinque parlamentari inviano a 3.000 “accreditati” una lettera di invito a segnalare persone degne del Premio, le proposte devono arrivare entro il primo di febbraio dell’anno corrente. Fra gli accreditati figurano capi di Stato, membri della Corte internazionale di giustizia, precedenti premiati per la Pace, professori universitari di materie attinenti. Le candidature da loro proposte vengono tutte esaminate dal Comitato norvegese per il Nobel, che ne seleziona circa 300, poi ulteriormente analizzate e discusse fino al mese di ottobre, quando la decisione finale viene annunciata ufficialmente. Solo dei vincitori è comunicato il nome, mentre la lista delle candidature viene tenuta segreta per 50 anni, anche se questo non impedisce ogni volta lo svolazzare di notizie apocrife sui tanti “media” senza controlli (per usare una bella parola latina).
È interessante scorrere i nomi dei premiati per la Pace, e forse anche di più le motivazioni, per cercare di capire se e come il mutare delle situazioni sociali e ambientali nel mondo abbia influito sulle decisioni del Comitato norvegese, o sui 3.000 accreditati consiglieri.
Il primo, nel 1901, Jean Henry Dunant, svizzero, fondatore della Croce Rossa e ideatore delle convenzioni di Ginevra per i diritti umani: grazie per sempre.
Fino al 1913 il Premio è attribuito ad Organizzazioni o singoli fondatori o rappresentanti nel campo dei principi generali della giustizia: una sorta di promemoria dei grandi valori.
E scoppia la Grande Guerra. Nel mare dei suoi lutti, nessun grande è abbastanza innocente da poter essere citato: solo nel 1917 è riconosciuto il valore della Croce Rossa “per essersi adoperata in difesa dei diritti dei prigionieri di guerra su tutti i fronti”.
Dal 1919 al ’22 , dopo che l’appello ai principi generali si era dimostrato inefficace, protagonista è la Lega delle Nazioni, dal Presidente degli Stati Uniti Wilson al francese Bourgeois, allo svedese Branting, ai norvegesi Lange e Nansen: a quest’ultimo si deve un onore speciale, perché molto speciali sono state sia la sua vita che la sua opera.
Fridtjof Nansen, sportivo di valore da giovane ( un record mondiale nel pattinaggio su ghiaccio) esploratore per mare e per … neve – traversata della Groenlandia sugli sci -, scienziato con osservazioni fondamentali sulle correnti marine e non solo.
Nell’ambito del suo compito di Commissario per i Rifugiati si spende concretamente in tutta Europa, dove molte strade ancora ricordano il suo nome. Ma la sua cosa più grande è l’aver concepito il Passaporto per i Rifugiati, che salva la dignità e il futuro degli apolidi e di coloro che senza colpa non possono riavere dal proprio Paese un documento di identità. Ancora oggi questo foglio di accoglienza porta il suo nome, ed è la firma della giustizia di una Nazione.
Negli anni seguenti si premiano i protagonisti dei vari patti e trattati (di Locarno, Brian-Kellogs) che promettevano reciproco rispetto e “rinuncia alla guerra”.
Nel 1935 il primo giornalista pacifista, Carl von Ossietzky, imprigionato dalla Gestapo dal 1933: gli occhi del Comitato norvegese si posano sul sacrificio personale.
Poi ancora la guerra: solo nel 1944, il Premio al Comitato internazionale della Croce Rossa, “Per l’ottimo lavoro svolto durante la guerra a favore dell’umanità”.
Nel 1948 la più clamorosa non-assegnazione: era candidato il Mahatma Ghandi, la Grande anima dall’eroica non-violenza, ma il Premio non venne attribuito “perché non c’era nessun candidato idoneo vivente” . In realtà Ghandi era morto assassinato il 30 gennaio di quello stesso anno, quindi anche volendo pensare da burocrati, era vivente nel tempo giusto delle candidature, fino a due giorni prima della chiusura. Era già stato fra i candidati altre quattro volte, nel ’37, ’38, ’39 e ’47, ma il Mahatma era un piccolo uomo dall’eco mite, mentre gli echi di guerra gridano la loro richiesta d’aiuto: nel 1937 è premiato Robert Cecil fondatore e presidente della Campagna internazionale per la Pace, nel 1938 l’Ufficio Internazionale Nansen per i rifugiati.
Dopo il caso del 1948 una valanga di critiche sul Comitato norvegese, che dopo qualche tempo riconobbe almeno in parte l’errore. Ma sono convinta che la pace del piccolo uomo non ne sia stata scalfita.
Nel 1952 un grande, Albert Schweitzer, il chirurgo che missionario in Gabon fondò l’ospedale Lambaréné, portando in grande luce la filosofia del rispetto di ogni forma di vita. Grandissimo il tributo di stima che raccolse nel mondo.
Nel 1960 di nuovo l’Africa all’attenzione del Comitato per la pace, e col sudafricano Albert Lutuli irrompe il problema dell’Apartheid.
Sono anni forti. Nel 1962 Linus Pauling, già nel 1954 Nobel per la chimica, qui premiato come promotore della campagna contro i test nucleari. ‘63 Croce Rossa, ’64 Martin Luther King, vittima forte e mite per i diritti civili. ’65 l’UNICEF, i bambini.
René Cassin, nel 1968, Presidente della Corte europea dei diritti umani, (laureato in letteratura, legge, economia, scienze politiche) merita di essere ricordato anche come redattore della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’uomo.
1971 Willy Brandt, riunificazione della Germania.
1975 Andrej Sacharov, fisico nucleare sovietico, diritti umani.
1979 Madre Teresa di Calcutta.
1984 Desmond Tutu, di nuovo l’Africa e l’Apartheid.
1989 Dalai Lama, la non-violenza nella lotta di indipendenza del Tibet.
1990 Michail Gorbachov, la fine della Guerra fredda.
1991 Rigoberta Menchù Tum, diritti dei popoli indigeni.
1993 Nelson Mandela e Willem De Klerk per fine dell’Apartheid.
Lo sguardo del Nobel si è allargato al mondo di tutti.
Nel ’94 il Premio alla grande speranza di pace per le piaghe di Palestina: Yasser Arafat. Shimon Peres, Ytshak Rabin firmano il trattato che istituisce l’Autorità Nazionale Palestinese e le riconosce un autogoverno parziale su Gaza e la Cisgiordania: ma tre Nobel per la Pace non bastano.
Medici senza Frontiere, premiati nel ’99, oggi sono di nuovo lì, a offrire il proprio sangue.
Le motivazioni sono spesso “Per gli sforzi”, è chiaro ormai che nulla è definitivo, la società è in fermento ovunque, si moltiplicano gli scenari, i protagonisti e le precarietà delle lotte per il Bene, scegliere è difficile, accade che “il mondo” si dissoci.
L’attenzione va alle armi nucleari, le mine anti uomo, i conflitti fra nazioni, la democrazia e i diritti umani in Asia, – molte di queste motivazioni nel Premio a Jimmy Carter nel 2002, e forse al tempo non ce ne siamo accorti – i diritti delle donne e dei bambini, lo sviluppo economico e sociale “dal basso”.
I cambiamenti climatici irrompono nel 2007 con Al Gore e le Nazioni Unite, le lotte contro la sopraffazione e per il diritto all’istruzione dei bambini e dei giovani hanno i loro paladini in Kailash Sathyarti e Malala Yousafzai, India e Pakistan premiati insieme nel 2014, ed è un bel messaggio. Nel 2017 di nuovo le armi nucleari.
Nel 2018 e 2020 due delitti “nuovi”, le violenze sessuali nei conflitti armati, e la fame.
Fra il 2018 e il 2023 sono giornalisti e attivisti a muovere l’opinione pubblica e il Comitato, e a ricevere il doveroso onore del Nobel: è sul loro sacrificio personale, sul coraggio d’avere coraggio, che cresce nel nostro stanco Occidente la consapevolezza delle vergogne nascoste dei grandi Paesi.
Denis Mukwege, medico, Nadia Murad, Maria Ressa, Dmitry Muratov, Ales’ Bjaljacki bielorusso insieme a un Centro ucraino e uno russo per le libertà civili, l’iraniana Narges Mohammadi, hanno affrontato carcerazioni durissime e privazioni delle libertà per cui lottavano. È spesso dal dolore che nascono gli esseri Umani.
L’ultimo finora, il Premio del 2024, sembra inchinarsi al Popolo umanissimo del Giappone, che apre le sue ferite per pregare il mondo che non accada più. La nostra supplica, in questo mondo diventato cieco, è che i nostri occhi si aprano su quelle ferite, e portino luce nella profondità della nostra anima.