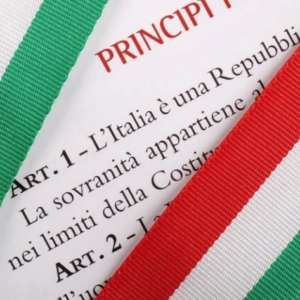Gli otto secoli del Cantico delle Creature: un altro modo di stare al mondo
Nell’anno in cui si ricorda l’ottavo centenario della composizione del Cantico delle Creature, ci viene offerta la possibilità di rileggerlo non solo come un testo spirituale, ma anche come mappa e bussola per intercettare e aprire vie di speranza e di futuro là dove paiono esserci solo rassegnazione e impotenza. Il cantico ci insegna ad usare bene il mondo, dove “usare” non rimanda alla dimensione della produzione e del consumo ma ad un concetto ben più preciso e profondo, quello di “cura”, cura del senso di sé e cura del mondo.
Francesco di Assisi ci insegna che avere cura del mondo non vuol dire avere cura di qualcosa che è lì davanti a noi come un oggetto, ma che è attorno a noi, è in noi e in sostanza ci permea. Il mondo è ciò di cui noi stessi siamo fatti: averne cura vuol dire non solo avere cura di qualcosa come la nostra “casa”, ma avere cura di noi che ne siamo gli abitanti e anche dell’aria che vi respiriamo.
L’ universo vissuto e cantato da Francesco è fatto di un materiale prezioso, come quello delle stelle e dell’acqua, è fatto di splendore, di bellezza, di utilità, di luce, di vita e di bontà ed è visto in una luce di ottimismo, di allegria e di gioia che si oppone totalmente al pessimismo del suo come del nostro tempo. Lo sguardo universale sulle cose e sugli altri esseri è un ponte vitale che comunica la sua interiorità personale agli esseri fuori di lui, espressione gioiosa “della comunione tra il cantore e le cose cantate”.
Composto tra il 1224 e il 1225, Il Cantico delle Creature è considerato il primo testo letterario in volgare italiano, destinato ad un pubblico di fedeli che non comprendeva il latino, lingua ufficiale della liturgia. Attraverso la bellezza poetica dei versi, Francesco poté parlare direttamente al cuore e all’intelligenza di tutti, costantemente preoccupato di condividere e trasmettere l’annuncio liberante del Vangelo. Egli canta e celebra la libertà, perché canta e celebra la vita e l’esistenza, perché si sente liberato e salvato, perché si sperimenta pienamente libero.
Attraverso il Cantico, Francesco di Assisi ci insegna che il valore sommo per un “buon uso” del mondo richiede la conoscenza del mondo e la libertà di scegliere la propria strada, all’interno di una comunità di valori che investe la relazione con il mondo e con gli altri. Lo sguardo di Francesco sulle cose non fu mai interessato e la sua volontà fu sempre libera dall’ingordigia e da ogni desiderio di possesso e di dominio. Francesco non era arrogante e per questo trattava le cose con immensa simpatia e cordialità; non solo le invitava a cantare, ma lui stesso fraternizzava e cantava con loro.
Viviamo un tempo in cui i rapporti interpersonali, le dinamiche politiche e sociali si fondano su un dare e ricevere basato su assicurazioni e garanzie, spesso su rapporti di forza e di potere. Francesco si spogliò assolutamente di sé e delle cose; per questo scoprì l’assoluto nelle cose. Si liberò incondizionatamente delle cose e delle pretese, e come contropartita trovò l’assoluto degli esseri e poté udire la musica silenziosa dell’universo. Egli aveva un forte senso della gratuità da parte di Dio; per questo tutta la sua vita fu un canto di gratitudine. Cantava, perché sentiva, sentiva perché viveva e viveva perché partecipava, ma con una partecipazione sentita, riconosciuta e riconoscente. Per questo egli non esigeva niente e dava tutto. Ma, dando a fondo perduto, egli ricevette come gratificazione l’apertura a tutte le strade possibili. E questo uomo distaccato e liberamente spoglio entrava nel gioco di Dio, degli uomini, degli animali e degli altri esseri creati.
Tuttavia, per comprendere il senso autentico del Cantico, è necessario leggerlo fino in fondo o forse addirittura partendo dal fondo. Solo così è possibile coglierne il suo tono vitale e scoprire ciò che preoccupò Francesco nel corso della sua vita. La penultima strofa celebra il perdono e la pace. Fu composta prendendo spunto da una situazione di conflittualità tra il vescovo e il podestà di Assisi. Questo significa, che mentre l’inno originale sgorga da una armonia cosmica e da una pace gioiosa, questa strofa nasce da un conflitto umano che è in contrasto con le strofe anteriori.
Questa la grandezza umana del Cantico. Mentre le cose si trovano in un’armonia già fatta e stabilita, gli uomini sono liberi di crearla, di renderla possibile e di inventarla.
Francesco canta il paradosso dell’idillio cosmico e della tragedia umana. Da Francesco, malato e sconfitto, emerge il cantico più sublime della spiritualità cristiana. Ne sgorga anche la sua portata etica e morale, espressione del suo particolare modo di essere e di stare nel mondo e del modo di essere delle cose. Un invito a ringraziare, abitare e custodire invece di pretendere e di possedere. Un invito a riscoprire che tutto è dono. E ciò che è dono non si possiede, ma si accoglie.
Siamo così incoraggiati a riorientare lo sguardo e a volare alto, non prima di essere ritornati alla domanda “che fare?”, dove il fare è un agire dotato di senso, del nostro stare al mondo e non semplicemente un puro muoversi’.