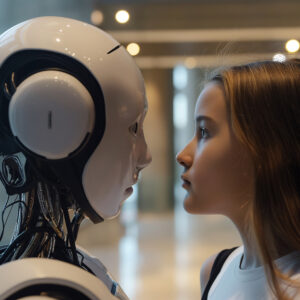Conservare la volontà di conoscere e capire anche in un mondo che favorisce la confusione
Quando, ormai quasi sei anni fa, il mondo si ritrovò nella morsa della pandemia, e soprattutto delle misure e limitazioni con le quali si tentò di contenerla, sin dall’inizio la raccomandazione principale fu: non date ascolto alle opinioni improvvisate, fidatevi degli esperti. Peccato che, già nell’immediato, tali esperti – che in generale lo erano effettivamente, dotati di titoli e studi e autorevolezza nel proprio campo – iniziarono a darsele e dirsele di santa ragione, contraddicendosi e sconfessandosi l’un l’altro, contrastandosi e non di rado insultandosi apertamente. Di conseguenza, indicazioni antitetiche e antagoniste tra loro divennero totalmente inutili, portatrici di confusione molto più che se nessuno avesse detto nulla (cosa, peraltro, ovviamente impossibile), finendo con il mescolarsi in un chiasso indistinguibile nel quale, a quel punto, tutti potevano sostenere tutto e il contrario di tutto, dando voce e uditorio anche a chi esperto non era per nulla.
Se rievoco un periodo che, nella memoria di quasi tutti, rimane tra i più sgradevoli, è soltanto perché un meccanismo simile, o addirittura analogo, sta presiedendo il momento attuale. Governanti, studiosi di questioni geopolitiche, analisti ed esperti militari s’affannano, spesso tronfi per l’attenzione ricevuta, a dire la loro sugli scenari bellici in corso e, soprattutto, su quelli futuri e su come affrontarli. Si va da chi ritiene inevitabile e certa una futura guerra tra l’Europa e la Russia, al punto quasi di auspicarla o addirittura propugnarla – dando per scontato, non è ben chiaro in base a quali stime, che la maggior potenza nucleare del pianeta si asterrebbe dal fare ricorso al proprio arsenale, qualora aggredita da una soverchiante coalizione internazionale – a chi ritiene risibile e assurdo, idealmente e militarmente, lo scenario di una minaccia concreta da parte di Mosca, che in quattro anni di sforzi ed enormi perdite umane è penetrata di poche centinaia di chilometri all’interno dell’Ucraina. Scenario risibile, ripeto (è ovviamente una mia idea personale, che non impegna quella della redazione e dei collaboratori di questa testata), se non fosse tragica e pericolosissima per le degenerazioni che potrebbero derivarne. Nessuno nega, beninteso, che le aspirazioni del Cremlino sul territorio di Kiev vadano contenute e fermate, ma è una follia immaginare che il modo giusto per riuscirvi sia un conflitto continentale o, addirittura, planetario.
Il problema, per l’ennesima volta, è che le lezioni della storia – da sempre indicata quale “maestra di vita” – in realtà rimangono inascoltate, nonostante offrano tutti gli elementi per interpretare, o almeno meditare, ogni situazione presente. Lo stimatissimo Alessandro Barbero, pur con il seguito (per fortuna) di numerosi altri, ha un bel daffare a ricordare e ribadire l’inconsistenza storica della massima in base alla quale, per ottenere la pace, si debba prepararsi alla guerra: può aver funzionato negli anni della contrapposizione tra Est e Ovest, ma non in moltissime altre occasioni, incluse quelle sfociate nei due conflitti mondiali. Invece oggi, dai singoli Stati-guida alle istituzioni europee, proprio alla guerra ci si sta preparando, con intenzioni magari diversificate – ora l’effettivo desiderio di un’azione bellica, ora la volontà di un rilancio industriale ed economico – che però, per quanto variegate, finiscono con l’essere non contrapposte ma convergenti.
Per cui, adesso come sei anni fa, e restando purtroppo evidente la memoria cortissima ed evanescente che caratterizza la nostra epoca (stiamo già accantonando ciò per cui, appena due mesi fa, ci indignavamo, ovvero il massacro di decine di migliaia di civili in terra di Palestina), finisce che ogni notizia, ogni informazione, ogni nozione, ogni testimonianza, ogni considerazione proveniente da una parte si scontra con quella sostenuta da un’altra, tutte magari nutrite sì d’esperienza e studi ma anche di personali inclinazioni, simpatie, interessi o, infine, semplicemente del desiderio di prevalere sull’interlocutore e dall’ambizione, illusoria, di saper predire quel che nessuno può realmente prevedere.
Certo: documentarsi il più possibile, confrontare le notizie, ragionare autonomamente “con la propria testa” rimane sempre la miglior regola di vita, sia per l’attuale situazione geopolitica sia per ogni altra questione. Ugualmente, la sovrabbondanza di informazioni e valutazioni è comunque un tesoro prezioso, non sempre disponibile in ogni nazione o angolo del mondo. Tuttavia, quest’azione di discernimento rischia di farsi sempre più complessa e articolata anche per chi disponga degli strumenti, delle attitudini e della preparazione necessari, cedendo al predominio delle generiche semplificazioni.
Resta, pertanto, una domanda decisiva che sarebbe piaciuta a Pirandello, consona com’è con le questioni trattate un secolo addietro nelle sue più celebri opere teatrali: a quale pro impegnarsi, spesso con fatica e dispendio d’energie e di tempo, per orientarsi tra le mille voci e perseguire una verità oggettiva e irrefutabile che, se esiste, è forse irraggiungibile non soltanto nell’ambito esistenziale e metafisico, ma anche nella realtà concreta d’ogni giorno? Un’oggettività, peraltro, che anche qualora ottenuta sarebbe destinata a rimanere un traguardo personale, circondata da mille opinioni approssimative o sommarie che la soffocherebbero, rendendola priva di effetti e utilità almeno a livello collettivo.
Questa domanda, di per sé, rimane priva d’una risposta certa. Eppure, come tutte le domande cui manchi una soluzione semplice e immediata, ci suggerisce che probabilmente la risposta è proprio nella sua ricerca, a prescindere che sia possibile o meno trovarla. Ambire ad orientarsi in un mondo governato dalla confusione, sì, è sempre più arduo. Ma non sarà mai vano.