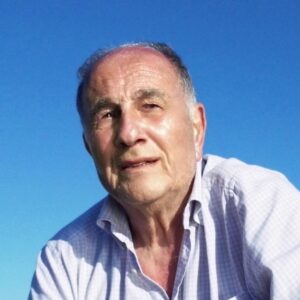Rigenerare i valori dell’impegno civile
La politica si è trasformata da militanza a tifoseria, perdendo la capacità di una visione proiettata al domani e scoraggiando la partecipazione alla vita pubblica
La politica è un servizio nobile per il governo della “polis”. La “polis” è la comunità di individui e famiglie tenute assieme da molteplici legami (etnici, religiosi, economici…). Al servizio della polis vengono elette le persone che, per libera scelta, decidono di confrontarsi con idee, programmi e storie personali con altri candidati.
Utopia? Chissà! Ma oggi riscoprire e rigenerare i valori alti dell’impegno civile è condizione per non precipitare nella superficialità di pensiero e azione. Nell’humus della superficialità si alimentano le tifoserie, incuranti dei problemi reali, trascinati in eterne dispute tra slogan.
Fino a qualche anno fa, il ruolo di formazione e di sintesi lo esercitavano i partiti, nei vari organismi di partecipazione interna, animati da discussioni anche accese, ma foriere di un pensiero che sapeva coniugare le risposte ai bisogni di oggi con una visione proiettata al domani. Oggi i partiti sono diventati per lo più dei comitati elettorali, poco avvezzi alla discussione ma più al servilismo verso i leader e i loro “cerchi magici” di supporto.
In questo quadro si motiva una delle cause della disaffezione verso tutto ciò che riguarda il governo della polis. L’astensionismo è il primo partito, con percentuali che vanno sempre più ampliandosi. Tante le discussioni sul fenomeno, ma limitate all’aspetto della perdita dell’elettore, anziché concentrarsi sulle cause del disagio che il cittadino dimostra con l’astensione. Il pianeta terra, il paese reale, sembra diventare trasparente per i leader, arroccati nelle loro convinzioni, piuttosto che nella ricerca di percorsi di partecipazione da parte dei cittadini.
Basti citare, ad esempio, la logorante discussione sul terzo mandato degli amministratori che non tende certo a favorire un processo di rinnovamento, ma al contrario a mantenere chiusi gli spazi di impegno da parte di cittadini che potrebbero portare “brezza di aria nuova” se seriamente coinvolti e non usati. È pur vero che molti si sono dimostrati bravi amministratori e che sarebbe illogico perdere la loro esperienza ma dieci anni sono sufficienti, in tutti i ruoli istituzionali, per progettare, realizzare e formare eventuali altre persone. Gli uomini soli al comando entusiasmano nel ciclismo, nella politica diventano un problema tendente al fastidio.
Trincerarsi dietro al terzo mandato non è funzionale alla libertà di scelta ai cittadini per conservare gli amministratori capaci, ma rappresenta il fallimento di non saper pensare al ricambio della classe dirigente. Nei paesi, come nelle grandi città, si stenta a trovare persone che si impegnino nel servizio politico. Il terzo mandato non considera il problema all’origine, ma lo nasconde e posticipa. Se uno è stato apprezzato può benissimo essere impiegato in altre esperienze di gestione e, magari, utilizzato per aiutare altri a formarsi.
Sul “pianeta terra” si chiede di affrontare i problemi dei territori. Oggi le campagne elettorali si riducono a sfilate di “big” e volti noti che poco o nulla conoscono del territorio che li ospita: aizzare le folle tra comizi, banchetti e sagre paesane diventa il metodo del consenso. Bene hanno fatto alcuni governatori, come la neo presidente della Sardegna, ad invitare, durante la campagna elettorale, i leader della coalizione che la sostenevano a rimanere a casa: lei voleva parlare ai sardi dei problemi irrisolti della Sardegna – viabilità, sanità, scuola, lavoro – e non di altro Per questo chiedeva la fiducia e solo su questo voleva presentare le sue proposte.
Sono i territori che devono pensarsi uniti valorizzando le specificità locali, lasciando liberi i rappresentanti locali di esercitare appieno la loro responsabilità, oggi minata da una serie infinita di orpelli che limitano o sterilizzano l’azione locale. Il principio dell’autonomia prevede che io possa esercitare la responsabilità nell’interesse locale, in una dinamica nazionale ed europea. Oggi al concetto di autonomia si fatica a legare quello di responsabilità, perché la possibilità di trasferire i fallimenti agli altri livelli di governo è un’area di confort che sta bene a molti.
In questa chiave vanno lette e interpretate le richieste autonomiste: esercizio della responsabilità di governo locale in un quadro preciso di competenze politico-amministrative che non soffochino le capacità organizzative locali, per farle diventare guida e riferimento per il sistema paese. Se uno corre più velocemente non lo si ferma, ma si offrono a tutti gli strumenti per correre alla pari. Poi sta alla volontà e organizzazione (responsabilità!) di ciascun territorio dotarsi di strumenti per migliorare sempre più il proprio risultato.
Ritornando al governo della polis, mi piace ricordare che la nostra storia è foriera di esempi positivi a cui attingere. Non c’è nulla da inventare, ma solo fare tesoro di tante buone pratiche ed esperienze personali di donne e uomini che il servizio alla politica lo ancoravano ad alti valori civili e di fede, per coltivare il gusto della ricerca alla mediazione, al rispetto della diversità pur mantenendo la propria identità, nel riconoscersi e pensarsi assieme tra persone, piuttosto che chiusi nei recinti delle appartenenze. Figure profetiche come Giorgio La Pira (1904-1977), Giuseppe Dossetti (1913-1996), Alcide De Gasperi (1881-1954), Vittorio Bachelet (1926-1980), il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ma più recentemente come i veneti Tina Anselmi (1927-2016), Lina Merlin (1887-1979), Luigi Gui (1914-2010). Ma, assieme a loro, tanti altri deputati e senatori e sindaci che si sono distinti per stile di vita e capacità di “vedere oltre”.
Rileggere la storia per ancorarci ai valori fondanti, abbandonando banalità e riscoprendo il gusto del pensiero alto, affinché chi segue intraveda speranza e voglia di partecipare.
Le partite si giocano sul campo e non sulle tribune.