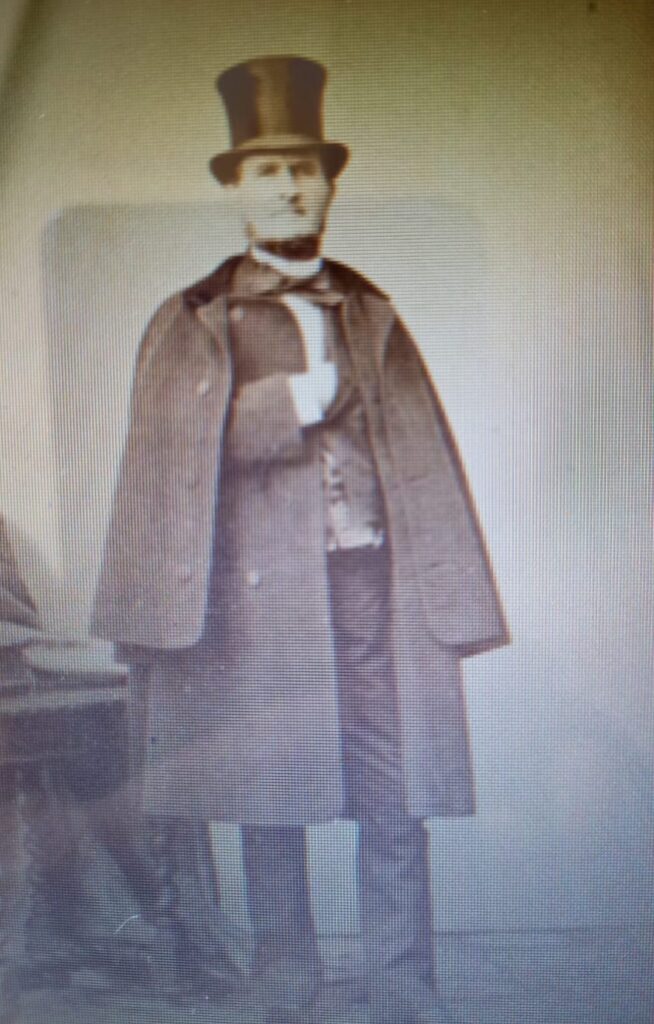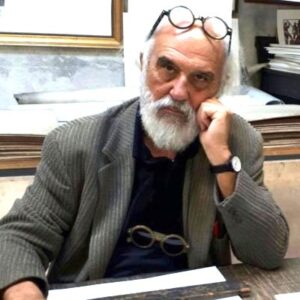La Casa degli Angeli: ricordo di un padre e di un luogo
Tra affetti privati e memoria, una poetica riflessione sul trascorrere del tempo, individuale e storico

Lei sta dove comincia la quiete, la pazienza buona della campagna. Lei, la Casa, raccolta nel silenzio delle finestre chiuse.
È la casa di mio padre, della famiglia, ha ospitato le nostre radici antiche, e la mia prima infanzia.
Il tempo è una cosa affascinante: fugge veloce come spesso ci pare, oppure è continuamente immobile in ogni singolo istante, e continuamente nuovo in quello che subito segue? E a noi sembra fluire, il tempo, perché ogni attimo passato permane nella nostra memoria, e vive? E tutti gli attimi che sono passati per la nostra vita imbevendosi di qualche particella di noi, dove vanno quando nessuno li ricorda?
Io amo i pensieri gratuiti, senza possibili conferme né possibili smentite. Qui per esempio, i nostri istanti emeriti, che hanno completato con onore il loro breve insostituibile lavoro, li vedo sostare nel luogo in cui hanno conosciuto il vibrare della vita umana. Non cerco prove, ma forse qualcosa di simile esiste davvero: una casa nuova non ha lo stesso silenzio di un luogo dove si è vissuto, pensato e amato.
Nella Casa degli Angeli il silenzio è dignitoso e grande. Tante le cose che non so. Voglio cercarne la storia.
Il nome della famiglia Angeli risulta per la prima volta presente a Rovigo nel 1603, come facente parte del nobile Consiglio della città. Nel ‘700 i primi nomi documentati sono quelli di Giovanni Domenico Angeli e del figlio Giovanni Battista, e qui già si parla della Casa di Buso, da loro acquistata nel 1775 da Agostino Santini, ristrutturata e abitata. Perfino il Palazzo è nato dopo di lei!
Torniamo a Giovanni Battista, che sposando Teresa Maria Mammo di Venezia arricchisce il Polesine di un ventaglio di sei figli: Francesco, Domenico, Annunziata, Anna, Maria Elena Cattarina, Isabella.
E qui troviamo la prima data storicamente importante, 1797, nascita di Domenico Angeli: su Wikipedia “Filantropo italiano”, sulla lapide che accompagna il busto esposto alla palazzina del Corpo di Guardia “Insuperato benefattore”.
Detto per sorridere, ho sempre ammirato la sagacia del Comune di Rovigo, che evitando l’enfasi della parola insuperabile ha lasciato libera la fortuna di provvedere in un eventuale futuro …
Ma che il Conte Domenico Angeli abbia meritato tutta la stima e la riconoscenza che gli sono state tributate non si può mettere in dubbio. La solida fede di famiglia ha generato in lui il desiderio di essere concretamente presente dove c’erano necessità culturali o sociali (parlando di “Popolo Veneto” e sensibilità sociali… c’è affinità).
Dai restauri di chiese e monumenti alle case dei contadini, lui c’era, e prima di andarsene nel 1876, con un legato testamentario destinava al Comune il Palazzo Angeli in città, e “una campagna con fabbriche e una casa dominicale in San Bellino” con l’impegno che i proventi delle campagne venissero impiegati a vantaggio dei poveri della zona.
Era stato anche il primo sindaco di Rovigo, nel 1866, quando la vittoria nella terza guerra d’indipendenza aveva portato il Veneto in Italia.
Intanto amministrava anche le sue proprietà e trasmetteva la cultura della terra alle sorelle e alle nuove famiglie che si andavano formando. Perché Domenico Angeli non si è mai sposato, né ha lasciato discendenti diretti. Del fratello e di tre sorelle non conosco altro che i nomi, ma so che il cognome degli Angeli si sarebbe estinto, se la sorella Anna non avesse chiesto e ottenuto di conservare e trasmettere il cognome di nascita oltre a quello del marito.
E chi fosse il marito spiega bene per quale motivo il destino degli Angeli giovani si sia trasferito a Vienna per quasi un secolo. Si chiamava Florian Pasetti, era un ufficiale austriaco, consigliere di Corte, ma soprattutto era un ingegnere idraulico, conosciuto in campo internazionale per la specifica esperienza sui fiumi. E a Vienna le esondazioni del Danubio distruggevano, da tempo e ripetutamente, interi quartieri, e nessuno sapeva come guarire la piaga.
La prima inondazione nel 1801, poi un’altra rovinosa nel 1830, poi finalmente nel 1848 il Ministro del Commercio von Bruck riunisce una Commissione per cercare di venire a capo del problema. È intuibile che ne faccia parte Florian Pasetti.
La maggioranza dei commissari propende per una ipotesi di lavoro, ma Pasetti ritiene che sia tecnicamente non realizzabile. Gli altri non possono prevalere sulla sua competenza e il suo prestigio, ma resistono, e non viene approvato nemmeno il progetto di Pasetti.
Non so con quale intensità siano proseguiti i lavori, ma tre anni dopo von Bruck si dimette e la commissione si scioglie.
È interessante seguire con le date l’alternarsi degli avvenimenti, perché se ne trae la sensazione che Vienna sia una terra di gente paziente.
1830, grande alluvione.
1848, prima commissione.
1851, scioglimento senza esito.
1854, Francesco Giuseppe nobilita Pasetti col titolo ereditario di Ritter von Pasetti.
1862, alluvione catastrofica.
1864, l’Imperatore ordina che sia indetta una seconda commissione.
1866, è convocata la seconda commissione.
1867, ancora il Kaiser nobilita Pasetti col titolo di Barone Florian von Pasetti de Friedenburg. Da notare che l’uso di nobilitare elementi della società civile meritevoli non solo culturalmente, ma anche nel concreto, era sì riconoscimento del merito, ma anche saggia pratica dell’Imperatore per inserire concretezza nella nobiltà.
1868, il Barone va in pensione.
In breve tempo, i commissari trovano la concordia, scelgono il progetto sempre bocciato e lo realizzano proprio in base ai dati della monumentale Pasetti Karte, la mappa del Danubio che è ritenuta una rivoluzione nella cartografia, l’inizio dell’era nuova. Quindi la cocciutaggine di Florian è stata più forte della sua stessa scienza e quella dei commissari degna di ammirazione e di successo.
Al di là dei particolari dei progetti, che non sono alla mia portata, basti sapere che il Danubio è domato, Vienna rinnovata e sicura.
E può accadere che negli anni 2000 un ragazzo vada un sabato a Vienna ed entri in un museo, veda una lunghissima mappa del Danubio e una firma e una dedica della città a un Florian Pasetti di cui conoscevamo solo il nome.
L’abbiamo studiato, ed era ancora solo un antenato di carta. Poi quel ragazzo ha trovato una foto e me l’ha mostrata senza parlare: è stata una gioia inattesa e tenerissima, perché quel viso era il viso di mio padre, il sorriso ironico e complice degli occhi con cui mi guardava mio padre dall’alto del calesse. La foto si è accesa, e Florian è il mio trisavolo giovane.
Intanto nascevano i figli dei miei trisavoli, non c’è più molto Polesine nei nomi: Johann, Joseph, Aloys, Marius, ma la lingua italiana resiste, e la Casa di Buso è sempre lì ad attendere nel sole.
Aloys, che è del 1839, sposa una fanciulla greca di Trieste, Maria Karis, e qui siamo proprio vicini al ritorno in Italia, perché sì… la figlia Leopoldine Pasetti Angeli sposa Lothar von Polzer e vede la luce il piccolo Alfred che si farà italiano, ma è soprattutto Nonna Karis la nonna amatissima e dolce che lo consola da piccolo e lo guida, poi, nella scelta del suo futuro destino.
Infatti, uscito dalle scuole superiori, lui lascia sfumare le passioni artistiche che aveva coltivato, teatro e musica, rimanda gli studi di sociologia che erano il suo interesse più profondo, si laurea in scienze agrarie e ritorna alla terra degli Angeli. Per la Casa è una nuova vita, il fermento della campagna, la voglia di futuro. Vedrà di nuovo una famiglia vivere, vedrà una guerra, i militari tedeschi, il comandante ubriaco che sparava alle porte dove voleva entrare (ma i suoi soldati, bravi ragazzi, lo portavano via).
Ha visto la Resistenza, il coraggio, i giorni che Alfredo de Polzer ha definito i più forti e appaganti di sempre, quelli in cui ha potuto rischiare davvero la vita per i suoi ideali.
Ha ospitato ancora, dopo di lui, anime di famiglia, e ne custodisce gli istanti, la Casa degli Angeli di Buso. Ora sta dove comincia la quiete, raccolta nel silenzio delle finestre chiuse.
Qui sotto, nell’ordine: Alfredo de Polzer, Domenico Angell, il generale Pasetti von Friedenburg