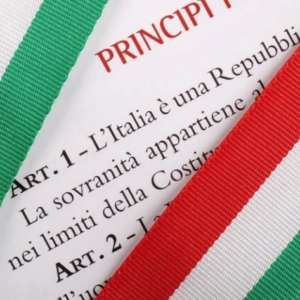Capitalismo 4.0: versioni diverse di uno stesso “software”
Considerazioni storiche e critiche su come, dalla Rivoluzione Industriale del Sette-Ottocento ad oggi, lo sfruttamento del lavoro abbia cambiato forme, ma non la sua sostanza né i suoi fini
Già nel 1886, l’ingegnere ed imprenditore tedesco Ernst Werner von Siemens (1816-1892) – fondatore insieme ai fratelli della casa elettrotecnica Siemens – evidenzia l’accelerazione costante dello sviluppo della civiltà. Infatti, a partire dagli anni cinquanta del XX secolo, i cambiamenti dei processi economici e tecnologici si fanno sempre più repentini e globali. Tuttavia, con il loro procedere si diffonde anche una crisi di valori e di istituzioni politiche della democrazia liberale, scossa da nuovi meccanismi di governo, condizionati dall’inarrestabile flusso tecno-economico.
Alejandro Galliano, docente dell’Università di Buenos Aires, in La máquina ingobernable. Historia de cuatro capitalismos (2024), effettua una revisione schematica di tale dinamica nel tentativo di individuare alcune vie d’uscita. Ispirandosi al concetto di “Industria 4.0” proposto durante la Fiera di Hannover del 2011 da Wolfgang Wahlster, direttore del Centro di Ricerca Tedesco sull’Intelligenza Artificiale, egli analizza quattro fasi del capitalismo, come versioni di uno stesso software. Il concetto si basa sul fatto che ogni sistema economico è un insieme di procedure per la circolazione di materia, di energia e di informazione (ovvero della “ricchezza”), proprio come un software, che deve essere installato su un hardware: in economia, quest’ultimo equivale a un ambiente stabile, con istituzioni, risorse e territori sicuri. Da qui, le diverse versioni che il capitalismo sviluppa per fare fronte alle crisi generate dalla sua disgregazione.
Il capitalismo 1.0, risalente alla prima metà del XIX secolo, riguarda il periodo della “rivoluzione industriale”, quando i flussi mercantili iniziati nel XVII secolo si consolidano attorno a un paradigma tecnologico – la macchina a vapore e, per estensione, la termodinamica – e a un modello d’ impresa capitalista sotto la guida del proprietario. La sua crisi si deve all’ambiente di assoluta instabilità causata dal succedersi di guerre e di rivoluzioni ininterrotte dal 1756 al 1815 , allo sviluppo accelerato della produzione in virtù della meccanizzazione, alla globalizzazione degli scambi e alla proletarizzazione del lavoro. La saturazione dell’offerta genera la Grande Depressione di fine XIX secolo, dove ogni tipo di equilibrio viene alterato.
Il capitalismo 2.0 si basa su un nuovo e più complesso paradigma tecnologico – elettricità, motorizzazione e produzione di massa – e su un tessuto istituzionale reso solido dagli Stati interventisti oltre che dalle grandi imprese “oligopolistiche”, ovvero quelle poche imprese che, con le scelte individuali, possono esercitare un impatto sensibile sul profitto degli altri venditori. Il loro campo d’azione si allarga superando i confini nazionali, incentivando il consumo e il lavoro. Seguono inevitabili tensioni tra le nazioni, la cui conseguenza è la grande crisi di governabilità che si manifesta tra il 1914 e il 1945, periodo funestato da guerre, da rivoluzioni e da crolli finanziari. I problemi si risolvono soltanto durante la Seconda guerra mondiale, con il consolidamento degli Stati Uniti all’interno di un sistema apparentemente bipolare: l’Unione Sovietica, infatti, rivela ritardi economici e tecnologici. Tuttavia, alla fine degli anni Sessanta, la progressiva resistenza all’egemonia statunitense, il lavoro in sofferenza nei grandi impianti industriali, le rivendicazioni della società di massa – studenti, operai, pensionati – producono un’ulteriore crisi a cui il capitale cerca di porre rimedio, approfittando delle reti transnazionali per eludere qualsiasi regolamentazione statale.
Nasce, pertanto, il capitalismo 3.0, basato su modelli aziendali connessi ai flussi finanziari globali, ai cicli economici brevi, alla crescente mercificazione del tempo libero, del turismo, della fantasia attraverso la pubblicità. Tutto ciò determina nuove tecnologie quali microelettronica, informatica, organismi geneticamente modificati, nuove istituzioni internazionali come l’Organizzazione Mondiale del Commercio, il Fondo Monetario Internazionale, la Federal Reserve System, la Borsa di New York, sistemi fiscali nazionali che hanno iniziato a distribuire la ricchezza verso il basso per stimolare la domanda e verso l’alto, con il taglio delle spese sociali, per ridurre le tasse sul capitale incentivando in tal modo gli investimenti.
La crisi del 2008 dà l’abbrivo al capitalismo 4.0, assestato sull’ Intelligenza Artificiale (AI). In esso emerge la precarietà globale dovuta alle variazioni climatiche – ad esempio alluvioni, incendi boschivi, desertificazioni… che spingono intere popolazioni a spostarsi, mutando equilibri sociali – e alla digitalizzazione come paradigma tecno-economico. Quest’ultima ha creato una vera e propria “rottura”: annullamento dei posti di lavoro, ritocco al ribasso di stipendi per i nuovi lavoratori, trasformazione dell’azienda in una startup, accorciamento dei cicli economici, eliminazione delle intermediazioni (logistica, marketing), per citare solo gli esempi più eclatanti.
La conclusione, cui approda Galliano, è condivisibile: individuare una soluzione a detta ingovernabilità che risponde alla contraddizione principale della modernità – ossia vivere meglio avendo mezzi tecnici per farlo, senza però conoscere l’impatto materiale di questi mezzi – sarà compito arduo. Infatti, la precarietà si universalizza, la voce degli esperti si deteriora per un sovraccarico di informazioni, l’incertezza lascia il posto alla pura e semplice ignoranza, i dati si trasformano in soft e i valori sociali diventano hard. Ne sono conferma gli interminabili e contradditori dibattiti avvenuti durante la pandemia e le quotidiane trasmissioni televisive che danno voce a un pubblico di massa, amplificando e distorcendo ogni problema sociale. Potremmo affermare che, nel XXI secolo, la “verità” è una questione del tutto personale, sovente modellata su pregiudizi e stereotipi, su disinformazione deliberata e sulla violazione del copyright.
È ancora presto per avvertire le conseguenze della deglobalizzazione che caratterizza il capitalismo 4.0. Sinteticamente, le possibili vie da percorrere potrebbero essere il riemergere di un certo grado di diversità tecnologica e culturale; lo sviluppo di problemi relativi alla governance mondiale frammentando il capitalismo 4.0 in blocchi concorrenti, privi di egemonia; la nascita di un capitalismo ordinato, secondo la lezione maoista. Per il politologo Roland Lew, il maoismo ha involontariamente gettato le basi per il successivo sviluppo accelerato del capitalismo in Cina, distruggendo gran parte delle istituzioni tradizionali che potevano ostacolare il flusso di capitali, disciplinando sia la società che la leadership comunista alla sopravvivenza e alla flessibilità di fronte alla costante instabilità («¿Cómo alcanzó China su sorprendente solidez?», Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, 10/2004).
Attualmente la politica europea sta discutendo l’aumento della spesa per la difesa militare e il titolo di Iveco Defences Vehicles – IDV, appartenente all’ex galassia Fiat, oggi il maggiore fornitore di veicoli militari per l’esercito italiano – vola in borsa. Da quando è scoppiata la guerra in Ucraina, l’azienda che produce, tra l’altro, il Lince, il blindato contro mine ed esplosivi artigianali, è in forte attivo: solo nel 2024 ha ottenuto il 47 per cento in più rispetto all’anno precedente. Se ciò non bastasse, lo scorso novembre, IDV ha stipulato con Leonardo, società pubblica e prima azienda produttrice di armi nell’Unione Europea, un accordo che prevede un incremento nella produzione di armamenti. In particolare, l’ex Finmeccanica ha realizzato con la tedesca Rheinmetall una joint venture per produrre mezzi militari terrestri tra cui il Main Battle Tank, l’ambito carro armato pesante. Roberto Cingolani, attuale amministratore delegato di Leonardo, nell’intervista rilasciata al Sole 24 ore – parzialmente riprodotta da Eugenio Arcidiacono nell’articolo “Il grande business dei veicoli da guerra” (Famiglia Cristiana 11/2025) – ha previsto un aumento degli ordini del 40-60 per cento e, di conseguenza, l’assunzione di centinaia di persone. Tant’è che sia Leonardo sia Rheinmetall raggiungono in borsa, solo in un anno, rispettivamente quota 75 e 120 per cento.
Sarà la guerra a produrre il capitalismo ordinato in Occidente?