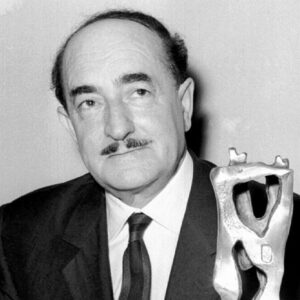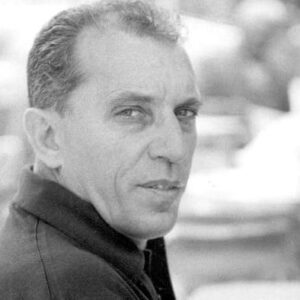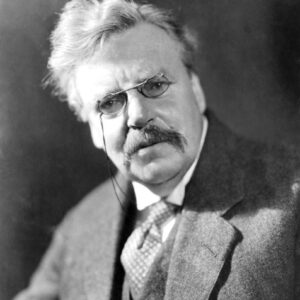Coltivare competenze: il terreno fecondo della letteratura per l’infanzia
L’esperienza di una classe prima in una scuola di periferia
Quando i bambini e le bambine giungono alla classe prima della scuola primaria, ci si aspetta che abbiano già acquisito sufficienti prerequisiti per avviare uno strutturato apprendimento della lettoscrittura. Se per ragioni differenti ciò non è potuto accadere, e i giovanissimi alunni ed alunne presentano difficoltà linguistiche e un pensiero narrativo ancora embrionale, diventa necessario avviare processi di arricchimento funzionali non solo agli apprendimenti scolastici, ma, ancor più, in risposta al diritto di poter acquisire gli strumenti necessari per esprimere i propri pensieri, affermare la propria singolare identità ed essere attivi nell’avviare discorsi e dialoghi. L’esperienza che ci proponiamo qui di raccontare, fra le tante che si sono sviluppate in tutto il territorio nazionale nell’anno scolastico conclusoci a giugno, seppur a macchia di leopardo, riguarda un piccolo gruppo di bambini e bambine al primo anno della scuola primaria in un comune di campagna della bassa padovana. Bambini e bambine vivaci, allegri, giocosi, eppure, con forti difficoltà linguistiche: per appartenenza a gruppi culturali non autoctoni, per difficoltà specifiche, se non anche per provenienze da contesti socio-familiari a forte debolezza relazionale e con scarse stimolazioni culturali. Di fronte a queste difficoltà, il team delle insegnanti decide di proporre un percorso di potenziamento della lingua italiana, in orario extrascolastico, gratuito, a libera adesione. Contattate le famiglie degli undici possibili destinatari, in dieci accolgono senza indugio la proposta. Un’insegnante della classe dà la propria disponibilità a realizzare il progetto di potenziamento, scegliendo di iniziare dai libri illustrati l’avvio di un percorso fra parole, significati e possibili sentieri narrativi.
Come un abbraccio ampio e generoso, la letteratura per l’infanzia si è offerta via privilegiata, con accogliente bellezza fatta di albi illustrati (picture book), con o senza parole (silent book), di generi e stili multiformi, così intrigante da fungere da catalizzatrice di attenzione, da attivatrice di curiosità. Solleticante invito a ripetere, a dire, a dialogare. Libri illustrati scelti con cura, caratterizzati da strutture narrative ripetitive, cumulative, circolari, in grado di invitare all’ascolto, sostenere e allenare l’attenzione, permettere l’acquisizione di nuovi vocaboli e altre espressioni, in un clima accogliente, stimolando la partecipazione dialogica attraverso inviti rassicuranti sollecitanti l’espressione di un parere personale. Al termine di ciascuna lettura la domanda chiave è stata la medesima, come una sorta di mantra letterario: “dimmi, che cosa ti è piaciuto?” (adottando, anche se solamente in parte, il metodo Tell me proposto dall’autore inglese Aidan Chambers, recentemente tristemente scomparso, ben descritto in Il piacere di leggere e come non ucciderlo. Come imparare a leggere con i bambini e i ragazzi, A. Chambers, edizioni Sonda, 2011). Un invito rivolto ad ogni lettrice e lettore ad esprimere la propria personale preferenza, con l’ascolto rispettoso da parte di tutto il gruppo, così che, nella comunicazione condivisa di ogni espressione singola, si possa delineare una sovra-narrazione costituita dalle voci-pensiero di ciascuno. E di letture ne sono state fatte tante: in quindici appuntamenti settimanali, più di sessanta libri hanno trovato spazio di narrazione, di lettura condivisa, di dialogo e confronto, di giochi di smontaggio e rimontaggio della trama, di cambio del finale e, non ultimo, di lettura individuale o in coppia. Le bambine e i bambini, aiutati dai libri stessi che richiamavano la loro attenzione, senza costrizione, ma per effetto di una persuasione di piacevolezza, accoglievano sempre più di buon grado l’invito a sostare nei racconti. A mano a mano che il percorso proseguiva, sviluppavano sempre più l’interesse per le parole e le immagini che uscivano dai libri: chiedevano di rivederli, si animavano nel ricordare trame e personaggi; si divertivano a ripetere a memoria espressioni e modi di dire (ripetere di filato, a gran voce, la lunga filastrocca Stacciaburatta era motivo di orgoglio e forte ilarità corale!), indugiando su ogni nuova proposta letteraria con sguardo sorpreso e attento ascolto. Sempre più cresceva la dimestichezza con l’atto di tenere in mano un libro, di scrutarlo, di condividere un commento con i compagni. Aspettavano con entusiasmo la domanda che, alla fine di ogni libro, sapevano che li attendeva: cosa ti è piaciuto di questo racconto? E lo sguardo si accendeva quando, con tutto se stessi, erano impegnati a dire la loro opinione, ad esprimere la loro idea, tanto che a volte le parole inciampavano una sull’altra dall’emozione ed era difficile mantenere l’impegno di attendere il proprio turno prima di poter parlare.
Gli albi illustrati, dunque, e la lettura condivisa come terreno fecondo, come campo di coltivazione e fioritura, come luogo di partecipazione attiva al gioco di leggere. Gioco? Sì, gioco e non lavoro, non attività didattica, bensì libera azione in cui il piacere dell’ascolto e della lettura condivisa si dipanano come dispositivo pedagogico e arena di gradevole allenamento della mente e delle emozioni, in un clima disteso, in una dimensione di piacevolezza che favorisce lo stare bene insieme e, con esso, la massima disponibilità all’apprendimento di ciò che, attraverso il libro, la storia narrata veicola: percorsi interpretativi, linguaggio comune d’incontro e scambio, scoperta e meraviglia, esperienza del perdersi e ritrovarsi, opportunità di sentirsi a casa nella complessità di questo mondo. Libri, libri e ancora libri. Tanti e diversi nella forma, contenuto e proposta stilistica, in risposta al tentativo di rispettare, almeno in parte, tre delle cinque regole fondanti la biblioteconomia, secondo il pensiero di Shiyali Ramamrita Ranganathan (1892-1972): primo, Books are for use (i libri esistono per essere utilizzati: sono la materializzazione di idee, non oggetti fisici o prodotti di particolari individui); secondo, Every reader his book (a ogni lettore il suo libro: il lettore deve poter individuare il libro che lo interessa maggiormente); terzo, Every book its reader (a ogni libro il suo lettore: il libro deve poter essere fruito per le sue caratteristiche intrinseche). Libri, libri e ancora libri in cui la qualità si esprime in ogni dimensione: dal linguaggio alle immagini, alla storia, dal formato ai materiali editoriali. Disporre della lettura, con continuità e costanza, ha delle ricadute certe e comprovate nello sviluppo e potenziamento del vocabolario, con benefici mnestici, miglioramenti nella competenza fonologica e nella competenza logica e analogica; sostiene la capacità attentiva e inferenziale, nonché la capacità di comprensione dei significati. Tutto attraverso l’atto piacevole del leggere un bel libro insieme, di soffermarsi sulle immagini, di raccogliere le domande spontanee, di sollecitare l’espressione di un parere, di ascoltare con rispetto i pensieri che dalla lettura prendono vita. Ed è stata questa l’esperienza vissuta in quegli appuntamenti, in quegli incontri inizialmente mal visti, per il timore di altre e ancora diverse attività didattiche, e poi, al contrario, attesi e richiesti con fervore. Libri, libri e ancora libri. Per nutrire menti, per emozionare e far pensare, per divertire e far dialogare, per sollecitare e incuriosire, per coltivare stili di partecipazione rispettosa, incoraggiante, attiva. Libri, libri e ancora libri, per una scuola che si fa prossima, che accoglie le fragilità e se ne prende cura. Non basteranno quindici appuntamenti, né sessanta libri: ma è pur sempre un buon inizio!