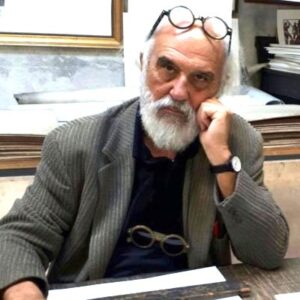Le teorie idrauliche tra Francia e Italia: un confronto storico-giuridico
L’evoluzione normativa in un settore fondamentale per la gestione del territorio
Il problema della sistemazione idraulica dei fiumi ha attraversato la storia europea come questione tecnica, politica e giuridica. La contrapposizione tra la scuola francese e la scuola italiana, sviluppatasi tra XIX e XX secolo, non fu una mera disputa ingegneristica, ma un vero laboratorio di politica del diritto delle acque, destinato a incidere profondamente sulla legislazione e sull’assetto istituzionale degli Stati.ì Centrale è la conferenza di Luigi Miliani, Presidente del Regio Magistrato alle Acque, tenuta a Padova nel 1931, che riflette la maturazione di questo dibattito, mostrando come l’Italia avesse già consolidato la propria scelta in favore della difesa arginale, arricchita da nuovi strumenti di laminazione e invaso, in linea con una politica idraulica accentrata e pianificata.
La teoria francese: gli argini sommergibili
La scuola francese partiva da un principio teorico generale: i fiumi dovevano modellare il proprio alveo in autonomia, attraverso l’azione delle piene e delle magre. Tale dottrina escludeva le arginature continue e preferiva gli argini sommergibili. Le acque di piena avrebbero così dovuto straripare nei terreni laterali, depositando le torbide che servivano alle coltivazioni e mantenendo basso il livello degli alvei.
La ratio di tale scelta era quella di ridurre i costi e lasciare spazio alla dinamica naturale dei corsi d’acqua, con conseguenti benefici di fertilizzazione dei terreni. Tuttavia, le grandi piene della Garonna (1870, 1872, 1875) e quelle successive del 1879, del 1882 e del 1883 misero in crisi detto modello. Gli argini sommergibili furono distrutti prima ancora che le acque potessero defluire. Questo approccio, seppur coerente con una visione di “adattamento alla natura”, non garantiva la sicurezza dei territori agricoli e abitati, rivelandosi insufficiente sul piano della protezione civile e, di riflesso, della legittimazione giuridica dell’azione pubblica.
La teoria italiana: la difesa arginale continua
La scuola italiana, al contrario, sosteneva da sempre l’ineluttabilità dell’arginamento. L’argine era non solo un’opera tecnica, ma anche un simbolo della difesa pubblica del territorio e della continuità tra l’antica tradizione veneziana e lo Stato unitario. Per gli ingegneri italiani non era possibile lasciare le pianure in balia delle acque. La difesa si doveva fondare su argini continui e robusti, capaci di contenere integralmente le piene. Rilevavano inoltre che, costringendo i fiumi in alvei regolari, si facilitava anche il trasporto dei materiali.
Il rappresentante più famoso di tale teoria fu l’ingegnere Carlo Lombardini, che dimostrò con dati empirici che l’arginamento era una “necessità ineluttabile e costituiva il minore dei mali”. Tuttavia, furono osservati dei limiti anche per tale prospettazione. Nel lungo periodo, infatti, a causa dell’accumulo di materiali che si depositavano negli alvei, erano necessari continui innalzamenti arginali (caso emblematico: l’Adige, con argini fino a 12 metri sopra il piano di campagna nel Polesine).
Ricadute giuridiche e istituzionali
La contrapposizione tra i due modelli non era tuttavia solo tecnica. In Francia, la visione più “naturale” discendeva da un minor intervento normativo centralizzato, con margini di autonomia più ampi per i proprietari e le comunità locali. In Italia, invece, la scelta arginale implicava una politica idraulica accentrata, costosa e duratura, con il coinvolgimento diretto del legislatore e dei governi centrali.
Sul piano normativo, questa impostazione italiana trovò riflesso nelle seguenti tappe fondamentali:
1. Codice Civile del 1865, che attribuì allo Stato la titolarità delle acque pubbliche (artt. 427 ss.);
2. Legge 20 marzo 1865, All. F, sulle opere pubbliche, che già assegnava al Governo la competenza sulle grandi sistemazioni idrauliche;
3. R.D. 523/1904, Testo unico sulle opere idrauliche, che consolidò la centralità statale, disciplinando le classi di corsi d’acqua e l’obbligo di manutenzione;
4. R.D. 368/1904 e R.D. 215/1933, che introdusse il concetto di bonifica integrale, legando la difesa idraulica alla valorizzazione agricola ed economica.
Sul piano istituzionale, l’Italia conservò il Magistrato alle Acque di Venezia, eredità della Serenissima, rafforzandolo come organo tecnico-giuridico centrale. Parallelamente sviluppò i Consorzi di bonifica, anch’essi derivanti dalla defunta Repubblica Veneta, strumenti di autogoverno locale ma sempre vigilati e diretti (anche sotto il profilo finanziario, che è quello che conta) dal potere statale.
Il superamento del conflitto: la prevalenza della scuola italiana
Gli eventi storici dimostrarono la maggiore solidità della teoria italiana. Le piene francesi di fine Ottocento segnarono il fallimento pratico del modello degli argini sommergibili. L’esperienza italiana, pur con i suoi limiti (sovraccarico idrostatico e costi crescenti), garantì maggiore sicurezza e divenne riferimento anche per altri Paesi.
Nel Novecento, la sistemazione idraulica in Italia si arricchì di nuove tecniche (sbarramenti montani, bacini di laminazione, serbatoi artificiali, mai teorizzati prima) ma senza mai abbandonare l’impianto concettuale della difesa arginale. Miliani stesso, nel 1931, parlò di una “nuova politica idraulica del Regime”, che non rinnegava l’arginamento, ma lo integrava con strumenti più moderni, confermando così la prevalenza storica e normativa della scuola italiana. L’idraulica, infatti, fu un tema centrale per l’Italia degli anni ’20 e ’30 e non fu un caso che, proprio all’interno degli enti idraulici, troveremo un maggior collocamento dell’allora apparato politicamente orientato.
La nuova politica idraulica del Regime: serbatoi e invasi come strumenti giuridici e tecnici
Nel 1931 Luigi Miliani, nella sua conferenza padovana, parlò espressamente di una “nuova politica idraulica del Regime”. Essa non abbandonava l’impianto tradizionale dell’arginamento, ma lo integrava con strumenti più moderni, quali sbarramenti montani, serbatoi artificiali e invasi regolati.
L’introduzione di serbatoi e invasi rappresentava un’evoluzione rispetto al semplice contenimento delle acque nei fiumi. L’idea era duplice:
– trattenere i materiali solidi nelle alte valli tramite grandi sbarramenti, riducendo l’interrimento degli alvei di pianura;
– laminare le piene, scaricandone le punte in bacini naturali o artificiali, così da ridurre la pressione sugli argini e prevenire rotte disastrose.
Esempi concreti furono i progetti per il bacino dell’Agno-Guà, dove l’invaso di Montebello dimostrò l’efficacia della laminazione, e i piani di diversione dell’Avisio nei laghi di Levico e Caldonazzo, che univano la difesa idraulica alla produzione agricola ed energetica.
Questa evoluzione tecnica si rifletté anche sul piano normativo. Il R.D. 523/1904 già disciplinava opere di contenimento e regolazione dei fiumi, ma la stagione degli anni Trenta inaugurò un diverso approccio: non più soltanto argini e alvei, bensì un sistema complesso di opere pubbliche integrate. Il successivo R.D. 215/1933 sulla bonifica integrale recepì pienamente questo paradigma, legando la costruzione di serbatoi e invasi non solo alla difesa dalle piene, ma anche alla valorizzazione agricola (irrigazione) alla salubrità dei luoghi (salute) e alla produzione energetica (idroelettrico). La difesa idraulica entrava così a far parte di una più ampia politica economica e sociale, in cui il diritto delle acque assumeva un carattere programmatico e polifunzionale.
Dal punto di vista giuridico, dunque, gli invasi e i serbatoi non erano più meri strumenti idraulici, ma divennero funzionali tanto alla sicurezza quanto allo sviluppo economico. La nuova politica idraulica del Regime segnava pertanto il passaggio da una concezione “difensiva” del diritto delle acque (arginamento) a una concezione integrata e polifunzionale, che resta il presupposto delle moderne legislazioni in materia di bacini idrografici e gestione delle risorse idriche.
Conclusioni
Il confronto tra la scuola francese e quella italiana mostra come la gestione dei fiumi non sia mai stata questione meramente tecnica, ma espressione di scelte politiche e giuridiche fondamentali. La scuola francese, pur raffinata sul piano teorico, si rivelò impraticabile di fronte alla realtà delle piene e alla crescente pressione antropica sui territori. La scuola italiana s’impose come modello realistico, capace di coniugare tecnica, istituzioni e diritto, influenzando la legislazione e l’assetto amministrativo fino ai nostri giorni.
Le attuali normative sulla difesa del suolo e la gestione integrata dei bacini idrografici (L. 183/1989; D.Lgs. 152/2006) sono ancora debitrici di quella scelta storica, che consacrò l’arginamento come principio giuridico e politico di difesa integrale del territorio.
Immagini del Canale Roncajette, nel territorio di Padova