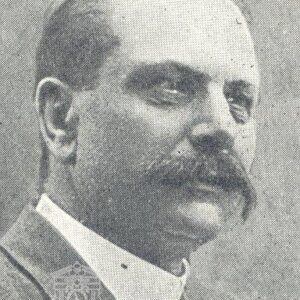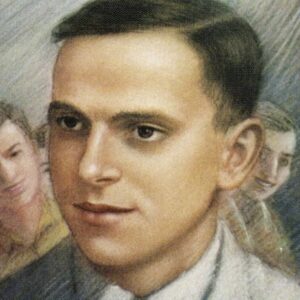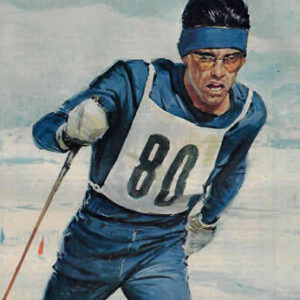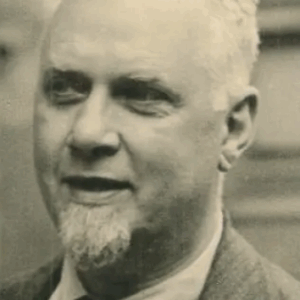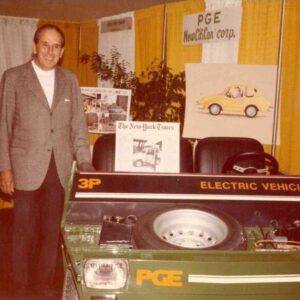Il centenario della scomparsa di Giuseppe Corazzin, sindacalista cristiano e antifascista
La vicenda biografica e politica del trevigiano Bepi Corazzin, così lo chiamavano gli amici, è simile e parallela per molti versi a quella dell’onorevole Sebastiano Schiavon: morì infatti nel 1925, a soli 35 anni, per una peritonite, dopo aver contratto la malaria nella guerra di Libia e una grave ferita alla gamba sul fronte della prima guerra mondiale (dove fu decorato al valor militare), e dopo aver subito nel 1924 un pestaggio fascista, a causa del quale la moglie Emilia perse il bimbo che portava in grembo.
Corazzin fu anzitutto un credente tutto d’un pezzo: il suo laboratorio formativo fu costituito dal circolo della gioventù cattolica da lui stesso fondato, quindicenne, nel suo paese natale di Arcade. Già nel 1909 fu cooptato nella Direzione diocesana di Treviso di cui divenne propagandista. A soli 24 anni fu nominato primo direttore laico del settimanale diocesano La Vita del popolo. In quell’occasione il vescovo mons. Longhin, ora beato, gli donò un’edizione di pregio della Rerum Novarum con la seguente raccomandazione: “In una mano il Vangelo e questa enciclica nell’altra. Avanti sempre con coraggio: il vescovo è con voi”.
Corazzin fu giornalista, fondatore e direttore di giornali: firmava spesso i suoi articoli con lo pseudonimo di Miles, a indicare la sua tempra combattiva. All’inizio del 1915, nell’acceso dibattito tra interventisti e neutralisti, si schierò per una pace – come direbbe Papa Leone – “disarmata e disarmante”. Scrisse tra l’altro: “Voler la guerra senza ragioni incombenti è un voler far versare al nostro popolo un tributo luttuoso, gravissimo, incomputabile di sangue, di lacrime, di sofferenze”. Egli fu altresì un pubblico amministratore, presidente tra l’altro dell’Amministrazione provinciale di Treviso dal 1920 al ’22 come esponente di spicco del Partito popolare di don Sturzo.
Ma si distinse soprattutto come grande sindacalista, infaticabile promotore e organizzatore di leghe bianche nella Marca trevigiana già nell’anteguerra, aiutando i contadini a superare atteggiamenti sia di astiosa ribellione sia di inerte rassegnazione. Fu a partire dall’amore per la sua gente, e non da astrazioni dottrinarie, che Corazzin perseguì i suoi nobili obiettivi di giustizia sociale fidando nel trionfo del diritto. Del resto egli aveva grande competenza in agricoltura, essendosi diplomato nel prestigioso Istituto enologico di Conegliano. Fu tra i fondatori, nel 1910 a Cittadella, del Sindacato veneto tra i lavoratori della terra, che aggregava le diocesi di Treviso, Padova e Vicenza, e venne posto alla guida dell’Ufficio cattolico del lavoro di Treviso.
A seguito delle ferite riportate in guerra trascorse la sua convalescenza a Milano, ottenendo il favore del cardinal Ferrari e prodigandosi, dopo la rotta di Caporetto, nell’assistenza ai profughi veneti. Va ricordato, nel periodo bellico, il suo rilevante apporto sul piano nazionale nella costituzione di federazioni professionali, culminato con la sua partecipazione alla fondazione, nel maggio 1918, della Confederazione italiana dei lavoratori, antesignana della Cisl. Inoltre nel 1919 partecipò a Parigi alla costituzione dell’Internazionale sindacale di ispirazione cristiana.
Rientrato a Treviso da Milano nel 1919, Corazzin si trovò a riorganizzare il movimento sindacale dovendo fare i conti con le inenarrabili devastazioni materiali e morali prodotte dal conflitto nell’intera provincia, con conseguenti disordini e moti di piazza. Egli fu messo alla guida dell’Unione provinciale del lavoro che contava anche diverse sezioni mandamentali. Fondò pure l’Unione reduci di guerra a favore degli ex combattenti e mutilati. Le leghe bianche lievitarono nella Marca trevigiana fino a circa 250 con 110.000 organizzati. Corazzin e i suoi amici avviarono nel febbraio 1920 laboriose trattative con la neocostituita Associazione agraria, che aggregava i grandi proprietari terrieri, per migliorare radicalmente i vecchi patti colonici semifeudali che perpetuavano la subalternità dei contadini ai padroni. La prospettiva perseguita a medio-lungo termine era di trasformare mezzadri e fittavoli in piccoli proprietari autonomi. Tuttavia gli agrari boicottarono sistematicamente le trattative condotte con il sindacato bianco. Non rimase che dar vita a una massiccia ma pacifica mobilitazione delle leghe contadine, che ebbe risonanza nazionale e vide scendere in campo con affollati comizi, con l’intervento degli arditi bianchi, circa 200.000 contadini di tutta la provincia. Finalmente nel giugno 1920 si tenne in prefettura l’incontro risolutivo che portò all’approvazione dei nuovi patti agrari, nei quali furono riconosciute, se non tutte, le principali richieste del sindacato bianco, ossia la durata novennale del contratto, il risarcimento delle migliorie introdotte dai conduttori, l’abolizione di onoranze e corvées, il diritto di prelazione nelle vendite, l’esclusione di ogni arbitrario aumento del canone d’affitto.
Molti agrari però si rifiutarono di firmare il capitolato agrario dell’11 giugno 1920 e, anzi, denunciarono soprattutto i capilega più combattivi alla magistratura, procedendo allo sfratto di numerose famiglie contadine. Per fronteggiare la difficoltà di sbocchi migratori, Corazzin riuscì a collocare tra il 1923 e il ‘24 parecchi coloni trevigiani nelle zone di bonifica dell’Agro romano. Ben presto gli agrari cominciarono a ricorrere allo squadrismo fascista, facendo affluire spesso da fuori provincia le camicie nere per spedizioni punitive. Nel famigerato assalto di Treviso del luglio 1921 da parte di fascisti provenienti da tutto il Veneto fu distrutta, tra l’altro, la tipografia de Il Piave, primo importante periodico fondato e diretto da Corazzin. Esso uscì qualche giorno dopo in formato ridotto intitolando “Esce mutilato per la barbarie distruggitrice dei così detti restauratori dell’ordine”.
All’inizio del 1923, tuttavia, Corazzin fondò L’Idea, settimanale dell’azione sociale cristiana. Dalle sue pagine egli tentò fino all’ultimo, malgrado gli ormai innumerevoli sequestri e censure, di lottare contro il fascismo a difesa della libertà di stampa, delle leghe bianche e dell’attività politica e cooperativa di ispirazione cattolica. Dovette sovente rintuzzare le intimidazioni, le calunnie e le violenze verbali del quotidiano fascista di Treviso Camicia nera. In particolare il giornale di Corazzin denunciò le ripetute pressioni fasciste fatte per costringere le amministrazioni comunali legate al Partito popolare a dimettersi.
Bepi Corazzin, in definitiva, fu un cattolico integrale ma non integralista: nella fede cristiana rinvenne la fondamentale motivazione etica della sua militanza, ma seppe anche maturare una concezione dell’autonomia riguardo ai mezzi e alle forme dell’impegno sociale, superando il confessionalismo prebellico. Va sottolineata poi la modernità del concetto corazziniano di democrazia, secondo il quale essa, sulla scia del pensiero di Toniolo, per essere autentica doveva estendersi alla vita socioeconomica prima ancora che alla sfera politica. Corazzin respinse decisamente il progetto corporativo fascista per le sue tendenze monopolistiche, per la sua subordinazione al regime e perché non avrebbe consentito le giuste rivendicazioni delle classi più deboli. Entrato nel 1925 nel Consiglio nazionale del Partito popolare, dichiarò nel congresso di Roma di ritenere ormai inadeguata la protesta aventiniana. Suggerì perciò le dimissioni dei deputati dell’opposizione per assumere più incisive forme di lotta contro la dittatura fascista, superando la tattica astensionistica. La sua proposta però non fu recepita dalla maggioranza del Partito.
Dopo la sua morte prematura, avvenuta il 18 novembre 1925, la stampa trevigiana di ogni colore politico tributò un corale omaggio al forte organizzatore cristiano, riconoscendone le idealità che ne avevano contrassegnato il pensiero e l’azione.