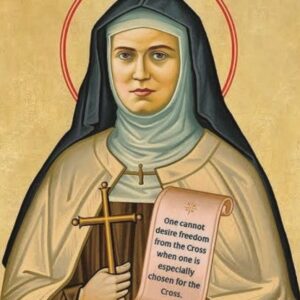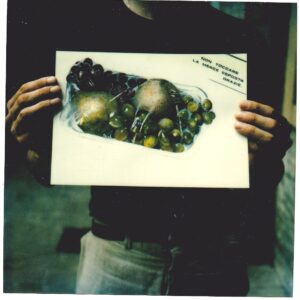Il Giudizio Universale di Jacopo Tintoretto: teologia della visione e potenza della Grazia
Nell’ambito di un ciclo di incontri su arte e fede promosso dal patriarcato di Venezia, il 4 novembre scorso Ester Brunet, già autrice de “La Bibbia secondo Tintoretto” (2012), ha tenuto la sua lezione su “Il Giudizio Universale di Jacopo Tintoretto” proprio nella chiesa di Santa Maria dell’Orto dove si trova il dipinto e dove, tra l’altro, il grande pittore veneziano è sepolto. Si tratta di un “telerone” di ben quattordici metri e mezzo di altezza che vuole rappresentare la fine dell’era sub gratia, collocato nella parete absidale destra proprio di fronte a quell’altro, sempre di Tintoretto, che mostra “La consegna a Mosè delle tavole della legge”, che sta invece a significare l’inizio dell’era sub lege. Ci troviamo così dentro a uno di quei dibattiti religiosi centrali del ‘500 su come possano essere giustificati e salvati i peccatori. “Il telero del Giudizio Universale di Tintoretto è veramente impressionante – sottolinea fin da subito la Brunet – e ci mostra la visionarietà e la forza travolgente del pittore veneziano”.

Il dipinto, che ha seri problemi di conservazione, tanto che la parte bassa risulta oggi molto scura e quasi illeggibile, “si presenta apparentemente caotico, al punto da risultare quasi respingente”.
Cosa vediamo? “In alto il Cristo con Maria e san Giovanni Battista, in basso quattro corone di santi, più in basso ancora un groviglio di corpi giudicati che stanno per assurgere e che lascia spazio a un affondo dominato dal profilo di un’enorme, impressionante cascata, che fa sì che mentre corpi salgono, altri vengono trascinati giù. C’è quindi un movimento ascendente e uno discendente e il nostro sguardo è invitato a penetrare nella parte più tenebrosa del dipinto”.
Andando a vedere i dettagli partendo dal basso, cioè dal luogo riservato alla resurrezione della carne, troviamo cadaveri che prendono vita dalla terra. In primo piano un uomo dalle cui dita stanno spuntando dei verdi ramoscelli, come anche dall’incavo dell’ascella di un altro, quasi citazione letterale dalla Prima Lettera di Paolo ai Corinti (capitolo 15, 35-39 e 42-44), in cui l’apostolo spiega il modo della resurrezione dei corpi, usando proprio una metafora vegetale.
Ma qualcuno dirà: “Come risuscitano i morti? E con quale corpo ritornano?”. Insensato, quello che tu semini non è vivificato se prima non muore e, quanto a quello che tu semini, non semini il corpo che deve nascere, ma un granello nudo, forse di frumento o di qualche altro seme; e Dio gli dà un corpo come lo ha stabilito e a ogni seme il proprio corpo. Non ogni carne è la stessa carne, ma altra è la carne degli uomini, altra la carne delle bestie, altra quella degli uccelli, altra quella dei pesci.
Così pure della risurrezione dei morti. Il corpo è seminato corruttibile e risuscita incorruttibile; è seminato ignobile e risuscita glorioso; è seminato debole e risuscita potente; è seminato corpo naturale e risuscita corpo spirituale. Se c’è un corpo naturale, c’è anche un corpo spirituale.
Paolo cioè paragona il nostro corpo a un seme che cadendo a terra muore e che rinasce diverso, rinascendo corpo spirituale. E allora ecco che le piantine che escono dalle dita di questi personaggi vanno all’insù. Gli empi invece restano appesantiti e precipitano, diversamente dagli eletti, che salgono trascinati da una forza che li spinge verso l’alto.

(Tintoretto, Giudizio Universale, particolare della parte inferiore del telero)
Tra gli eletti troviamo un rimando a un personaggio con la pelle scura presente anche nel Giudizio della sistina di Michelangelo, cui Tintoretto si riferisce, Giudizio che il pittore veneziano senz’altro visionò in copia dipinta, perché sappiamo che Tintoretto non si spostò mai da Venezia. Nella sistina gli eletti dalla pelle scura sono due e la loro presenza è stata messa in relazione con la bolla “Sublimis Deus” del 1537 con la quale il papa di allora, Paolo III, condannava con forza le tesi razziste e la schiavizzazione degli indigeni nel Nuovo Mondo, e non solo. Anche Tintoretto dunque sembra far fuori quelle tesi inconciliabili col messaggio evangelico.
Proseguendo nella lettura del dipinto, vediamo che a destra domina la forza imponente dell’acqua, rappresentata come un’onda travolgente, una piena minacciosa che inonda tutta la terra e che, riversandosi, trascina con sé i dannati. Potremmo chiamarla “un’acqua alta”, dato che i veneziani la forza dell’acqua la conoscono bene, perché sull’acqua Venezia ha sì trovato successo, ma sa anche quanto possa essere pericolosa. L’acqua è infatti elemento informe per eccellenza e proprio in San Marco, non a caso, nel polittico della Creazione Dio per ben tre volte ordina l’acqua. “Tintoretto – sottolinea la Brunet – immagina il Giudizio Universale come un ritorno dal cosmo al caos. Se la Creazione è stata un passaggio dal caos al cosmo che inizia dall’acqua, questo nuovo diluvio escatologico sembra la fine della storia”. Un altro riferimento è il Libro della Sapienza (5, 22), dove si legge a riguardo della punizione degli stolti che “Infurierà contro di loro l’acqua del mare
e i fiumi li sommergeranno senza pietà”. E sempre dal Libro della Sapienza (14,1-5) si giustifica la presenza in questo Giudizio di Tintoretto di una barca trascinata dalla corrente, che è come una nave che solca l’onda. Si tratta della nave degli stolti, soggetto molto rappresentato, soprattutto nella pittura nordica (Bosch, Durer), che si rifà alla “Nave dei folli” scritto da Sebastian Brant (1494), operetta satirica in versi che è una sorta di compilazione dei peccati, dei difetti e delle meschinità umane. “Ma in Tintoretto l’acqua non ha solo lo scopo di sommergere i malvagi. Secondo l’Apocalisse infatti nel giorno del giudizio i morti annegati saranno restituiti dal mare, come si vede anche nel Giudizio Universale di Torcello, altro riferimento iconografico sicuro di Tintoretto”.
“Allora anche in Tintoretto non tutti vengono trascinati giù dall’acqua. Sullo sfondo – fa notare la Brunet – vediamo infatti una donna che viene condotta fuori dall’acqua”.
Dove quest’acqua porta i corpi? Verso dove? “Entriamo qui nella parte purtroppo più illeggibile del dipinto, ma comunque vediamo che vengono portati verso un bagliore di fuoco che c’è a destra, in un Inferno solo accennato, come del resto nell’opera di Michelangelo. Diciamo che Tintoretto lascia il grosso dell’Inferno fuori, che lo lascia all’immaginazione. E come nella sistina vediamo la zattera di Caronte, ripresa dall’Inferno dantesco, qui l’acqua diventa Acheronte e sulla zattera un demone sta scaraventando dentro un dannato, mentre poco più in là troviamo uno dei figli di Cerbero, dal muso canino, che sta azzannando il capo di una giovane nuda”.
Passando alla parte superiore del dipinto, vediamo tutto il cielo indorato da una pioggia di luce che emana dall’alto e alcune figure femminili che sono personificazioni delle virtù. “Ben riconoscibile è la Carità, che come di consueto si prende cura di neonati. Perché la Carità allatta? Perché l’allattamento non è semplicemente dare qualcosa a qualcuno, ma è dare se stessi a qualcuno, è una madre che dà da mangiare se stessa, possiamo dire, e questo diventa simbolo cristiano della Carità, che, come dice san Paolo, è la più grande delle virtù”. Sotto di lei, altre due figure femminili. E saremmo tentati di dire che si tratta della Fede e della Speranza (avremmo cioè così rappresentate le tre virtù teologali), se non fosse che queste due si abbracciano e quindi probabilmente siamo di fronte a una rappresentazione del Salmo 85, dove si legge che “giustizia e pace si baceranno”; abbraccio che quindi giustifica in Cristo i due corpi apparentemente inconciliabili. “Certamente qui Tintoretto si rifà a un testo dello Pseudo-Bonaventura da Bagnoregio, in cui la Misericordia e la Pace si lamentano di fronte a Dio, dicendo che non è possibile che tutti gli uomini dopo la caduta dei progenitori finiscano all’Inferno. E allora in questo racconto leggendario Dio decide di mandare suo figlio per superare questa dicotomia. La condanna alla morte non è superata, ma la morte non è la fine della storia perché il Verbo ha permesso la riconciliazione di queste virtù. E allora in alto troviamo la loro ricomposizione: della Carità, della Giustizia, della Misericordia, della Pace”.
Cristo in alto, a destra e a sinistra Maria e san Giovanni come nelle deesis bizantine, altro grande riferimento di Tintoretto, vicino a Maria il giglio della Misericordia, associata al Battista la spada della Giustizia. Il Cristo è giudice misericordioso e riesce a tenere insieme queste virtù solo apparentemente incompatibili.
C’è infine la questione del committente. Due ipotesi sono state formulate, a partire da un personaggio presente tra la schiera degli eletti. Secondo una prima ipotesi si tratterebbe di un omaggio a Gasparo Contarini, che aveva tentato un accordo con Melantone sulla questione della giustificazione e che per questo fu accusato di essere troppo filo-protestante. Secondo una seconda ipotesi invece si tratterebbe di un membro della famiglia Grimani. Sappiamo che entrambe queste famiglie facevano parte di quella corrente che aveva cercato un confronto con le chiese riformate e questo spiega forse anche l’ultimo sorprendente particolare di questo telero. Nei Giudizi Universali c’è sempre un san Michele Arcangelo che pesa le vite e quindi le opere di chi poi sarà destinato al Paradiso o alla dannazione eterna. Che cosa succede invece nel telero del Tintoretto? “Succede che troviamo un san Michele Arcangelo con una bilancia senza piatti, quindi di fatto inutile. Dobbiamo leggervi una squalificazione tout court delle buone opere? “Io non mi spingerei a tanto – conclude la Brunet -. L’intento di Tintoretto era di porre l’accento sul primato della Grazia contro ogni tentazione di considerare le buone opere come esito di uno sforzo puramente personale o peggio ancora come una forma di acquisto della salvezza e non come effetto dell’azione dello Spirito, frutto della Grazia, risposta grata all’amore gratuito di Dio che sempre precede”.
Un dipinto, questo di Jacopo Robusti detto Tintoretto, che ancora oggi ci parla della fragilità dell’uomo e della forza redentrice della Grazia divina.

(Tintoretto, Giudizio Universale, particolare di san Michele Arcangelo che tiene in mano una bilancia senza piatti)