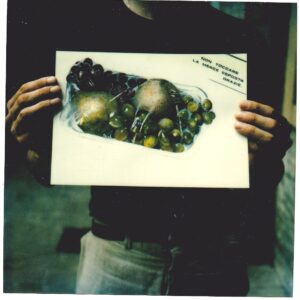La “Favola di Natale” di Giovanni Guareschi: il celebre racconto dello scrittore è una lettura sempre toccante, istruttiva e attuale
Natale nella poesia e nella narrativa: non c’è che da sfogliare antologie, diari, libri di memorialistica. Per limitarci al Novecento, basta rivedere quella elegante pubblicazione del 1962 (poco di una plaquette), antologia minima, ma quanto mai sostanziosa e ricca, edita da Scheiwiller per avere una esemplare testimonianza di come tanti autori hanno “sentito” e interpretato in versi l’evento più importante della storia, tale da definire un prima e un dopo: da Clemente Rebora a Eugenio Montale, da Camillo Sbarbaro a Giuseppe Ungaretti, da Carlo Betocchi ad Alfonso Gatto, da Diego Valeri a Vittorio Sereni, da Biagio Marin a Salvatore Di Giacomo, da Giorgio Orelli a Pier Paolo Pasolini, da Thomas Eliot a Ezra Pound, da Hans Carossa a Paul Claudel, da Miguel de Unamuno a Charles Peguy.
Quanto alla prosa, che dire, se non fare nomi emblematici quali quelli di Domenico Giuliotti e Giovanni Papini, Mario Rigoni Stern e Primo Levi, Dino Buzzati e Giulio Bedeschi, Charles Dickens e Agatha Christie, Curzio Suckert Malaparte e don Primo Mazzolari? Per non tacere del prete scrittore caro a tanti di noi: don Francesco Fuschini, con quel delicato, profondo racconto (“Il mio amico Gerardo”) di un Natale di guerra trascorso in quelle valli romagnole e ferraresi, habitat che lo aveva visto bambino (amato e cantato nelle sue pagine), tra fiocinini e cacciatori, barchini e reti, cani e doppiette – racconto apparso nell’immediato dopoguerra sul settimanale L’Argine.
Ma un caso speciale – ci pare – è quello di Giovannino Guareschi, uomo di fede e di libertà, di valori e di sentimenti, che al Natale ha dedicato non poche pagine della sua grande opera, rivelando il suo profondo, sentito, cristianesimo fin dai tempi del lager nazista, confermandolo in seguito nell’esperienza della galera italiana.
Fra gli Italienische Militar-Internierte (IMI) del Terzo Reich, dalla Polona alla Germania, aveva per la prima volta manifestato pubblicamente la sua fede religiosa in quella irrisione a chi lo teneva in carcere, che lui chiamò “signora Germania”, scrivendo nel 1944 nel Lager di Beniaminowo: “Signora Germania, tu mi hai messo fra i reticolati, e fai la guardia perché io non esca. È inutile, signora Germania: io non esco, ma entra chi vuole. Entrano i miei affetti, entrano i miei ricordi.
E questo è niente ancora, signora Germania: perché entra anche il buon Dio e mi insegna tutte le cose proibite dai tuoi regolamenti. Signora Germania, tu frughi nel mio sacco e rovisti fra i trucioli del mio pagliericcio. È inutile, signora Germania: tu non puoi trovare niente, e invece lì sono nascosti documenti d’importanza essenziale. La pianta della mia casa, mille immagini del mio passato, il progetto del mio avvenire.
E questo è ancora niente, signora Germania. Perché c’è anche una grande carta topografica al 25.000 nella quale è segnato, con estrema precisione, il punto in cui potrò ritrovare la fede nella giustizia divina. Signora Germania, tu ti inquieti con me, ma è inutile. Perché il giorno in cui, presa dall’ira, farai baccano con qualcuna delle tue mille macchine e mi distenderai sulla terra, vedrai che dal mio corpo immobile si alzerà un altro me stesso, più bello del primo. E non potrai mettergli un piastrino al collo perché volerà via, oltre il reticolato, e chi s’è visto s’è visto.
L’uomo è fatto così, signora Germania: di fuori è una faccenda molto facile da comandare, ma dentro ce n’è un altro e lo comanda soltanto il Padre Eterno. E questa è la fregatura per te, signora Germania”.
In queste espressioni di fede e di senso di libertà, come frequentemente accade con Guareschi, ci troviamo un rimando-collegamento, per così dire, al messaggio evangelico. Riferisce infatti Matteo (10,24-33): “Non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non possono uccidere l’anima…”. E ancora, in altra occasione (la galera italiana), lo scrittore avrebbe detto: “Libertà è dovunque vive un uomo che si sente libero”!…
Allora, se provassimo a far Natale con Guareschi? Se non altro per respirare un po’ di aria pulita, alla luce della fede, della speranza, della tradizione, con qualche soffio di umorismo e aliti di poesia. Perché se ne ha abbastanza di sortite demenziali sulla rinuncia a questo e a quello, per rispetto delle altrui tradizioni, usi, costumi, eccetera eccetera. Come se non avessimo l’obbligo morale di rispettare in primis le “nostre” tradizioni, i nostri usi e costumi, che non vogliamo certamente imporre a nessuno, ma che in casa nostra avremo pure il diritto di ricordare, di coltivare, di celebrare!
Giovannino, dunque. Perché non è frequente trovare, in un’opera letteraria la presenza del Natale espressa con un’intensità di fede e con un soffio di delicata poesia, come nelle pagine dell’autore della Bassa. Che nell’incarnazione di Dio che si fa uomo per il bene degli uomini, ci credeva a tal punto da scrivere addirittura due “favole di Natale”, e di dedicare all’evento diverse altre pagine in vari libri, a incominciare da quel finale di “Don Camillo” (il primo volume all’insegna del Mondo piccolo – Rizzoli 1948) nel quale Peppone, in una brumosa serata novembrina, andato in canonico a confidare certe sue preoccupazioni al parroco, si trova fra le statuine del presepe. Il pretone sta lavorando infatti, in forte anticipo sui tempi, perché – dice – Natale arriva in fretta cogliendoti magari di sorpresa.
Eccolo, allora, ricevere la visita del sindaco e capo dei rossi mentre sta ripulendo e sistemando le statuine del presepe… Don Camillo prende il Bambinello e un pennellino affidandoli a Peppone per i ritocchi necessari di pulizia e di colore. Incombenza alla quale il nostro omone non si sottrae, anzi… E uscendo – annota Guareschi – “Peppone si trovò nella cupa notte padana, ma oramai era tranquillissimo perché sentiva ancora nel cavo della mano il tepore del Bambinello rosa”.
Il finale del racconto è all’insegna di una fede semplice e toccante: “Il fiume scorreva placido e lento, lì a due passi sotto l’argine, ed era anch’esso una poesia: una poesia cominciata quando era cominciato il mondo e che ancora continuava e per arrotondare e levigare il più piccolo dei miliardi di sassi in fondo all’acqua, c’eran voluti mille anni. E soltanto fra venti generazioni l’acqua avrà levigato un nuovo sassetto. E fra mille anni la gente correrà a seimila chilometri l’ora su macchine a razzo superatomico e per fare cosa? Per arrivare in fondo all’anno e rimanere a bocca aperta davanti allo stesso Bambinello di gesso che, una di queste sere, il compagno Peppone ha ripitturato col pennellino”.
A proposito del “Mondo piccolo”, poi, è significativo il racconto “La cellula di mezzanotte”. Polemicamente, Peppone e i suoi si riuniranno, in alternativa alla liturgia in chiesa, a leggere i “testi sacri” del comunismo, Marx, eccetera. Se non che don Camillo si presenterà, inaspettato ospite, dai rossi e celebrerà messa sull’altare da campo che si è portato dietro. Toccante, coinvolgente racconto, dal quale emerge una fede mai sopita.
Ecco il passo: Peppone sta per leggere (propinare) ai compagni, dunque, “un magistrale profilo di Mao Tsetung”, quando…
“la porta si spalancò ed entrò un grosso uomo intabarrato che, passando come un panzer tra le panche, arrivò davanti al palco sul quale stava Peppone, salì la scaletta e, spalancato il tabarro, cavò fuori una vecchia cassetta grigioverde che mise con violenza sul tavolino di Peppone. Tutti quelli delle prime file di panche la conoscevano a memoria, quella vecchia cassetta grigioverde, perché l’avevano vista tante volte in montagna [durante la resistenza, ndr], quando don Camillo rischiava le pallottole per arrivare fin lassù. E si alzarono. Don Camillo sollevò il coperchio della cassetta ed ecco sorgere l’altarino da campo. Peppone intanto si era alzato ed era sceso dal palco. Don Camillo si volse un momento e fece un grugnito. Allora, caracollando, lo Smilzo salì la scaletta e arrivò al fianco di don Camillo, come aveva fatto tante volte lassù. Poi lo aiutò a vestirsi, accese le candele e, quando fu ora, si inginocchiò a lato dell’altare. Fu una Messa povera, roba da soldati, quasi clandestina. Ma avevano spento le luci della sala e le candele dell’altarino facevano un bell’effetto. E poi, le note dell’organo della chiesa, quelle che erano venute ad appiccicarsi ai vetri delle finestre del salone, erano ancora vive e palpitanti e così c’era anche una lontana musica nell’aria…”.
Di riferimenti al Natale ne troviamo anche in chiave umoristica: nello “Zibaldino”, per esempio, in un racconto esilarante, dove i figli dell’autore, Albertino e Carlotta devono imparare ciascuno una poesia da recitare il 25 dicembre, e si fanno i dispetti, l’una recitando quella del fratello, l’altro, quella della sorella, e tutto il vicinato nel frattempo, sentendo mandare a memoria ad alta voce i versi, ha in parte imparato anch’esso!
Ma ci sono tre momenti-episodi della vita dell’autore nei quali il Natale si rivela più che mai presente, significante, coinvolgente, consolante.
Ne “Il magone dell’antenato”, racconto apparso sul settimanale Oggi nel dicembre 1967, poi raccolto in “Chi sogna nuovi gerani?” (Rizzoli 1993), l’autore scrive dell’annuale visita alla tomba dei genitori nel piccolo cimitero di Marore, alle porte di Parma. Lì riposano sua madre, la maestra vecchia (Lina Maghenzani), e il padre Primo Augusto, e sulla tomba c’è il “monumento”, cioè un’opera in bronzo dello scultore Luigi Froni, a Gramigna, che non è una sorta di Franti del “Cuore” di deamicisiana memoria, bensì, “l’ultimo della classe”, di cuore buono, tanto da ricordare la vecchia maestra. Ed ecco come, prima di avviare il muto colloquio coi suoi morti, che ci immerge in quella meravigliosa “comunione dei Santi” del Credo cattolico, incomincia Guareschi.
“Dicembre 1967. La sosta di Natale. Per noi della vecchia generazione, pure disincantati da guerre, relativi dopoguerra, nonché da altre esperienze, il traguardo sentimentale d’ogni anno rimane il Natale. Natale è per noi la tappa annuale del lungo e duro cammino: l’albero frondoso all’ombra del quale, usciti dalla strada assolata e polverosa, ci fermiamo un istante per raccogliere le nostre idee, i nostri ricordi, e per guardarci indietro. E sono assieme a noi i nostri cari: i vivi e i morti. E nel nostro Presepino d’ogni Natale rinasce, col Bambinello, la speranza di un mondo migliore…”.
Sarebbe stato l’ultimo Natale di Giovannino. Quello del 1968 non avrebbe fatto in tempo a vederlo: il 22 luglio, infatti, avrebbe cessato di vivere, colpito da un infarto nella casa di Cervia dove trascorreva i mesi estivi.
Dopo il lager nazista, lo scrittore avrebbe vissuto, come noto, pure l’esperienza della galera italiana, per la condanna subìta nel 1954 nel processo per diffamazione a mezzo stampa intentatogli da Alcide De Gasperi: 409 giorni nel carcere di San Francesco nel Prato, antico complesso conventuale francescano risalente al tredicesimo secolo, a Parma. E lì, ecco un Natale confortante, perché… illuminato (anche) da una significativa presenza, quella di padre Paolino Beltrame Quattrocchi, monaco trappista, già cappellano militare, medaglia d’argento, ed esponente di spicco della Resistenza, che Guareschi aveva conosciuto al ritorno dai lager. Per completezza di informazione, va sottolineato come i genitori del religioso, Luigi (catanese) e Maria Corsini (fiorentina) costituiscono la prima coppia di sposi proclamati beati nel 2001.
Padre Paolino, a guerra finita, era uno dei responsabili della Pontificia Opera Assistenza (POA), che in quel di Pescantina accoglievano i prigionieri italiani reduci dai lager tedeschi, fornendo assistenza, con generi di conforto, informazioni, eccetera, e lì, in un giorno di inizio settembre del 1945, sceso da una tradotta, aveva fatto sosta anche l’ex internato numero di matricola 6865.
Un incontro “normale”, per così dire, ma che in circostanze straordinarie si sarebbe ripetuto nove anni dopo, come raccontato in prima battuta a chi vi parla dallo stesso monaco. Saputo che lo scrittore si trovava nel carcere di San Francesco, padre Paolino aveva combinato la sostituzione del cappellano per poter celebrare lui la messa di quel 25 dicembre 1954 e parlare al cuore di Giovannino. Come? Lo riferì lui stesso: “preparai con particolare cura il ‘sermone’ cercando di introdurvi uno dei più tipici momenti natalizi di Don Camillo e Peppone, ma velandolo in modo che solo lui potesse cogliere l’allusione, senza creare imbarazzo nei confronti degli altri detenuti”. E fu la citazione, adattata ovviamente per l’occasione, della pagina finale di Don Camillo, citata in precedenza.
“Terminata la messa” concludeva il religioso “mentre in sacrestia deponevo le vesti sacre e mi accingevo a chiedere al capo-guardia che mi facesse venire il detenuto Guareschi Giovanni, lui si precipitò dentro, mi buttò le braccia al collo e per un lungo momento abbandonò il capo sulla mia spalla, lasciandovi la traccia di due lacrimoni. Lacrime preziose di pace e di gioia e di libertà. In ‘un fondo di dolce sofferenza’. Non ci dicemmo una parola. Solo un ‘Grazie’ con voce velata, un’occhiata che sprizzava tenerezza, e poi… via come una saetta… Un Natale pulito, limpido, luminoso come il cielo splendido”, concludeva il suo racconto padre Paolino.
A questo punto viene spontaneo chiedersi come lo scrittore abbia poi parlato di questo incontro. La risposta la troviamo in una lettera scritta il giorno stesso all’amico e collega Alessandro Minardi.
“Che favolosa mattina! Sole di primavera, Don Camillo, colloquio straordinario. Difficilmente dimenticherò il meraviglioso Natale del 1954. Non occorre che io ti parli del sole di questa mattina, perché l’hai visto anche tu, è il sole uguale per tutti, e pur se la mia fettuccia di cielo è, quantitativamente, inferiore alla tua, la qualità è identica. Mi pare che guardandolo dal fondo della fossa del carcere, il mio scampolo di cielo sia di un azzurro più intenso del cielo di ‘fuori’. Ma non ne sono sicuro perché non ricordo bene come era il mio cielo di uomo ‘libero’ e, in verità, quando ero fuori, avevo gran poco tempo per guardarlo attentamente. In quanto a Don Camillo, bisogna che te ne parli: anche perché non sia chiama Don Camillo, bensì padre Paolino. E io lo conobbi nel settembre del 1945 a Pescantina, perché egli era là, con la Pontificia Commissione d’Assistenza, ad accogliere noi reduci dai lager. Ha celebrato lui la Messa, questa mattina, perché il cappellano era malato e, quando io udii la sua voce, sussultai perché era la voce del mio Don Camillo. E quando iniziò il suo sermone, io ancora sussultai perché, se il mio Don Camillo fosse non un povero prete di campagna, ma uno smagliante oratore come padre Paolino, così parlerebbe ai suoi fedeli. (…). Poi, colloquio straordinario natalizio: la Vedova Provvisoria aveva, per l’occasione, inaugurato un soprabito nero da mezzolutto, che faceva risaltare mirabilmente la pacatezza del suo viso. Alberto indossava il suo primo soprabito da ‘uomo’ e la Carlotta si destreggiava disinvoltamente col suo pure meraviglioso manicotto di pelliccia. La Vedova Provvisoria mi confermò che la Vigilia, alle Roncole, era stata serenissima e io mi resi conto che non mentiva e questo completò la mia gioia, perché anche la mia Vigilia era stata straordinariamente serena. Neppure un istante io sono rimasto solo nella mia cella il giorno della Vigilia: la posta aveva scaricato sul tavolino un grosso mucchio di lettere e cartoline, e io ho voluto leggerle attentissimamente tutte, e quando ho finito era già la Notte Santa. Allora ho letto le tre lettere che avevo tenute per ultime: le lettere di Natale di Alberto, della Carlotta e della Vedova Provvisoria. Anche la V. P. mi aveva mandato la letterina con gli angioletti, e mi ‘spettava’ perché anche io le avevo mandato una letterina con gli angioletti e con ‘Baffo Natale’, tutta pitturata da me! Il presepino del lager ha funzionato egregiamente: che stupenda idea ho avuto costruendolo smontabile! ‘Beniaminowo 10 dicembre 1943’: undici anni sono passati da quando mi costruì quel Presepino e mi par di averlo costruito quindici giorni fa. ‘Come sei giovane vecchio Giovannino!’ Anche questo scrissi undici anni fa, e mi par di averlo pensato ieri”…
Anche qui, anche in circostanze come questa, ecco come si può essere sereni, restare liberi, pur trovandosi ristretti in un carcere: alla luce della fede, testimoniata in questo caso anche da un uomo di Chiesa degno del nome, padre Paolino, appunto.
Il pieno, completo e compiuto senso del mistero, espresso poi con una altezza poetica da vertigine, lo troviamo infine in quella Favola di Natale pensata in un lager nazista nei giorni precedenti il 25 dicembre 1944.
Una prima fiaba, Guareschi l’aveva scritta pochi mesi dopo la cattura e l’avvio ai lager, alla vigilia di quello che sarebbe stato il suo primo Natale di internamento. Era una “favoletta”, nel senso di pochi fogli: con una sentinella sulla torretta, Giuseppe e Maria che arrivano al lager chiedendo ospitalità, e poi il nascondimento (grazie alla sentinella stessa), una luce che si accende nel luogo dove nasce il Bambino, una grande splendida stella, la presenza di un colonnello, quindi la scomparsa della Sacra Famiglia così, nel nulla. Per concludersi con un “Buon Natale” detto dal soldato (buono per l’occasione) della torretta. Un gioiellino, mai pubblicato da Guareschi, ma che apparve in anteprima sul Gazzettino, poi molto opportunamente dai figli, inserito in “Ritorno alla base” (Rizzoli – 1989).
A proposito di queste pagine, nel “Grande Diario 1943-1945” (Rizzoli), del Natale si legge più e più volte… Eccone una: “Venerdì 24 dicembre 1943 Vigilia di Natale. Neve in terra e nebbia – salute adeguata – minestra di cavoli, patate, marmellata, carne in scatola, pane”. “Ho disegnato la “Lettera del papà” sulla parete e Novello ha finito il Presepe. Abbiamo fatto l’albero di Natale… Ho finito la mia conversazione ‘Natale 1943’; l’ho scritta con disperazione…”. “Sabato 25 dicembre 1943. Nebbia di brina ricamata. Salute adeguata… Questa notte è venuto Albertino a trovarmi col suo sorellino e il buon Dio, per non farglieli vedere, ha coperto i reticolati con candidi fiori di gelo. Regalo del Bambino Gesù: dato i tempi ha fatto anche troppo”…
Ma il capolavoro di Giovannino sarà “La Favola di Natale” dell’anno successivo, musicata da Arturo Coppola, edita nel dopoguerra e più volte ristampata da Rizzoli. In quel testo, l’incipit vedrà ancora una volta protagonista il figlio dell’IMI numero di matricola 6865, Albertino, con una poesia da recitare, e quindi con la nonna, il fido cane Flik e una lucciola a illuminare il cammino, su per la lunga via sconosciuta che porta al lager: un percorso caratterizzato da vari e a volte strani incontri: dalla gallina padovana travestita da ferroviere che si affretta a ritornare in patria per deporvi l’uovo (non sia mai che succeda all’estero!) alla formichina che impreca a un risparmio che l’ha condannata alla povertà, dalle malefiche cornacchie ai gentili passerotti che nel finale faranno da contorno al gruppo nel bosco…
Nel “Grande Diario”, alla data di domenica 17 dicembre 1944, leggiamo: “Ho scritto una favola di Natale”. E il martedì successivo: “Finito Favola di Natale”. Ancora, nei giorni antecedenti il 25, si legge della preoccupazione dell’autore che il testo non venga capito, poi: “Domenica 24 dicembre 1944… Prima della Favola di Natale. Un successone”. E il successone si ripeterà nelle successive letture nelle varie baracche, suscitando commozione, instillando speranze in quegli sventurati lontani dalla famiglia, dalla Patria.
Tornato in Italia nella tarda estate del 1945, Giovannino presentò quella favola all’Angelicum di Milano la sera del 23 dicembre: spettacolo a favore delle famiglie degli ex internati; e tornarono la commozione, la fede, le speranze, la poesia di quel Natale fra i reticolati. Quelle pagine scritte nel lager avevano avuto tre muse ispiratrici: il freddo, la fame e la nostalgia – come sottolineato dallo stesso autore.
Erano pagine ricche di metafore, con note polemiche, con aliti di poesia, ma soprattutto testimonianza che il Dio della pace che si incarnava nella Notte Santa rappresenta l’evento centrale dell’umanità e quindi, a maggior ragione, nella vita di quegli sventurati, poveri straccioni affamati, ma che trascinavano i loro giorni di pena all’insegna della fede, della speranza e del senso di libertà. Sì, della libertà, perché – come aveva avvertito lo stesso Guareschi nella pagina che abbiamo citato all’inizio – lui non poteva uscire dal campo di concentramento, ma poteva entrare chiunque: sogni, ricordi, affetti, e pure il buon Dio! La libertà essendo, prima di tutto, un fatto interiore: la libertà dei figli di Dio…
Con “La favola di Natale”, lo scrittore avrebbe in un qualche modo posto un sigillo inconfondibile ai giorni di prigionia, nel senso di avere toccato un livello straordinario, inimmaginabile, rispetto alle altre pagine scritte e lette ai compagni di sventura, per aiutarli moralmente a sopravvivere, a resistere, ripetendo magari insieme a lui, la famosa (paradossale) frase “Non muoio neanche se mi ammazzano”! Quei fogli sgualciti, ingialliti, diventarono infine, come detto, un libro, con le illustrazioni dello stesso Giovannino, bellissime formalmente, emblematiche umanamente-moralmente-spiritualmente.
Non molti anni dopo, l’opera letteraria, con la voce recitante di Gianrico Tedeschi, compagno di lager di Giovannino, e il coro dell’Angelicum di Milano, diventò disco e poi audiocassetta e siamo, ovviamente, in attesa che diventi un cd… Per inciso, va aggiunto che in varie rappresentazioni succedutesi nel tempo, sia a livello scolastico, sia a livello teatrale, ci sono state anche interpretazioni musicali di notevole livello – con quelle note di Arturo Coppola, più volte ascoltate, così aderenti alla lettera e soprattutto allo spirito di Giovannino!…
Il finale della Favola è tutto un programma, per così dire. Il gruppetto composto dalla nonna, da Albertino e dal fido cane Flik non arriva al lager, perché nel frattempo anche il babbo è uscito, e l’incontro avviene in un bosco. Lì c’è il trionfo degli affetti, e lì si conclude il viaggio periglioso e ricco di imprevisti affrontato dai familiari dell’internato numero 6865. Dopo avere gustato una sorta di panettone improvvisato-preparato con utensili di fortuna, lì, fra gli alberi, insieme alla nonna, Albertino si rivolge al genitore.
Ma leggiamolo questo finale così toccante e coinvolgente da scaldarci il cuore. “A uno a uno gli occhietti che fiammeggiavano sull’abete nel bosco solitario si sono spenti. Nel fornellino la fiamma dà gli ultimi guizzi. Fa freddo. Gli alberi hanno riallargato il loro cerchio e il Vento soffia gelido. Croci nere sono sparse nel bosco e attorno a ogni croce si aggirano mute ombre. E le croci sono tante, e le ombre sono infinite. ‘Chi sono, papà?’ ‘Sono gli spiriti dei vivi che vengono a cercare i loro morti. Guardano tutte le croci che la guerra ha sparso nel mondo, leggono i nomi incisi sulle croci. E quando una mamma ritrova la tomba del suo figliolo, si siede sotto la croce e parla con lui di tempi felici che non torneranno mai più…’ Il Vento, intanto, riporta la canzone che è stata fino ai campi di prigionia e ritorna alle case, e la canzone che è stata alle case e ritorna ai campi di prigionia. ‘Buon Natale, mamma, buon Natale, Albertino’ dice il babbo. ‘Ora ritornate a casa: la vostra canzone vi riaccompagnerà’. ‘E tu non vieni, papà?’ ‘Domani, Albertino…’ ‘Domani, o morgen?’ chiede la nonnina. ‘Dorgen, mamma’. ‘Papà, perché non mi prendi con te?’ ‘Neppure in sogno i bambini debbono entrare laggiù. Promettimi che non verrai mai’. ‘Te lo prometto, papà’.
Se ne sono andati assieme alle loro canzoni e il bosco è muto e deserto. Nevica e una nuova soffice coltre si stende sull’altra indurita dal vento. Il cerchio verde attorno al fuoco è ridiventato bianco. Scompare la traccia dei sentieri. ‘Notte da prigionieri!’ esclama il Passerotto capofamiglia nascondendo la testa sotto l’ala. E nel muoversi fa cadere una foglia che scende volteggiando lentamente e si posa nel bel mezzo della bianca radura. E si vede che, sulla foglia, c’è scritto la parola FINE.
Ed è una foglia stretta stretta: Stretta la foglia – larga la via / Dite la vostra – che ho detto la mia. / E se non v’è piaciuta – non vogliatemi male, / ve ne dirò una meglio – il prossimo Natale, / e che sarà una favola – senza malinconia: ‘C’era una volta – la prigionia’. (Stalag XB, dicembre 1944)…”.
Grande, immenso, Giovannino! Che sa percorrere con la forza della fede, e con la delicatezza della poesia, a volte accompagnata da un soffio di umorismo, come abbiamo già detto, ma che ancora vogliamo sottolineare, le vie del cuore!… Trasmettendoci una compagnevole melanconia, nella sua profonda dolcezza… Allora, buon Natale con Guareschi, cari amici che avete avuto la pazienza di ascoltarmi! Sarà un Natale certamente sereno… nonostante tutto!

(Conferenza tenuta il 14 dicembre 2019 per il Comitato di Ravenna della Società Dante Alighieri)