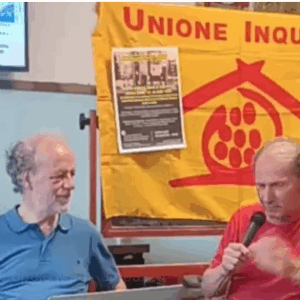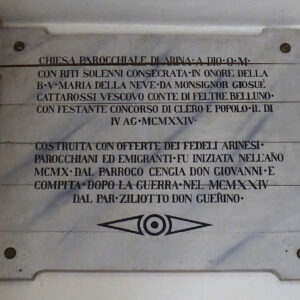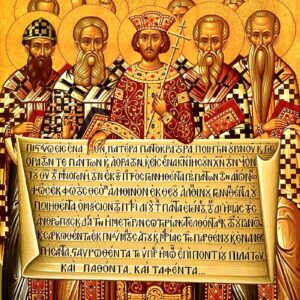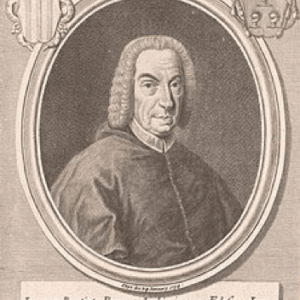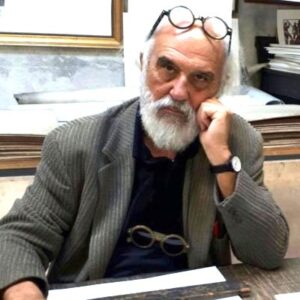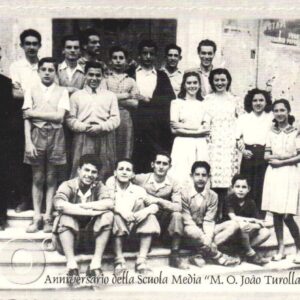La conquista del K2: i settant’anni di un’impresa
Lacedelli, Compagnoni e Bonatti ne furono i protagonisti, da allora celebrati come leggende dell’alpinismo
Sul giornale La stampa del 25 giugno 2024 leggo: Partita la spedizione femminile al K2 del Cai.
Le quattro alpiniste italiane in volo per Islamabad, insieme a quattro pakistane tenteranno la scalata della vetta dal 20 luglio per celebrare i 70 anni della salita di Lacedelli e Compagnoni.
Tale notizia mi fa ricordare che nel 1954 abitavo a Piazzola sul Brenta e per andare a scuola, a Padova, l’unico mezzo di trasporto era quel famoso trenino che sferragliava sbuffando attraverso i paesi di Tremignon e Limena e lungo la strada provinciale e nazionale, come in una moderna pista ciclabile..
Era un trenino antidiluviano, le carrozze con i sedili in liste di legno e la piccola locomotiva a carbone, tipo quella del Monet, che a volte con fatica riusciva a oltrepassare il cavalcavia Camerini di Altichiero. Ho passato diverso tempo tra andate e ritorni e ho visto cambiare, negli anni, anche la morfologia dei paesi che attraversavo.
Mi è rimasta impressa la costruzione dopo Limena, oggi tutta zona industriale, di un locale-bar con una grande insegna luminosa dal nome strano: K2. E proprio nel 1954 un’impresa eroica provocò un’ondata di entusiasmo in tutta Italia: non per i successi del discobolo Adolfo Consolini o del pugile Duilio Loi, ma per la scalata del K2 con i due alpinisti che avevano vinto la sfida con i migliori scalatori del mondo dopo che, l’anno precedente, Edmund Hillary e Tenzibg Norgay conquistarono per la prima volta la cima dell’Everest. Il 31 luglio 1954 il cortinese Lino Lacedelli e il valtellinese Achille Compagnoni raggiunsero la vetta del K2 a 8611 metri, la seconda montagna più alta del mondo, ma la più impervia e fino ad allora inviolata. La spedizione era guidata da Ardito Desio, un illustre geologo quasi sessantenne, coronato di onorificenze e titoli accademici, esploratore e giornalista. Per ragioni anagrafiche, era inadatto allo straordinario sforzo fisico della scalata. Tuttavia era un ottimo organizzatore e diresse le operazioni dal campo base, a circa 5000 metri di quota.
Fu un’impresa epica, non priva però di imprevisti e lutti. Partirono per il K2 tredici alpinisti italiani, dodici portatori e osservatori pakistani e cinque nostri scienziati. Le operazioni iniziarono tra la fine di maggio e gli inizi di giugno e furono funestate dalla morte dell’alpinista valdostano Mario Puchoz. Tuttavia proseguirono con ordine e metodo e i nostri costruirono persino una piccola teleferica. Più il gruppo saliva, più si assottigliava. Il 25 luglio arrivarono in sei a 7345 metri; tre giorni dopo partirono in cinque, più Walter Bonatti di riserva, per stabilire un nuovo campo quattrocento metri più in alto.
Il 29 Lacedelli e Compagnoni tentarono di raggiungere quota 8100, ma furono fermati dal maltempo; gli altri tre compagni Erich Abram, Pino Galloti e Ubaldo Rey furono costretti, per varie ragioni, a rientrare. Restava solo il giovane Bonatti.
All’alba del 31 luglio Lacedelli e Compagnoni partirono dal campo IX, raggiunsero il bivacco di Bonatti, si rifornirono delle ultime due bombole e attaccarono il tratto finale: alle 18 arrivarono in vetta e piantarono le bandierine italiana e pakistana. Nell’esultanza del momento si tolsero i guanti per fotografarsi e si congelarono le mani. Entrambi avrebbero subito l’amputazione di alcune dita: ma rimasero sempre convinti che ne fosse valsa la pena.
Entrambi gli scalatori furono ricevuti dalle massime autorità dello Stato e, per mesi, la loro immagine apparve sulla stampa e sui cinegiornali proiettati nei cinema: tanto che a Limena fu dato, al nuovo bar, il nome di K2.