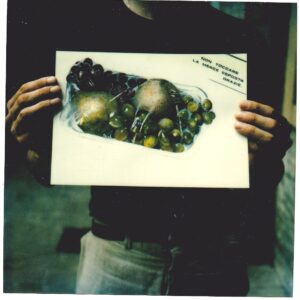Il vicentino Giacomo Zanella estimatore della poesia di Leopardi
Un brano che esprime in modo esplicito, e con parole entusiastiche, l’ammirazione dell’Abate
La Storia della Letteratura dell’Abate e letterato Giacomo Zanella (Chiampo, 9 settembre 1820 – Cavazzale di Monticello Conte Otto, 17 maggio 1888), tendenzialmente moralistica, è portata ad apprezzare di più gli autori credenti rispetto ai non credenti, ma davanti a un genio assoluto come Giacomo Leopardi – che, a differenza di Napoleone, per dirla con Manzoni, non volle mai piegarsi al disonor del Golgota – nella parte finale del capitolo a lui dedicato, con fervida e inusuale eloquenza si abbandona ad una appassionata e calorosa difesa di questo autore che troppo tardi fu riconosciuto anche dagli italiani nella sua indiscussa grandezza.
Ecco il brano che propongo all’attenzione dei lettori: “Ma non da lenta ed insanabile corruzione di cuore, né dal desiderio di nascondere le proprie colpe nelle colpe di tutto il genere umano è nata la poesia del nostro grande infelice. Vide prima la patria scaduta dalla sua antica grandezza, ed il fiore de’ suoi giovani, che potevano rialzarla dalla ruina, tratti a perire miseramente fra le nevi di Russia; vide i governi d’Europa, dopo aver col grido di libertà sollevati i popoli contro Napoleone, ribadir loro più dure e strette le vecchie catene; paragonò la possanza di Roma antica, quell’impero, quelle armi, qual fragore di battaglie e di vittorie che andò per la terra e l’oceano, colla debolezza e coll’ignavia dell’Italia de’ suoi giorni; e pianse lagrime di ardente dolore, perché non poteva in modo alcuno soccorrere alla necessità della patria. Le sventure d’Italia gli fecero parere più gravi le proprie particolari. Nato coll’anima di un eroe, e sentirsi chiuso in un corpicciolo gracile, infermo, inetto alle grandi azioni; abbracciare con uno sguardo d’aquila l’universalità del sapere, e vedersi dalle malattie inibito di correre il magnifico arringo; passare gli anni giovanili in una città di provincia, segregato dal consorzio degli uomini dotti, a cui più che discepolo poteva essere maestro, vedersi costretto a dare private lezioni di greco per campare con meno disagio la vita; quale meraviglia che il mondo gli si velasse di nero? Che la vita gli paresse una punizione? Solo nella religione, che insegna essere questa vita un campo di prova, e la mercede essere altrove, egli poteva trovare i veri conforti; e quando pensiamo come molti che si fecero illustri e benemeriti della patria nacquero e vissero in condizioni pari o peggiori che non erano le sue, noi non possiamo non dolerci della sua ostinazione a rifiutare il farmaco che la religione gli ponea innanzi. Possiamo dolerci, ma non getteremo mai la nostra maledizione sul capo dell’infelice. La sua vita fu d’uomo innocente e di onorato cittadino; fu schiavo di un altissimo errore, ma non cercò di trascinare gli altri nel suo abisso; non ambì proseliti; non si fece dell’arte uno strumento a corrompere il cuore de’ giovani. È mirabile a dirsi; ma la lettura delle sue poesie, lungi dal contaminare e snervare lo spirito, accende a nobili e virili propositi”. E così conclude questa ardente e vigorosa apologia della sua poesia: “Sei morto giovane e desolato di ogni umana speranza; ma se fossi tanto vissuto quanto permette l’ordinario spazio del nostro vivere, ed avessi veduto questa tua povera Italia libera e unita in un solo governo, ne saresti stato contento? Noi ti saremmo sembrati degni di tanta fortuna? Degni del glorioso nome di quell’Italia ‘che al finir dell’ammiranda / antichità per anni ultima viene / e primi per virtù gli onori ottiene?’. Io non oso far la risposta; questo solo posso dire: che finché la sua memoria sarà cara agl’Italiani; finché dalle Alpi al Po, e dall’Arno e dal Tevere trarranno a visitare la tua tomba presso Posillipo; e nella vicina chiesuola dove giaci sepolto, ti pregheranno da Dio quella pace che invano cercasti sulla terra, io non dispererò d’una patria che ancora produce tali ingegni ed ha bastante cuore e mente per riconoscerli e onorarli”.