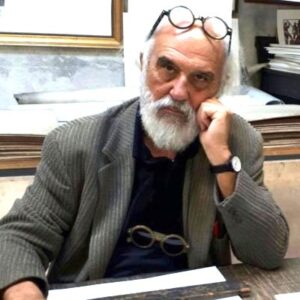Le radici bibliche del Giubileo, tempo di riconciliazione
Le origini antiche e profonde di un momento centrale nella storia della cristianità e della Chiesa
Il 2025 è l’anno del giubileo, di cui siamo soliti raccontare la storia a partire da quello indetto dal papa Bonifacio VIII nel 1300. In realtà la parola ‘giubileo’ ha un’origine molto più antica ed esprime una realtà complessa che affonda le proprie radici nella tradizione biblica, rimandando all’anno della grazia e della liberazione.
Per la sua origine si fa riferimento al termine ebraico jobhel: il montone, dalle cui corna si ricavavano i corni che venivano suonati all’inizio della guerra oppure quando prendeva avvio un evento di significato pubblico. Tra questi anche l’anno di misericordia che ci racconta il testo del Levitico al cap. 25. È a partire da esso che, nel corso dei secoli, il termine jobhel ha finito per rappresentare l’anno consacrato all’amore di Dio.
In realtà non c’è alcuna diretta attinenza con il termine latino iubilaeus, che ha origine invece da iubilum (gioia), con il quale san Gerolamo probabilmente volle rendere l’idea dello jobel: anno di gioia e di pacificazione, tanto che lo stesso Gerolamo definì il giubileo come annus remissionis.
Per capire il senso del giubileo dobbiamo andare pertanto alle sue radici bibliche.
A ricordo del settimo giorno della creazione in cui Dio si riposa, gli ebrei celebrano il sabato, giorno dedicato al riposo e alla preghiera, che esprime in modo pieno l’identità religiosa di quel popolo. A somiglianza del sabato, ogni sette anni essi celebravano un anno sabbatico (shemittah), dedicato al riposo della terra, lasciandone i frutti spontanei ai poveri ed ai forestieri.
Se una norma di saggia economia agricola (non era ancora in uso la rotazione biennale, poi triennale) poteva spiegare la sosta nella coltivazione della terra, non altrettanto facile è spiegare il significato della liberazione dai debiti che l’anno sabbatico comportava. Nel settimo anno, infatti, i debiti venivano estinti. Ogni prestito poteva durare al massimo sei anni. Se non veniva estinto, la legge prevedeva una donazione, temperata da prestazioni compensative e sostitutive per altri sei anni: se non hai pagato, ti è condonato il debito, ma devi servirmi con del lavoro gratuito per ricambiarmi quanto ti avevo dato in prestito.
Questa indicazione settennale è divenuta poi un elemento centrale dell’anno giubilare. Il libro del Levitico (25, 8-17) ci testimonia infatti come all’anno sabbatico si aggiunse, nel corso dei secoli, l’anno giubilare: ogni 50 anni (al termine di sette settimane di anni), con il riposo della terra la comunità civile proclamava anche un anno di liberazione per tutti. Sette cicli di anni sabbatici fanno un giubileo: «Dichiarerete santo il cinquantesimo anno e proclamerete la liberazione nella terra, per tutti i suoi abitanti. Sarà per voi un giubileo; ognuno di voi tornerà nella sua proprietà e nella sua famiglia» (Lev. 25, 10). In esso ognuno recuperava la proprietà venduta e la libertà, se era stato venduto per pagare i contratti di cui era debitore. Se un uomo aveva contratto un debito e non aveva come rifonderlo, doveva accettare l’idea di divenire in un certo senso schiavo, lavoratore mercenario e non pagato del suo creditore. Poteva riscattarlo solo il parente più prossimo, ma pagando in denaro.
L’anno giubilare era allora un anno sabbatico particolare, caratterizzato sia dal riposo della terra, sia da una sorta di perequazione sociale ed economica, che tendeva a riconciliare gli uomini tra loro ed a portare un clima di pace e di convivenza serena. L’obiettivo di fondo era quello di evitare che le condizioni di povertà e di indigenza divenissero insopportabili. Il senso della solidarietà e della fraternità aveva un ampio spazio nella concezione del ‘riposo’ e della consacrazione giubilari.
Nel contesto ebraico il giubileo assumeva così una caratterizzazione di perdono e di riconciliazione, fino a rappresentare l’occasione per ristabilire rapporti resi conflittuali dalla durezza del cuore (si pensi alle lotte per il possesso dei campi e del bestiame), ma con una connotazione teologica chiara: la terra è dono di Dio ed a Lui va resa, senza che si possa divenirne padroni.
Il giubileo voleva aiutare il popolo ebraico a comprendere alcuni elementi di fede e di vita morale chiari:
a. tempo di consacrazione a Dio nella preghiera e nella liturgia;
b. tempo di liberazione anche per gli schiavi;
c. tempo della giustizia in cui la terra ritorna ai proprietari originari ed in cui c’è un condono universale;
d. tempo del creato in cui c’è un riposo cosmico della terra e degli animali.
Al tempo di Gesù parlare di giubileo voleva dire parlare di un momento forte di giustizia sociale, in cui la comunità era invitata a vivere un ideale più alto di generosità e di fraternità.
Ma Gesù ha voluto dare un nuovo significato al giubileo. In Lc 4, 16-21 è raccontato infatti l’episodio in cui egli, tornato a Nazaret ed entrato di sabato nella sinagoga, aveva preso il rotolo di Isaia e, trovato il passo (61, 1-2) in cui il profeta annunziava l’anno di liberazione dei prigionieri («Lo spirito del Signore Dio è sopra di me; per questo il Signore mi ha consacrato con l’unzione e mi ha mandato a portare il lieto annunzio ai poveri, a fasciare le piaghe dei cuori spezzati, a proclamare la liberazione degli schiavi, la scarcerazione dei prigionieri, a proclamare l’anno di grazia del Signore»), aveva sostenuto: «Oggi si è compiuta questa Scrittura che voi avete ascoltato».
In questa prospettiva l’attesa ebraica dell’anno di grazia trova nella persona e nelle parole di Gesù il suo compimento: Gesù stesso si presenta come il messia che sta per compiere il giubileo definitivo. E l’intera predicazione di Gesù esplicita i grandi temi del giubileo, sintetizzandoli nel discorso della montagna (Mt. 5-7).
Celebrare oggi il giubileo, per i credenti, o anche solo riflettere sul suo significato, per quanti non condividono la fede cristiana, non può prescindere dall’attenta considerazione di queste radici millenarie, che ancora molto hanno da dire all’uomo di oggi nel suo rapporto – spesso conflittuale – con il pianeta che lo ospita e con gli altri uomini.