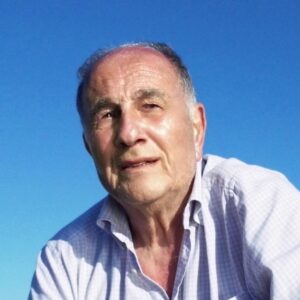Il libro, un patrimonio in estinzione?
Neppure una società ipertecnologica può esistere o progredire senza la lettura
Immanuel Kant, in Fondamentazione della Metafisica dei Costumi (1785), afferma che il libro può essere considerato sia come oggetto – vale a dire un bene materiale, pubblicato da un editore, acquistato o regalato a una persona, che ne diventa possessore e potenziale lettore –, sia come opera, ossia un testo che trasmette un determinato discorso. Tale duplice dimensione trova la prima valida affermazione nel XVIII secolo, periodo in cui, con la nascita del copyright o diritto d’autore, il libro viene protetto quale opera testuale, ponendo il discorso al primo posto rispetto alla materialità. Ciò condiziona anche il modo in cui esso viene letto e percepito. Le due caratteristiche si manterranno invariate nel corso del tempo, risultando imprescindibili per comprendere gli aspetti salienti della storia del libro e, di conseguenza, della lettura, in costante tensione tra la libertà del lettore ‒ dipendente sempre dalla propria costruzione socio-culturale ‒ e i vincoli imposti. In fondo, la lettura è un’attività creativa, insegna Jorge Luis Borges, perché suscita emozioni, necessarie per vivere: l’importante è essere sinceri con il proprio sogno, in quanto il mondo è contenuto in un libro. Non a caso oltre alla realtà oggettiva, esso racchiude una “realtà” immaginaria, dove convivono senza discriminazioni e senza divisioni, uomini e donne in carne ed ossa, personaggi storici e creature del mito, razionalità e irragionevolezza, possibile e impossibile.
La vera rivoluzione dell’invenzione di Gutenberg si deve alla “tecnica”, ovvero alla rapidità della riproduzione dei testi, un tempo scritti o copiati a mano. La stampa, infatti, implementa la circolazione dei libri, rendendola particolarmente vorticosa nel XIX secolo, quando si espande l’industrializzazione della stampa e nel XX secolo, con l’affermarsi della trasformazione digitale. Soltanto nei primi decenni del XXI secolo, la forma materiale del libro subisce un radicale mutamento. Senza dubbio, la rivoluzione digitale ha comportato una modificazione tecnica, relativa al modo in cui viene trasmessa la testualità, ma anche una variazione morfologica, in quanto lo schermo è totalmente diverso da una pagina di un libro che si può toccare. Ciò attiva rettifiche importanti nelle pratiche di lettura, divenuta più accelerata, superficiale e frammentaria, prestandosi a falsificazioni e a manipolazioni del racconto.
Se osserviamo le ultime statiche ISTAT, in cui viene rilevato un calo di oltre un milione di lettori, distribuito sul territorio italiano, in particolare al Sud, certo non c’è da stare tranquilli. Non bisogna nemmeno stupirsi se le case editrici, soprattutto quelle di piccole dimensioni, sono in difficoltà, per non parlare delle librerie che, gradualmente, chiudono i battenti. Una per tutte: la “mitica” libreria Draghi, aperta a Padova nel 1920 da Giovanni Battista Randi, “el siòr Tita” ‒ ampliata nella sezione artistica e storica da Giuseppe, sino ad arrivare a Pietro Randi e agli ultimi proprietari Elena e Lorenzo Randi‒, dal 2011 non esiste più! Situata in pieno centro di Padova, da generazioni era punto di ritrovo di studiosi e di studenti i quali, una volta entrati, avevano la medesima espressione di felicità sul volto, osservando sornioni i libri che suscitavano immediata curiosità: venivano aperti con rispetto, quasi accarezzati, prima l’uno poi l’altro e l’altro ancora. Ricordo con nostalgia quel posto magico, dove si respirava il profumo della carta stampata, e si andava alla ricerca di tesori nascosti con l’aiuto di Adriano: più che essere un commesso, era un grande lettore, dalla memoria infallibile, capace di individuare il libro richiesto al benché minimo indizio.
Nemmeno le edicole, dove si comperavano i vari fumetti e i classici a costi irrisori – a volte venivano regalati insieme al giornale – sopravvivono all’uragano internet. Lentamente scompaiono ovunque: esistono ancora in qualche Centro commerciale, situato fuori città, inaccessibile ad anziani e a bambini che non usano l’auto. Un’iniziativa davvero curiosa per la sua originalità è stata messa in atto dal comune di Genova, che ha bandito una selezione pubblica per trasformare un chiosco, orami dismesso, in un info-point con giornali, guide turistiche della città, pubblicazioni dedicate alla città e alla sua storia in varie lingue. A gestirla sarà la libreria San Paolo, situata nella medesima piazza, nel centro della città. Per questa scommessa di rinnovamento che non accetta la crisi delle edicole, la libreria ha ricevuto uno dei premi annuali della diocesi di Genova. Potrebbe essere un’idea da emulare.
Dobbiamo davvero rassegnarci a perdere un simile patrimonio librario? Alla stregua di mia cugina Franca che afferma, tra il serio e il faceto, “senza libri, non posso vivere”, anche l’attuale società non può esistere o, tantomeno, progredire senza la lettura di un testo. Esso apre alla riflessione, fa volare la fantasia superando barriere di ogni tipo, stimolando emozioni, dando sicurezza in sé per affrontare il domani, consolando l’animo, infondendo speranza e riempiendo la solitudine. E, cosa non meno importante, arricchisce il nostro vocabolario, altrimenti ridotto a superficiali semplificazioni. Basti pensare a quanto accaduto al Liceo Scientifico Minghetti di Bologna, dove i docenti di materie scientifiche, non umanistiche come si potrebbe pensare, hanno richiesto un’ora supplementare di italiano alla settimana per gli studenti del ginnasio: costoro giungono dalle medie inferiori senza alcuna capacità di elaborare testi e, ancor peggio, di crearli. Le lacune di carattere ortografico, lessicale e sintattico sembrano essere incolmabili. Altrettanto carenti sono gli adulti che, sempre secondo i rilevamenti ISTAT, non sono abituati alla lettura. Da qui, il diffondersi della mancanza di immaginazione, alimentata dall’uso indiscriminato della tecnologia che, pur essendo in grado di anticipare i cambiamenti sociali, di fornire soluzioni a bisogni non ancora percepiti, di facilitare l’organizzazione dei vari gangli dell’attuale società, impedisce di trovare soluzioni alternative per superare gli inevitabili ostacoli, incontrati nel percorso vitale.
Il Ministero della Cultura cerca di introdurre agevolazioni economiche e strutturali per supportare biblioteche e librerie, in modo da creare o da stimolare lettori attenti ed esigenti, tali da essere una garanzia di continuità di lettura, intesa nella duplice valenza di leggere e di interpretare. Tuttavia, non è ancora sufficiente per far sì che i giovani colgano l’invito dantesco ‒ “fatti non foste per viver come bruti, / ma per seguir virtute e conoscenza” ‒ e si formino una cultura, quella derivata dalla bistrattata tradizione umanistica, che crea sapienza e induce a pensare con la propria testa, dando risposte alle nostre inquietudini. Dato che il progresso non può essere arrestato, a questo punto non importa se un libro appare in forma cartacea o digitale, fondamentale è che sia letto.