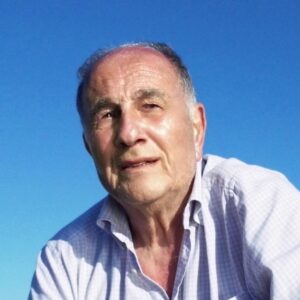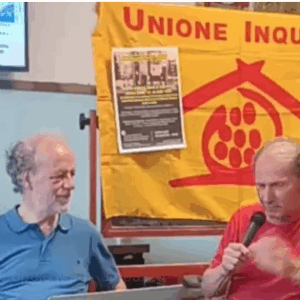Vecchia e nuova economia in Veneto: il modello di imprenditoria tra passato, presente e futuro
La dimensione locale come risorsa strategica per una collocazione nel contesto internazionale
Negli ultimi anni è sorta l’esigenza internazionale di riappropriarsi della dimensione locale, in quanto la globalizzazione ha utilizzato i territori come occasione di delocalizzazione dei prodotti, di uso e di sfruttamento delle risorse naturali, o come vie di passaggio delle merci. Pertanto, sulla base dell’elaborazione dell’Indice di Qualità Regionale dello Sviluppo (QUARS), anche l’Italia sta cercando di individuare indicatori capaci di rappresentare, in maniera sintetica, l’Indice di Benessere Economico Sostenibile (Index of Sustainable Economic Wefare – ISEW), ovvero il grado di sviluppo e la qualità della vita di una nazione, ma anche di uno specifico contesto geografico. Quest’ultimo, infatti, risulta essere estremamente importante nella ridefinizione delle politiche economico-sociali, nella gestione degli spazi e della partecipazione democratica alla cosa pubblica. Lo ha dimostrato, e continua a farlo, la nostra Regione che, soprattutto a partire dagli anni Cinquanta del XX secolo, ha convogliato risorse e strategie per la realizzazione del famoso “Modello Veneto”, tanto apprezzato nel mondo.
La Seconda guerra mondiale colpì duramente l’intero tessuto produttivo: mentre le fabbriche erano in sofferenza per la carenza di materie prime, le infrastrutture sprofondavano in uno stato drammatico. Pertanto, con la riapertura dei mercati internazionali che intensificarono gli scambi delle merci, gli imprenditori dovettero aguzzare l’ingegno e rimboccarsi le maniche. Numerose fabbriche cambiarono destinazione, riconvertendo gli impianti – come accadde per il Polo Industriale di Marghera – e dando impulso a piccole e medie imprese. Ciò favorì nuove assunzioni e creò ulteriori assetti industriali, in grado di occupare i diversi settori della filiera di produzione. Non è un caso se, tra gli anni Cinquanta e Settanta, il ramo meccanico passò dall’assemblaggio di componenti prodotti altrove, alla realizzazione di manufatti conseguiti in loco. È sufficiente ricordare la nascita dell’industria degli elettrodomestici, diffusi in tutta Italia e nel mondo: chi non conosce i termoventilatori, i condizionatori o le macchinette da caffè De Longhi? D’altra parte già negli anni Trenta del Novecento, singoli artigiani si dimostrarono reattivi nei confronti delle difficoltà del decennio, aprendo la via alla sorprendente espansione della manifattura leggera che, a tutt’oggi, caratterizza l’intera zona.
Grandi famiglie, attivamente coinvolte nei ruoli di vertice, generarono una miriade di micro-realtà di indotto. Grazie al fiuto imprenditoriale dei Basso e dei Maltauro si svilupparono imprese edili, mentre i Rana, indirizzati verso la gastronomia, incentivarono modeste attività culinarie. Marzotto, Benetton, Stefanel, per citare alcuni esempi, si dedicarono al settore tessile, istituendo piccoli laboratori, in cui ad essere assunte erano soprattutto le donne. I Rossi, i Voltan e i Boldrin si orientarono verso il settore delle scarpe, distribuendo il lavoro casa per casa, dove a cucire le tomaie erano ancora le donne che, in tal modo, arrotondavano gli esigui bilanci familiari. Tutto ciò contribuì a dare nuova vitalità alla Riviera del Brenta, oggi terzo polo calzaturiero italiano per numero di aziende e di risorse. Gli altri due poli sono lo Sportsystem di Montebelluna e la Calzatura di Verona, ubicati sempre in Veneto. Essi devono il loro successo alla qualità del prodotto finito, alla vicinanza tra imprese dell’intera filiera ed al know-how, ovvero a quel complesso di conoscenze, di esperienze e di competenze accumulate da generazioni di appassionati artigiani. Secondo una ricerca condotta da Cherry Bank, la resilienza dimostrata da queste aziende, anche nel periodo post pandemia Covid19, è, infatti, frutto dell’interconnessione con Brand di lusso che, tramite acquisizioni o investimenti, hanno insediato gli stabilimenti produttivi nel Distretto.
Il merito di questi imprenditori fu quello di interpretare le necessità del momento e di innovare i prodotti per soddisfarle. Purtroppo, la difficoltà di individuare una netta separazione tra regole dell’impresa e principi della famiglia, la paternalistica direzione delle risorse umane, il passaggio generazionale, causò confusione in quanto a condurre l’azienda era soltanto il fondatore della stessa. La reiterata mancanza di managers preparati contribuì, infine, ad accelerarne l’inevitabile declino. Dopo la crescita vorticosa degli anni d’oro, incapaci di fare fronte alla crisi economica e alla burocrazia statale, diverse famiglie subirono una serie di tracolli e dovettero affrontare difficoltà insormontabili.
Le nuove generazioni appresero la lezione, superando il desueto modello Famiglia-Impresa, investendo in modo strutturato e riservando ampio spazio alla ricerca e allo sviluppo. Ben lo dimostrano le padovane Marcato, che produce macchine per fare la pasta in casa – uno dei suoi prodotti è al MoMA di New York – e Sapiselco, la sola azienda al mondo specializzata nella produzione integrata di fascette di cablaggio. Una curiosità: proprio con detto materiale, nel 2015 l’artista israeliano Tsibi Geva, realizzò un’opera per la Biennale di Venezia.
Tra i grandi imprenditori, che mantennero alti nel tempo nome e capitale, figurano ad esempio: Sergio Stevanato (Venezia, 1943), presidente emerito di Stevanato Group (Piombino Dese, PD), primo produttore mondiale di cartucce di insulina per il trattamento del diabete e di fiale di vetro per i medicinali; Giuseppe De Longhi (Treviso 1939), presidente della De Longhi Spa che produce piccoli elettrodomestici; Eredi di Leonardo Del Vecchio, fondatore della Luxottica; Angelo Dalle Molle (Mestre-Venezia, 1908 – 2001), paròn del Cynar, di cui tratterò dettagliatamente in un prossimo articolo.
Secondo la classifica di Forbes del 2023, nell’elenco dei veneti più ricchi appaiono, inoltre: Renzo Rosso, Luciano, Giuliana, Sabrina e Barbara Benetton, Alberto Bombassei, Massimo Moratti, Mario Moretti Polegato, Sandro Veronesi, Massimo Doris, Annalisa Doris e Lina Tombolato.
Oggigiorno, una possibile via percorribile per la crescita dell’intero Nord Est, la individua il progetto VeNetWork, ideato da Alberto Baban. Si tratta di un’iniziativa di re-startup di aziende e di brand storici in cui sono coinvolti cinquantasei giovani capitani d’impresa, impegnati a rivitalizzare la cultura imprenditoriale. Tra coloro che hanno rilanciato imprese venete in crisi, ma con potenziale di sviluppo, ricordo lo stesso Alberto Baban: la sua Tapì SpA ha rivoluzionato il mondo delle chiusure top-bar, introducendo il concetto di design e di creatività; Gianluca Bisol, erede di una famiglia di vignaioli attivi fin dal 1542, è attualmente alla guida di una delle più antiche cantine di Prosecco di Valdobbiadene, estesa su venti poderi, una parte dei quali situati nella celebre collina del Cartizze; Elisabetta Armellin, dopo la laurea in Belle Arti a Venezia e varie esperienze come stilista di importanti case di moda, nel 2012, fonda il V73, un marchio di borse presente in oltre quattrocento negozi in tutto il mondo; Philipp Breitenberger, insieme al fratello Manuel, muta l’azienda agricola di famiglia, situata a Giavera del Montello, in una moderna impresa dell’agroalimentare specializzata in kiwi biologico e suoi trasformati; Pierangelo Bressan, con esperienza nell’ambito dell’abbigliamento, nel 2014, rileva la Garmont, storico marchio di calzature da montagna di Volpago del Montello (Treviso). Per una completezza di informazioni rimando al volume Impavidi veneti. Imprese di coraggio e successo a Nord Est di Giampietro Bizzotto e Gianpaolo Pezzato.
Aperti alle sfide dell’innovazione, ognuno di questi “nuovi” imprenditori, affronta il particolare momento storico, in cui l’economia sembra dare segnali contrastanti, con il medesimo spirito pionieristico dei “vecchi” imprenditori, sia pure con una maggiore preparazione scientifica. Essi fanno intravvedere un percorso di realizzazione ai giovani d’oggi che, mossi dall’amore per la propria terra, rifiutano di ingrossare le fila dei cosiddetti cervelli in fuga.