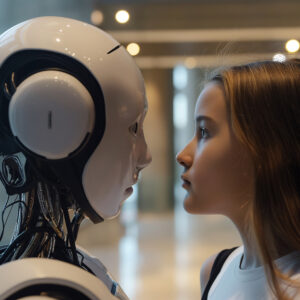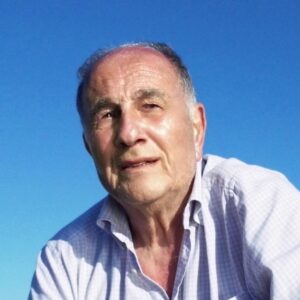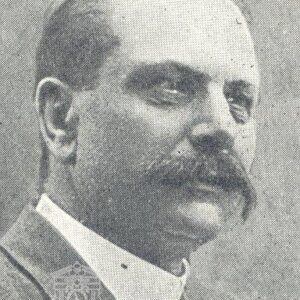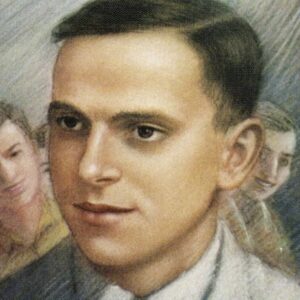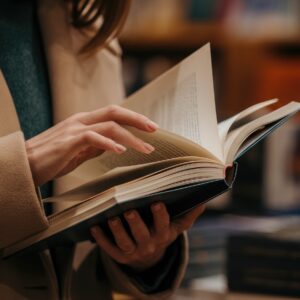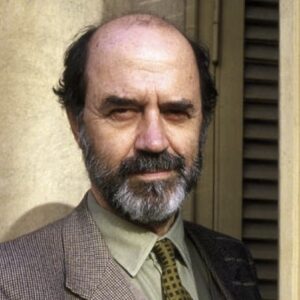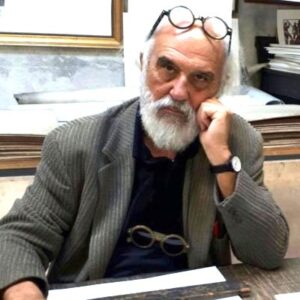La Resistenza al nazifascismo in Bassa Padovana
A ottant’anni di distanza, è sempre opportuno ripercorrere e ricordare i giorni in cui orribili stragi fecero da preludio alla festa della Liberazione
Il 25 aprile si celebreranno gli ottant’anni di Liberazione dal nazifascismo e anche la Bassa Padovana ha conosciuto l’importanza dei sacrifici sostenuti durante la Resistenza. Quest’articolo, per ovvi motivi di brevità, non vuole e non può essere un’esaustiva analisi di tutti gli avvenimenti accaduti fra il 1944 e il 1945, ma intende fornire gli spunti e gli stimoli necessari per permettere al lettore di approfondire e conoscere determinati momenti storici: perché è solo attraverso lo studio della Storia che si possono evitare gli errori del passato e impedire che certe situazioni possano ripetersi.
Vorrei iniziare questa mia rapida ricostruzione dei principali episodi accaduti citando un passo del diario di Maria Carazzolo, all’epoca una giovane ragazza di Montagnana, che così descrive i terribili anni di occupazione nazifascista: “È la lotta agli estremi, elementare ormai come le antiche caccie preistoriche, il fuggitivo e l’inseguitore. Non c’è più la legge, non ci sono né tribunali, né autorità: l’inseguitore ha il libero ordine di ammazzare il fuggitivo appena lo vede. È il terrore. […] Ormai è semplicemente lotta per la vita”.
Ed è in questo clima che fra la primavera e l’estate del 1944 si costituiscono i Comitati di Liberazione Nazionale di Montagnana e di Este. Si decide che è giunto il momento di passare dalla propaganda antifascista all’azione: il 7 luglio un gruppo di partigiani assalta la caserma dei carabinieri di Merlara e nella sparatoria che ne segue viene ucciso Paride Cervato di Castelbaldo, il primo partigiano caduto, a cui verrà intitolata la più importante formazione partigiana attiva nella Bassa, la brigata Paride. Seguiranno sabotaggi alla linea telegrafica fra Este e Ospedaletto. Le rappresaglie nazifasciste non si fecero attendere, non solo nelle campagne o con incendi delle case dei ribelli, ma anche interrompendo momenti di svago quali la proiezione di un film: come avvenne il 23 luglio quando una ventina di brigatisti neri e una decina di tedeschi bloccano le uscite del Cinema Impero, fanno uscire donne e ragazzi e selezionano una sessantina di persone che vengono condotte al Collegio Vescovile di Este, in attesa di essere deportate in Germania. Ad una retata così plateale, alcuni partigiani decidono di rispondere sequestrando il dottor Giuseppe Pisanò, commissario del fascio di Montagnana, il quale viene nascosto nella zona di Castelbaldo. Il responsabile del Servizio di Sicurezza di Padova Sud è il capitano Lembcke,il quale, presi in ostaggio venti antifascisti di Montagnana, minaccia di fucilarli se non verrà riconsegnato il gerarca fascista. Ma, soprattutto, poco dopo l’una del 26 luglio, Castelbaldo è investito da un rastrellamento a tenaglia, con i fascisti che muovono da Merlara e i tedeschi da Masi; lo stesso Lembke, come scriverà il parroco don Miotto “dal campanile prima e dall’argine poi impartisce ordini di strage e di morte”.
Comincia sull’Adige la carneficina e sull’Adige ha termine, dopo aver insanguinato il centro abitato. Pietro e Nerino Cavalletto sono tra i primi a cadere nelle mani dei tedeschi. Vengono uccise anche le sorelle Panziera, infine tutti quelli che son fatti prigionieri sono ammassati in piazza Rovere e poi fatti sfilare lungo via Garibaldi. I tedeschi ne prelevano una mezza dozzina e li conducono sulla sponda sinistra dell’Adige, nei pressi del mulino Menato. Qui si consuma la mattanza: i prigionieri sono buttati nel fiume e crivellati dalle raffiche dei mitra e dei fucili.
A coronamento della strage viene appiccato il fuoco ad alcune abitazioni. Quella di Giuseppe Doralice, ritenuto a ragione un capo del movimento di resistenza, è saccheggiata, mentre sua moglie è incarcerata ad Este e da lì inviata in Germania.
Dopo una lunga trattativa si giunge alla liberazione di Pisanò e al rilascio dei venti ostaggi. Oltre alla formazione comunista della brigata Paride, nel territorio ne agisce anche una democristiana, poi battezzata Pierobon, che nella notte fra il 15 e il 16 agosto riceve armi grazie all’aviolancio alleato.
Mentre ad Este la voce degli antifascisti è particolarmente flebile, sul margine più occidentale della Bassa, ai confini con Verona, la lotta si fa più cruenta con perdite da ambo le parti.
Il 3 settembre le brigate nere, nei pressi di San Salvaro, attuano una vasta retata che si conclude con la cattura e la detenzione per alcune ore di decine di persone, compreso il parroco il quale descrive la sua zona indicandola come “teatro tragico di incendi, rapimenti, uccisioni”.
Nel frattempo, gli alleati dal sud risalgono la penisola mentre i tedeschi, sempre più pressati, cercano di arginarne l’avanzata tramite la cosiddetta Linea Gotica. Vedendosi però sempre più minacciati, i nazifascisti aumentano le nefandezze delle loro rappresaglie. Non basta più eliminare i ribelli, bisogna lasciare in esposizione i loro corpi almeno per un paio di giorni affinché siano di ammonimento alla popolazione. Come nel caso di Ottavio Cuccato di Granze, arrestato perché trovato in possesso di un mitra americano. È giustiziato a Casale di Scodosia ed esposto ad un gancio di ferro che, sulla facciata della vicina osteria, sosteneva i fili elettrici: “Guai a chi lo tocca e guai a chi gli farà qualche dichiarazione nella sepoltura”, viene impartito come ordine perentorio.
Sangue e brutalità continuano a Megliadino San Vitale, dove fra il 13 e il 14 ottobre 1944 piombano i tedeschi con l’intenzione di annientare i combattenti della brigata Pierobon. Gli squadristi di Lembcke giungono a Megliadino sequestrando alcuni partigiani, specialmente quelli che nascondevano in casa le armi ottenute con gli aviolanci. La sera del 14, dopo una serie di stringenti interrogatori, Aldo Gennaro, Nello Gioachin, Giocondo Vascon, Mario Rosa, Augusto Bruschetta e Giovanni Cremon sono fucilati a un centinaio di metri dall’osteria, lungo la strada che costeggia il canale Vampadore. Contemporaneamente i tedeschi e i repubblichini appiccano il fuoco alle case dei ribelli in cui sono state trovate le armi, oltre a deportare in Germania le mogli di due di loro.
Anche questa strage mette a dura prova le formazioni partigiane e, considerato che la Linea Gotica resiste agli sforzi degli alleati e non è ancora stata sfondata, c’è chi si chiede se abbia senso oppure no continuare con la lotta armata.
Decisi a proseguire sono i militanti della brigata Paride i quali, anzi, rilanciano con il cosiddetto “piano in stile” che, come racconterà il partigiano Omobono Mozzi, detto Bonin, fu “un’azione combinata di sabotaggio che portò alla distruzione di quattro ponti, con la partecipazione di complessivi 32 uomini. […] Nella stessa notte atto di sabotaggio alla ferrovia Mantova-Monselice in due punti. Risultati ottenuti: interruzione della ferrovia per una settimana; i quattro ponti completamente distrutti; uno ricostruito in settimana, gli altri dopo più di tre mesi. Nessuna perdita da parte nostra”. Un successo dal punto di vista militare, ma le cui conseguenze furono pesantissime per il movimento partigiano del montagnanese: Lembcke, furibondo, minaccia deportazioni in massa e, con il rastrellamento successivo, un centinaio di persone vengono imprigionate presso il castello di Bevilacqua.
La sanguinosa rappresaglia fiacca ancor di più le formazioni partigiane mentre Lembcke si sente sempre più forte e detta le regole: ad esempio, arresta il parroco di Megliadino San Fidenzio con l’accusa di aver mantenuto rapporti con i ribelli e lo rilascia solo dopo aver ricevuto un consistente quantitativo di materiale bellico. A metà novembre la lotta armata è pressoché cessata e bisognerà attendere la primavera del 1945 per rivedere i primi segnali di ripresa, anche perché dal 5 aprile riparte l’offensiva alleata che, in poche settimane, travolge le linee difensive tedesche. Il 21 gli alleati sono a Bologna, il 25 a Rovigo. Tra il 24 e il 25 le truppe tedesche in rotta varcano l’Adige a Boara Pisani e a Masi. È una fuga disordinata che tra il 26 e il 28 aprile investe molti paesi della Bassa Padovana e dei Colli Euganei, una fuga che porta con sé uccisioni, eccidi e stragi: “una truppa schiacciata dalla propria catastrofe, sterminata massa umana che cammina per forza d’inerzia e si batte per spirito di conservazione, nella speranza di raggiungere il confine”.
Nel frattempo la mobilitazione partigiana ha ripreso slancio: il 25 aprile il Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia ha diramato l’ordine di insurrezione generale, cercando di ostacolare in tutti i modi la sanguinosa ritirata tedesca.
Ritirata che il 27 aprile, nella Bassa Padovana, si trasforma nel giorno delle stragi, il giorno del sangue e del fuoco. Il primo e più terribile massacro si consuma poco dopo l’alba a Santa Margherita d’Adige, nella località Taglie, ai confini con il territorio del comune di Ponso: a farne le spese la famiglia Bogoni, sterminata dai nazifascisti presso la propria fattoria. Stessa sorte tocca ai Costantin, poco lontano, e la scia di sangue prosegue fino a Ponso, ma anche a Valle San Giorgio con l’assalto mortale alla casa dei Cerchiaro. L’ultimo eccidio ha luogo nel pomeriggio vicino alla città di Este.
Sul territorio martoriato cala la notte ma finalmente al risveglio, la mattina del 28 aprile, i tedeschi non ci sono più, anzi alle 11 i carri armati alleati arrivano a Montagnana e sfilano tra due ali di folla.
Anche i patrioti che hanno combattuto nella Resistenza possono sfilare festanti. Le case sono imbandierate e le bandiere recano lo stemma sabaudo coperto da pezzi di carta o di tela. La gioia finalmente può invadere le strade e, come scrisse Maria Carazzolo, “la gente non scappa più. Siamo liberi. Siamo di nuovo uomini. Non c’è più da nascondersi, da temere, da sotterrare le bici nei letamai come abbiamo fatto fino a stanotte. Si può circolare, nessuno ci aggredisce, nessuno ci mette le bombe a mano sulle porte delle case. Giriamo per le strade, per le nostre strade, sotto il nostro cielo. Possiamo parlare, possiamo cantare”.
E veramente la gente poteva festeggiare la fine di una dittatura, la fine di una guerra, festeggiare la conquista della libertà. Una liberazione che fra l’estate del 1944 e la primavera del 1945 era costata la perdita di 150 vite fra l’estense e il montagnanese. Ed è per questo e per molti altri sacrifici che, a lotta finita, la gente libera può finalmente gridare insieme ai partigiani: “xe’ vegnua la nostra ora”, come fedelmente riporta sempre Maria Carazzolo nel suo diario: un libro-testimonianza pubblicato nel 2007, a cura di Francesco Selmin, con l’emblematico titolo “Più forte della paura”, che ovviamente vi invito a leggere.
Bibliografia essenziale:
M. CARAZZOLO, Più forte della paura, a cura di F. SELMIN, Sommacampagna, Cierre, 2007.
T. MERLIN, Fascismo e spirito pubblico nel Padovano, in “Terra d’Este”, 11 (1996).
T. MERLIN, Significato e limiti del movimento partigiano nella Bassa padovana, in “Terra e Storia” 19 – 20 (2022).
G. PASQUALIN, Giuseppe Doralice sindaco di Castelbaldo, in “Terra d’Este”, 40 (2010).
F. SELMIN, Ammazzateli tutti, Sommacampagna, Cierre, 2016.
F. SELMIN, La Resistenza tra Adige e Colli Euganei, Sommacampagna, Cierre, 2005.
L. ZERBINATI, Dante Dall’Aglio da perseguitato a sindaco di Masi, in “Terra d’Este”, 40 (2010).