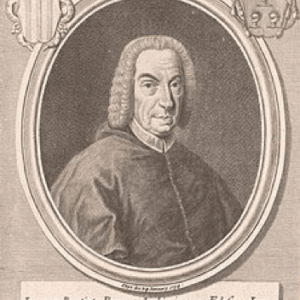La Via delle Valli nel Delta del Po: la bellezza della natura tra civiltà e paesaggio
Da anni frequento Rosapineta e da anni ogni volta passo davanti all’indicazione Via delle Valli, a destra, e sempre mio marito, io e i nipoti, coralmente, ci ripromettiamo di inoltrarci per quella strada, ma non l’abbiamo mai fatto, rimandando ad altre occasioni. Così, all’improvviso, nell’estate 2023 e successivamente quest’anno, presi da un inedito spirito di esploratori ci lanciamo per questa sconosciuta via, già nel nome misteriosa. Col senno di poi avremmo potuto allora visitare su internet il nominativo della località e trovare mille notizie sul Parco del Delta del Po, di cui la mitica via fa parte tuttora. Ma è stato meglio così, perché ci avrebbe tolto la gioia delle scoperte continue offerte dal luogo.
Dapprima la via appare affossata fra il verde senza rivelare immagini di paesaggi laterali. Solo procedendo sembra elevarsi quasi nel cielo, nell’ampiezza di lagune intorno, tra fisionomie di tamerici e di oleandri, stretti in un sipario che si aprirà sulla grande scenografia sottostante, in particolare a destra, mentre a sinistra appare la laguna nella sua immensità sconfinata, forse ricongiunta a Porto Caleri? Finalmente a destra, all’apertura di queste tende vegetali, appaiono ville proprio sulla soglia della laguna, con il loro abituale corredo di oleandri. Qui la natura non ha limiti e, obbediente alla legge del creato, si espande in un altrove che non ci appartiene. Sono curiosi, per noi abitanti della città, i ripari vicino alle abitazioni per le barche durante il riposo notturno, raggiunti attraverso una rete di canali, propri di questa zona. E pure caratteristiche sono le chiuse, come Chiavica Tofana, che regolano armoniosamente il deflusso dell’acqua, con altri nomi che richiamano la Serenissima. Più avanti, dalla parte sinistra, una serie di costruzioni “nascoste”: le case degli attuali pescatori che lì attraccano le imbarcazioni. Il pescato, subito viene raccolto da camioncini frigoriferi con una evidente organizzazione di orari precisi da parte di una comunità che obbedisce sì alle leggi della natura, ma si muove con ordine rifiutando l’apparente anarchia che domina invece la vegetazione. Finalmente, prendiamo visione della realtà di questo paesaggio che affascina e ti cattura: basta pensare alle rondini che ti volano quasi tra le mani, mentre si preparano le casse di “peoci” che vengono prelevate dai citati camioncini per essere immesse nel mercato. Annotiamo il tutto con precisione forse eccessiva, per comprendere però meglio la dimensione, la valenza di questa mitica via in cui pulsa nel silenzio e nel mistero una intensa vita offrendo continui stupori. Ci attirano cancelli aperti sull’infinito invalicabili, tutela di centri faunistici e venatori, che rimangono solo un desiderio di un oltre che non ci appartiene: possiamo solo seguire la lunga strada sterrata che lambisce la laguna e immaginare in fondo una villa, un oratorio.
In direzione Porto Levante attraverso paesaggi magici delle valli Veniera, Sagreda, Morosina e Moceniga appare brillante nel verde un oratorio per la messa dell’Assunta lì annunciata nella bacheca ai vallanti e ai forestieri. Luogo di preghiera, espressione artistica del Settecento, ad opera dei Mocenigo, nobili veneziani, che acquistata là una vasta zona, la resero una valle per attività di caccia e pesca. Segno del potere economico-sociale di Venezia, che via mare, fiumi e canali, arrivava ovunque lasciando tracce della sua presenza. Curioso è che, tra dicerie raccolte, la chiesetta sia stata una delle locations del film Il testimone dello sposo di Pupi Avati e che pure il grande Zucchero Fornaciari del casone di valle Veniera abbia fatto sfondo ad uno dei suoi videoclip.
Ma tornando al nostro oratorio scopriamo che altri cinque a noi non noti sorgono nella zona, sempre come presenza dogale. Quello che fa pensare è che questa venezianità sia ancora identificabile in molti altri luoghi. Si respira in particolare a Loreo, circondato da un corso d’acqua, con calli, piazzette, colori delle case ed opere del Longhena, rievocanti atmosfere raffinate di Venezia. Loreo, gemma del Polesine, ha goduto di notevoli poteri giurisdizionali, estesi sino a Rosolina e altri luoghi attigui. Volendo, in questa pausa di riflessione storica, si può ricordare anche Badia Polesine con la sua piccola Fenice intatta nel suo restauro e pure Cà Tiepolo ad Albarella, altri fari di venezianità.
Tanta bellezza fa pensare che civiltà e paesaggio, quando s’incontrano armoniosamente, segnando l’orma della storia, accendano lo splendore dell’umano procedere. Tutto questo non dà gravezza alla meraviglia, alla serenità provate contemplando la pace che infonde la laguna, così pudica in ogni sua espressione di vita. Silenziosamente pulsa negli “orti”, nei campi lagunari coltivati a molluschi, nelle barene piene di uccelli celati in nidi segreti o bianche gazzette quasi richiami in mezzo al verde, in attesa di uccelli di passo e di tribù di rosati fenicotteri. Ed ancora si prova tenerezza alle distese dei fiori di limonio, simbolo d’innocenza e di ricordi dell’infanzia. Questo è solo un invito a conoscere di più questo mondo misterioso, aperto in pagine di stupori naturali e di storiche presenze, per inoltrarsi nel Parco del Delta del Po e riconoscere i rapporti di Venezia con il territorio. Chiudo queste segnalazioni turistiche seduta sulla panchina di ferro di un osservatorio, lungo via delle Valli, della vita della laguna nelle sue acque e nei suoi cieli. Annoto il passaggio di tribù di ciclisti, godendo di questa sensazione di spazi infiniti e di minuti alati in volo fra il verde dei rami.