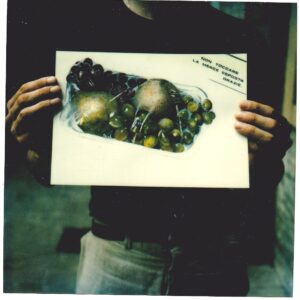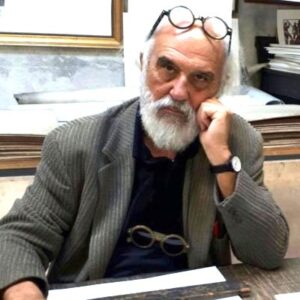Sebastiano Schiavon e le Settimane sociali a Praglia: un laboratorio di politica
Un’autentica scuola di formazione dalla quale emergeranno diverse personalità protagoniste del proprio tempo
Nel 1967 l’Associazione Stampa Padovana, in collaborazione con la Libreria Draghi-Randi, pubblica un libro sul giornalismo a Padova dal 1866 al 1915 con la prefazione di Diego Valeri che, tra l’altro, scrive:
“… eccomi qua a dichiarare agli amici autori che la lettura del loro libro mi ha fatto rivivere qualche ora della mia così lontana giovinezza (della mia vecchia giovinezza) risuscitando nella mia mente nomi e fatti dimenticati, evocando immagini di persone da lungo tempo perdute e confuse nella grande ombra. Così ho visto riapparire sulla avanscena di questo piccolo teatro storico un Francesco Sandoni, un Attilio Borgatti; e il dottor Cesare Sartori, e l’on. Schiavon, detto “el strapazzasiori” restando sullo sfondo, in atteggiamento meditativo, i due filosofi avversari, l’Ardigò e il Bonatelli: avversi, eppur così simili in aspetto, nel candore delle loro immense barbe bianche. Su ciascuno di questi personaggi avrei qualcosa da dire, ma non hic locus”.
Diego Valeri afferma dunque che non è il momento per parlare di Sebastiano Schiavon “el strapazzasiori”. Però, avendo l’occasione di consultare all’Abbazia di Praglia la “Cronaca della Badia di Praglia dall’anno della ristorazione 1904-1925”, trovo che si parla molto di Sebastiano Schiavon, popolare a Padova e provincia, come sindacalista, deputato e organizzatore delle leghe bianche. Uno degli uomini di punta, dal 1908 al 1922 – con don Restituto Cecconelli, Giuseppe Dalla Torre, Rinaldo Pietrogrande, Cesare Crescente, Gavino Sabadin – di quel gruppo di giovani democratico-cristiani che affianca il vescovo Luigi Pellizzo nella costruzione del movimento politico e sociale diocesano.
Pellizzo, a differenza del predecessore Cardinale Giuseppe Callegari, dal 1907, anno del suo insediamento a Padova, incrementa i rapporti con l’Abbazia di Praglia non solo con incontri personali, ma anche evidentemente sollecitando i suoi più stretti collaboratori a continue frequentazioni con i monaci benedettini.
Nel 1911 don Restituto Cecconelli, giovane segretario del Vescovo, presidente della Direzione Diocesana e braccio operativo del movimento politico-sindacale organizzato a Padova, è costretto a dimettersi perché troppo esposto nel Congresso Cattolico di Modena contro gli indirizzi della Santa Sede e si ritira, non a caso, nel Monastero di Praglia, dedicandosi allo studio per prepararsi alla laurea. Scorrendo ancora la cronaca si legge di Cecconelli, il 19 maggio 1916, in relazione alla sua tragica scomparsa.
Anche il conte Giuseppe Dalla Torre, successore nel 1911 di don Cecconelli, frequenterà abitualmente l’Abbazia di Praglia tanto da diventarne oblato.
Sono questi gli anni in cui, dopo il forte impegno sindacale e politico del biennio 1908-1910, la formazione del movimento cattolico mira ad essere religiosa oltre che sociale e politica, nella speranza di costruire cattolici militanti che operino nella società sotto la guida della gerarchia diocesana. Vengono allora costituite dalla Diocesi a Praglia, dal 1913, le cosiddette “Settimane sociali”, cioè raduni di giovani cattolici per la formazione di dirigenti a livello locale. Tale esperienza si ripete sempre nell’Abbazia nel 1914 e gli oratori sono don Emanuele Caronti, don Giovanni Alessi, il professor Giovanni Battista Soffiantini di Rovigo e l’onorevole Sebastiano Schiavon. Il 19 marzo dello stesso anno, festa di San Giuseppe, il cronista padre Eusebio Camilli scrive che… in chiesa l’orario è come nei giorni festivi e poco prima di mezzogiorno Sebastiano Schiavon, deputato di Cittadella, ha fatto visita ai giovani accompagnato dall’avv. Italo Rosa…, altro dirigente cattolico padovano impegnato sul fronte sindacale (a proposito di Schiavon e Rosa, è da notare che già nel 1911 svolgevano attività di studio e aggiornamento sociale anche nella Diocesi di Belluno, come risulta da un articolo dello stesso Schiavon sulla “Settimana sociale” di Firenze e anche da documenti del Fondo “Circolo Contardo Ferrini” di Belluno).
Il giorno successivo anche il vescovo Pellizzo visita i giovani diocesani che frequentano la “Settimana sociale”. Il 22 marzo è sempre il cronista benedettino che scrive: … si chiude la Settimana sociale e nel chiostro pensile dell’Abbazia si è fatta la premiazione delle bandiere dei circoli giovanili che più hanno lavorato: erano più di venti le bandiere, ma di queste solo nove sono premiate. Il rev. Padre Abate Nicolini ha distribuito ed attaccato su ciascuna le medaglie. Distinti gli oratori, tra i quali l’on. Sebastiano Schiavon, hanno pronunziato discorsi, ed ultimo di tutti il nostro reverendissimo Abate. La banda musicale di Selvazzano ha dato maggior allegria alla festa per se stessa gioviale per tanta gioventù.
Il 3 aprile 1915 il cronista padre Teofilo Caronti scrive che alla sera giunge da Padova l’onorevole Schiavon appositamente per augurare le buone feste pasquali alla comunità. In agosto il cronista annota: Il nostro governo ha diretto alle regie rappresentanze all’estero un telegramma circolare nel quale espone tutte le vertenze fra l’Italia e la Turchia, sorte dopo il trattato di Losanna del 18 ottobre 1912. Al monastero niente di nuovo; alla sera è venuto a visitare noi monaci il deputato Schiavon. Da queste ripetute visite in Abbazia e dalle successive si può capire che il giovane dirigente cattolico fosse personalmente legato all’Abate Nicolini.
Il cronista padre Giuseppe Caronti, l’11 gennaio 1917, riferisce: Il reverendo padre Abate Nicolini, avendo graziosamente ricevuto in dono dall’onorevole deputato Schiavon un biglietto andata e ritorno di prima classe delle FFSS, ne approfitta per recarsi a Roma e Subbiaco alfine di conferire col rev.mo padre Abate Generale vari importantissimi affari che riguardano la comunità di Praglia: passando per Genova ossequierà il padre Abate Visitatore ed infine si recherà a Torino a riabbracciare suo fratello, già soldato austriaco, prigioniero dei suoi e da questi inviato in Italia. Buona riuscita! Ottimo viaggio e felice ritorno.
Sebastiano Schiavon viene citato anche nella cronaca del 26 aprile 1917. Giovedì: dedica della nostra chiesa. Alle ore 9 Messa solenne e alla sera Vespri cantati. Nelle ore pomeridiane viene a farci visita l’on. Sebastiano Schiavon deputato al parlamento, ma si ferma poco tempo, tanto più che il reverendo Abate è assente.
Purtroppo, come visto, la consultazione di questa fonte dà la possibilità solo di conoscere che tra Schiavon e l’abate Nicolini c’era un forte legame, ma non consente di penetrarlo in profondità, chiarendone ragioni e contenuti.
L’ultima segnalazione su Schiavon si trova il 26 ottobre 1919, in cui si scrive: … L’onorevole Schiavon proposto deputato nelle liste del PPI (Partito Popolare Italiano) tiene una conferenza nella sala del Fuoco comune a scopo elettorale… in preparazione delle elezioni del 16 novembre 1919 data in cui “quasi tutti i padri si recano nelle scuole comunali di S. Biagio a dare il loro voto per le elezioni politiche a cui quest’anno si dà la massima importanza, onde far trionfare il testè sorto Partito Popolare basato sui principi cristiani e cattolici
Da queste poche parole del cronista dell’Abbazia si capisce che il 1919, anno di fondazione del PPI, è un anno pieno di effervescenze e anche i padri benedettini sono impegnati a dare il loro contributo a quei candidati che siano più vicini al loro sentire.
Nel nuovo partito infatti si riscontrano diverse correnti già all’atto delle sua fondazione: un centro sturziano, geloso dell’autonomia dei cattolici, ma aperto verso una politica di riforme, con Filippo Meda e Giuseppe Micheli accanto a uomini nuovi, quali Antonio Boggiano Pico, Giovanni Bertini, Mario Augusto Martini, Umberto Tupini, Mario Cingolati; una destra filo-clericale e nazionalista, riconoscibile in Filippo Crispoldi, Stefano Cavazzoni, Cesare Nava, Egilberto Martire, Livio Tovini, Giulio Paduli; infine una sinistra attiva sul piano sindacale e non aliena dall’assumere posizioni estremiste in concorrenza con i socialisti, dove accanto alla nota e per certi versi eccentrica figura di Guido Miglioli si trovano uomini quali Angelo Mauri, Italico Corradino Cappellotto, Sebastiano Schiavon, Giovanni Gronchi.
Dopo la cronaca benedettina sulle elezioni politiche cessa ogni riferimento al partito di don Sturzo e a Schiavon che, con l’apertura delle sezioni a Padova e provincia, ha contribuito a farlo nascere e svilupparsi.