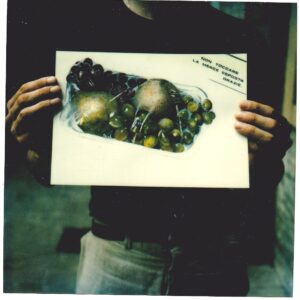L'”autobiografia poetica” di Antonio Daniele
La profonda umanità e cultura di un amico autentico e indimenticabile

Alla scomparsa improvvisa e inattesa di Antonio Daniele, nel maggio 2023, annunciata dall’Accademia Galileiana di cui era presidente, molte pagine di vita subito riemersero, facendosi ricordo e narrazione. Un modo per tener vivo e onorare chi non c’è più, un amico nella poesia e nella vita, partecipe al Cenacolo di poesia di Praglia “Insieme nell’Umano e nel Divino”. Ricordo la sua attenzione ad ogni mio libro: una cartolina di Udine, un biglietto, mi dicevano sempre il suo gradimento per le mie diverse scritture.
Fu, tra le molte altre cose, autore di Lucamara, bella silloge (Cleup, 2016) recensita dalla sottoscritta sul numero 124 (quarto trimestre 2016) della rivista La Nuova Tribuna Letteraria:

“A dire il vero alle prime pagine della composita raccolta (Lucamara, Ferume e Rugoleto), pur in parte a me già note, mi sono sentita aggredire dall’uso del pavano, dialetto revoluto del proprio contado (scritto come se lo avessero scritto i miei, se fossero andati a scuola), un po’ duro all’inizio da masticare. Poi lentamente più morbido al palato, al cuore, capace di catturarti perché ha la vita dentro di quella campagna da me amata e vissuta, durante i soggiorni nella casa dei miei nonni paterni, con i suoi ritmi, con la fatica della gente, con la pazienza e la saggezza della terra, intrisa di proverbi dei vecchi, di tradizioni, filastrocche, giochi dell’infanzia. Terra tradita da ‘na man de ciordi che hanno disorientato, in nome di un arrogante progresso, con le strutture della zona industriale, l’uomo nel suo lavoro, nel paesaggio agreste, nella memoria individuale e collettiva. Sensazione che ho provato anch’io quando, rivedendo i luoghi, non ho più riconosciuto la casa dei miei nonni, lo spazio-tempo della mia infanzia. Però questa poesia, con la sua funzione quasi di bussola, mi ridisegna i punti cardinali per ritrovarmi, rievocando un mondo pregno di sapori, odori, suoni campestri, profumo di fiori e foglie, di primavera spanìa, voci di animali alati e terrestri, di feste paesane, ancora in me vive: il tutto diviene memoria affidata al verso, alla parola perfettamente aderente all’immagine creata. Questo paesaggio arcaico fa da sfondo a tutta la raccolta e ne è elemento unificatore con la sua staticità atemporale, ma anche con la dinamica della natura garante di pulsioni stagionali, scansioni perenni, riferimenti nel procedere umano, nello scorrere del tempo, motivi conduttori della raccolta. Un paesaggio quindi con i suoi slanci vitali che percorrono pure i febbrili amori giovani dell’autore, sicché fra le vigne, le siepi, i campi, le barchesse e l’adolescenza-giovinezza del poeta c’è un intimo legame tradotto nella sua verità in gesti-parole-riti amorosi che, allo smalto del ricordo, s’illuminano di quella luce dolce-amara, la nostalgia per il bene più grande della vita, la giovinezza ormai fuggita via: altro tema ricorrente che ancor più turba l’anima stessa dell’autore in note continue di rimpianto per l’amore ormai perduto in quel tempo passato per sempre di cui rimane solo un quadrifoglio tra le pagine di un libro aperto. Sì perché la raccolta (un diario, un libro di meditazioni) è in fondo un ragguaglio sull’esistenza, realizzato appunto attraverso ricordi, malinconie, rimorsi, rimpianti, revisioni, in un voler tornare indietro. È un colloquio ben riuscito dell’autore con se stesso, ora triste, ora ironico nel guardare la vita e la propria frenesia d’amore , che rivela in fondo la sua filosofia esistenziale, e anche la nostra: un inquieto chiedersi il senso delle cose, un guardarsi a ritroso fra un intrico di se e ma, un lamentarsi/tormentarsi, dilaniati dal carólo dell’amore ed altro, che mastega dì e note dentro, con la coscienza sempre che manca una fregola per essere felici, nella realistica visione della fine tra quatro tòle. Ma risuona anche forte l’affermazione di una regola portante: l’accettazione della vita stessa che può vincere, pur con le sue difficoltà, su tutte le pene. Lo spazio tempo si allarga ad altri luoghi (Vienna, Parigi, Udine…), ad altre esperienze vissute con la zia Ina, a persone care scomparse come Mario Rigoni Stern che sta morendo sol nostro Altipian, come Fernando Bandini ricordato in canti di usignoli, voli di colombe…, questo sempre con un sottofondo di malinconia per i beni perduti, non assaporati con la coscienza del momento vissuto. La poesia si allarga in preziosi intarsi di poeti italiani e stranieri del passato in una condivisione valoriale, in particolare con il Petrarca, poesia resa sempre più pura nel bel dialetto autentico, colto, capace di suggerire atmosfere suggestive ed emozioni, in particolare legate all’infanzia (da bocia ghevo coato in granaro/ dove nessun me saveva catare) e alla natura (varda se oncora/ me incanta/ la cipria d’oro/ de on petabrose). Il tutto coniugato in una variazione metrica davvero sorprendente. Bravo l’autore per questo suo Lucamara, nostra radice bambina, dal sapore dolce-amaro, fra tritumi del fieno lasciato dopo la mietitura, col ricordo del pasquale rugoleto, memoria scomparsa di un mondo più povero ma forse più felice, testimonianza da trattenere ancora. Quindi, come dice Paccagnella, un canzoniere d’amore ma anche un canto alla natura, alla vita nelle sue note più profonde di gioia e dolore. Uno scrigno ruvido in dialetto pavano, contenitore avvolgente del vissuto umano e culturale di Antonio Daniele. E Zanzotto affermerebbe che solo nella lingua succhiata dalla madre-terra si può esprimere la vita nella sua innocenza e verità. Va ricordato anche il suo lavoro di studioso apprezzatissimo, ordinario di Letteratura italiana e filologia in varie università, Vienna, Padova, Cosenza e per ultima Udine, infine presidente amato dell’Accademia Galileiana. Rimane viva in questo ricordo la sua figura di uomo disponibile, ironico, divertente, impegnatissimo in ogni tipo di lavoro con grande amore per la poesia. Tra i tanti, la già citata raccolta Lucamara e saggi su autori anche dialettali veneti”.
Nel 2014, Antonio presentò a Praglia, a nostra richiesta, la sua “autobiografia poetica”, che l’abate Norberto definì “narrazione biografica, culturale, poetica e spirituale di un testimone del nostro tempo che ci ha guidati lungo il fiume della sua vita”: la riproponiamo qui.
Autobiografia poetica di Antonio Daniele
Ho cominciato a scrivere poesie, come fanno tutti i ragazzini, in prima media, cercando disperatamente la rima come elemento imprescindibile di ogni vera manifestazione poetica.
Scrivere poesie in età adolescenziale è normale, direi fisologico; diventa problematico quando il fenomeno continua in età adulta e può assumere i tratti di una patologia anche grave, perché può essere legato a un mancato sviluppo nella crescita, a una distorta visione del mondo, nel più benevolo dei casi a una forma espansa, prolungata di narcisismo. Questo lo so, ed è per questa ragione che ho sempre cercato di castigare in me l’insorgenza del bisogno di poesia, considerandola come una devianza: innocente, innocua, ma pur sempre da tenere sotto controllo, come una pressione arteriosa fuori squadra, una puntina di diabete, un lieve soffio al cuore…
Dico queste cose per mettere subito la faccenda in chiaro. Scrivo poesie, è vero, ma sono ben lontano dal considerarmi un poeta realizzato, anche per la semplice ragione che (dato il mestiere che faccio) sono un critico del fatto poetico e, ironia della sorte, ora insegno addirittura all’università Stilistica e metrica italiana: contrappasso questo che è toccato in sorte, mentre era in vita, anche al mio collega e amico Fernando Bandini, poeta vero e di ben altra rilevanza.
Parlo dunque per cognizione di causa, conosco abbastanza il valore delle cose. Se ora parlo di me, è per l’insistenza degli amici e di chi mi ha invitato a questo piccolo ma fervoroso cenacolo di amanti della poesia. Così tratterò di me, se volete, come soggetto di studio, come campione sociologico, fingendo di credere a tutte le mie potenzialità, latenti od espresse.
Ho cominciato, dunque, a scrivere partendo da poesie di carattere intimistico, cercando di imitare le strutture formali che erano a mia conoscenza, imitando Pascoli e D’Annunzio, autori da me letti in una antologia scolastica di mia sorella che aveva fatto le magistrali. Molti libri non c’erano in casa; i miei erano metà operai e metà contadini: ci si doveva arrangiare con quello che si trovava. Per fortuna in fondo ad una grammatica italiana sempre di mia sorella avevo trovato anche un piccolo trattatello di metrica. Fu una rivelazione, perché, anche sapendo che la lirica moderna poteva essere libera e sganciata da ogni regola costrittiva, mi accorsi subito che, seguendo le regole della prosodia tradizionale, i versi ‘suonavano’ meglio; pagato lo scotto della rima il senso si faceva più impegnativo ma anche più chiaro e scorrevole, implicava una impresa di assoggettamento alla misura dell’endecasillabo, alla necessità parallelistica di far cadere gli accenti tonici nei posti consaputi, imponeva un’attenzione non superficiale agli effetti ritmici ritornanti…
Conservo ancora questi piccoli brandelli di poesia infantile, battuti a macchina su carta velina da un mio amichetto coetaneo, primo estimatore di quelle mie povere prove. Inutile dire che a quell’età (ma anche in seguito) è assai importante il conforto di un qualche interlocutore. La poesia non è merce rara, ma neppure si vende o contrabbanda facilmente; ha bisogno di uditori pazienti e consenzienti per trovare il suo minimo appagamento, una ragione di esistenza. Si può dire senz’altro che abbia spesso un valore di scambio, di complicità, di intesa semisegreta.
Spesso chi scrive poesie è fornito di una sensibilità raddoppiata, ha un animo più mite ed esposto, ed è anche più fragile di fronte ai soprusi del mondo; ed è perciò che uscire dalla fase ‘poetica’ corrisponde spesso al diventare più robusti e responsabili, più capaci di affrontare la vita realisticamente e non da sognatori. Era in questo senso che parlavo all’inizio della poesia come fosse una delle tante malattie infantili, dalle quali si guarisce, anche se sempre si resta segnati.
Solo chi non guarisce resta un problema per sé e per gli altri. Lo dico scherzosamente, ma neppure tanto.
A scuola, a parte le elementari, non sono mai stato uno studente esemplare. Ma in seconda media incontrai un professore di lettere che mi prese a benvolere; in particolare si accorse (e non era poco per quei tempi e per quella scuola) che avevo qualche inclinazione per la scrittura. Devo a lui se non mi sono perso nei meandri di una scuola di classe, che sembrava proprio disegnata sui modelli negativi che pochi anni dopo don Milani individuerà nella sua travolgente Lettera a una professoressa. Fu a lui che in uno slancio di confidenza feci vedere le mie prove di traduzione in endecasillabi sciolti del IV canto dell’Eneide (il canto di Didone), spinto da non so più quali esempî di traduzioni moderne di classici antichi (forse Pascoli e Quasimodo), lette nella biblioteca di paese che nel frattempo era stata installata dal Circolo didattico provinciale nella mia vecchia scuola elementare di Camin a edificazione e beneficio di chi, non per sua colpa, aveva dovuto interrompere le scuole. Il professor Marchetti, mio sostenitore e benefattore, divenuto poi preside di scuola media, fu quello che mi dette da fare le mie prime supplenze scolastiche, ancor prima di aver ottenuto la
laurea; con lui rimanemmo, fin che visse, sempre in contatto e sempre amici.
Fu nell’estate dei quindici anni che cominciai a raccogliere con metodo in un quaderno apposito le mie poesie, con l’intenzione di raccoglierle in una sorta di canzoniere generale che ancora conservo. Complice un amoretto poco più che infantile, mi ritrovai a scrivere dei versi lunghi e distesi appassionati, alla maniera un po’ di Foglie d’erba di Whitman e delle Terra desolata di Eliot.
Inutile dire che si tratta di imitazioni distanti le mille miglia dai modelli di riferimento, ma io sentivo che per me si trattava di una nuova ripartenza, che qualcosa era cambiato nella qualità del mio scrivere. Mi pareva di aver raggiunto una superiore autocoscienza, di poter guardare la mia materia con una superiore consapevolezza e determinazione. Fu anche in quella circostanza che cominciai a tenere un diario giornaliero, abitudine che pur con qualche breve interruzione continuo tuttora, con qualche vergogna data la mia più che incipiente calvizie e canizie.
Solo con l’università ho avuto coscienza piena dei miei limiti (e, inversamente, delle mie possibilità). Iscritto a Padova alla Facoltà di Lettere, ebbi la fortuna di incontrare dei maestri di prim’ordine (Folena, Branca, Sambin e tanti altri). Ebbi subito piena coscienza che se volevo guadagnarmi il pane con la letteratura dovevo convertirmi alla filologia, alla linguistica, alla critica seria. Era controproducente inseguire farfalle poetiche nel bosco, con il pericolo di incappare presto nell’insidia di un qualche burrone. Importante era acquisire un’abilità, un metodo, fondare su basi conoscitive solide una passione per la letteratura, in modo da poter accedere alla scuola, all’insegnamento. Sapevo con certezza che l’arte, la poesia sono anche genio e sregolatezza, passione e disperazione, esaltazione e malattia; ma io coltivavo, e coltivo, un’aspirazione pacifica dell’esistenza, tendenzialmente borghese e di poche pretese, ben sapendo che la vita di ognuno si incarica di distribuire mazzate a non finire, spesso imprevedibili, senza che si vada a cercare noi di perturbarla e viziarla, di renderla maledetta. Euforico e disforico per complessione ed indole, procedo per alti e bassi d’umore; l’ottimismo non è il mio forte, ma sinora ho fatto forza a me stesso tramite un’azione repressiva e propulsiva della volontà, che mi auguro duri più a lungo possibile, vincendo la parte malinconica del mio carattere.
Ho cominciato a scrivere poesie in dialetto pavano, partecipando ad un concorso dell’Università popolare di Padova. Avevo ventun anni. Presentai allora tre sonetti, di stampo tradizionale, badando a mettere in fila i quattordici versi dei componimenti in maniera meno sgangherata possibile, giocando ancora una volta la carta della poesia erotica, che mi era la più congeniale allora (e temo anche adesso). Vinsi la targa giovanile. Solo molto più tardi mi resi conto che quel piccolo concorso era molto serio. La giuria era presieduta da Manlio Dazzi, e tra i componenti c’erano anche Anita Pittoni, Sandro Zanotto, Paolo Venchieredo e Giulio Alessi; ma soprattutto il primo premio fu bene assegnato, essendo andato al poeta istriano Ligio Zanini (scomparso da alcuni anni), che da allora ho imparato a conoscere e apprezzare (i suoi libri sono poi stati pubblicati da Scheiwiller).
Quel concorso poetico fu l’unico che vinsi ed anche l’unico a cui partecipai, consentendomi di ottenere un prestigio paesano, di cui ora mi posso vantare di fronte a voi. Una nostra vicina di casa (si chiamava Teresa, ed era madre di famiglia), avendo sentito alla radio (verso mezzogiorno e mezzo, mentre stava facendo la polenta) la notizia che ero stato segnalato per un premio di poesia, abbandonò il desco domestico, il paiolo sul fuoco, inforcò la bicicletta e ci venne ad avvertire di quel mio piccolo trionfo del tutto inaspettato. Così funzionavano allora le buone relazioni nelle campagne.
Ma intanto la scuola, non severa ma certo rigorosa, di Folena all’università mi aveva completamente preso. Imparavo a distinguere le sottigliezze della linguistica e della filologia, cominciavo a poco a poco ad entrare nel laboratorio dei grandi poeti, a riconoscere gli espedienti, i trucchi ed anche le geniali invenzioni della grande arte. Questo se da una parte mi apriva gli occhi nei confronti della vera poesia, anche mi inibiva non poco nel cercare una via propria, autonoma per essere io stesso creatore, ponendomi miseramente a confronto con i più grandi campioni della nostra tradizione letteraria. La mia tesi di laurea (di impianto tutto linguistico e stilistico) ebbe come argomento specifico uno dei massimi lirici della nostra tradizione, Torquato Tasso, il punto di sutura tra i nostri massimi vertici lirici, Petrarca e Leopardi. Questo mi permise anche di indagare a fondo la razionalità che presiede alla costruzione lirica, di anatomizzare i formidabili madrigali tassiani che sono il non plus ultra della distillazione sonora ottenuto nella nostra lingua e sono anche il preludio del melodramma, che ha contrassegnato una delle più grandiose invenzioni del nostro genio nazionale: l’opera lirica.
E contemporaneamente, frequentando il Circolo di Folena, ebbi modo di venire in contatto con i migliori critici di ascendenza universitaria, non solo italiani ma anche europei (filologi, letterati e
linguisti delle diverse scuole: da Contini a Segre, da Jakobson a Martinet…), nonché con poeti e scrittori, italiani e stranieri. Ne ricorderò solo alcuni, un po’alla rinfusa: Rafael Alberti, Vittorio Sereni, Mario Luzi, Andrea Zanzotto. Ma ce ne furono tanti e tanti altri.
La presenza di questi uomini singolari, più che di stimolo, valse come inibizione. Continuai a scrivere le mie cose, ma tenendole ben chiuse nel cassetto, ben sapendo di non voler (e poter) competere con questi giganti. Ma tuttavia, nel segreto delle mie notti giovanili e dei miei ritagli di tempo, ho continuato – come pomposamente si dice – a tentare la musa, pur sempre con discrezione, di tempo in tempo e per intervalla insaniae, scrivendo in italiano e nel mio dialetto nativo, del contado padovano, non quello propriamente odierno, edulcorato e civilizzato, ma quello imparato in casa dai miei (e quindi un poco retrodatato, da far risalire direi ai primi del Novecento). Ben presto mi sono accorto che scrivendo in italiano ero come guidato (meglio ingessato) da una tradizione aulica novecentesca che mi teneva imbrigliato entro degli schemi fissi: gli stereotipi linguistici e concettuali che passavano per il nostro ermetismo e le sue più varie continuazioni. Solo scrivendo in dialetto, nel mio dialetto, avevo un mio spazio esiguo di originalità. Lo sperimentalismo, in qualche misura vietato dal mezzo espressivo utilizzato, mi indirizzava verso una determinazione originaria, se non originale, del tutto priva di quelle situazioni circostanziali, di quei giri frastici e nodi sintattici, che erano avviati a diventare maniera. Mi accorgevo che certe cose potevo dirle solo io in quanto locutore di una lingua che attualmente non aveva figure soverchianti che l’avessero in uso scritto come me. E se anche mi allontanavo dalla modernità più attuale, la mia lingua retrograda e un tantino arcaizzante poteva compensare per interesse quel tanto di tematicamente scontato e quasi angustamente provinciale che inevitabilmente i dialetti veicolano. Insomma cercavo di compensare magari con qualche reperto lessicale, qualche locuzione caduta in desuetudine il tritume concettuale che di solito e quasi per forza si lega all’espressione dialettale, quando non si voglia staccarla violentemente dal suo ambito conservativo, dalla sua inevitabile poetica degli affetti e degli strumenti più elementari. Ero convinto di non poter fare nulla di rivoluzionario, ma pure cercavo di intaccare dall’interno la materia, immettendo almeno qualcosa non dirò di moderno, ma di atemporale (non eterno, ma stabile e sempre valido).
Quello che vi ho raccontato sinora non è altro che la premessa alla mia “poetica” (permettetemi di chiamarla così ancora per un momento, pomposamente): premessa che ha avuto qualche sviluppo nei miei studî indirizzati sulla poesia moderna dialettale, anche se in verità le mie propensioni di ricercatore sono sempre andate soprattutto nella direzione dei grandi scrittori del passato, come avrete già capito (Petrarca, Folengo, Ruzzante, Tasso…). Ma la curiosità per i moderni mi ha sempre accompagnato e ora posso dirvi di aver di tempo in tempo scritto dei saggi su Biagio Marin, su Virgilio Giotti, su Giacomo Noventa, su Andrea Zanzotto, su Luigi Meneghello, su Fernando Bandini e altri: poeti che rappresentano – posso dirlo senza tema di smentita – il fior fiore della poesia veneta del nostro Novecento. Di Romano Pascutto, poeta nel dialetto di san Stino di Livenza, ho avuto la ventura di pubblicare anche le edizioni critiche dei suoi volumi di liriche (editia Venezia da Marsilio).
Accompagnato da questi autori, con alcuni dei quali sono entrato anche in contatto e in amicizia, ho accarezzato anch’io un pochettino le guance della musa, ma con un’esatta coscienza dei miei limiti che mi ha trattenuto dall’esibirmi apertamente, se non nella cerchia protettiva degli amici, di quelli cioè che, magari soffiando e sopportandomi, potevano perdonare i miei ghiribizzi mentali.
Mi sono fatto, dunque, anch’io tentare dalla poesia in varî momenti della mia vita, nell’intensità delle emozioni, nell’infittirsi del dolore, nella perdizione della fantasticheria… Ma, confesso, l’ho sempre fatto con un senso di colpa, come se rubassi il mio tempo ad opere più utili, allo studio severo, alle cure familiari… Confesso: ho vissuto sempre questa mia inclinazione, pur inoffensiva, come un peccato originale. È per questa ragione che di solito scrivo poesie nei ritagli di tempo, negli interminabili cotidiani viaggi in treno, nei momenti di pausa delle passeggiate, nel fondo delle ore notturne, quando non sarebbe possibile fare positivamente altro, cercando di non sprecare il tempo contato che ci è avaramente concesso.
A conclusione, e con tenerezza, voglio riportare qui le due poesie in dialetto inserite in Macedonia, raccolta di filastrocche e poesie varie durante il lockdown per offrire ai bambini figli di amici, agli scolari di insegnanti conosciute, momenti di evasione dalla pesantezza virale.
Te me parevi
Te me parevi spaurìa,
proprio ’na cinciarela
che in primavera sponta
tra ’l fior de la brombara.
Chi podeva mai dire
quante mossete te sarìa
vegnù da fare dopo
tacà de caminare?
’Pena cascà dal gnaro
te ghe catà la strada:
’desso te marci cofà ’na anareta
che tra’ la coa in fora.
Te sì ’na bestiolina
che ride, core e salta
e zorno dopo zorno
sempre pì la me incanta.
Mi me roverso
Mi me roverso a vardarte nel sono
quando on respiro te alsa el petesin:
nialtri do, quanta vita ne distaca
e quanto amore zà ne ponze e liga.
Eco cossa vol dire essar to nono:
on penar in tema pa’ on coresin,
’na freda angossa de essarghe doman
pa’ chei oceti che cussì me striga.
È solo un piccolo segno d’affetto, il mio, di fronte al tanto che Antonio ha costruito nella sua vita.

Antonio Daniele, al centro, con Maria Luisa Daniele Toffanin e Massimo Toffanin